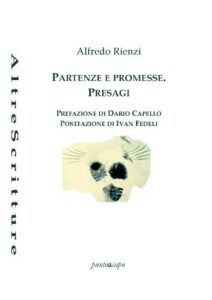
Partenze e promesse. Presagi, Alfredo Rienzi (puntoacapo Editrice, 2019)
La scrittura biblica si nutre di passaggi, lunghi cammini e profezie. La sua forza di attrazione risiede nella binarietà della sua lingua, insieme splendida e oscura, specchio del dio sfuggente che l’ha ispirata. A questo modello elevato si riferisce l’ultima, pluripremiata, opera poetica di Alfredo Rienzi, Partenze e promesse. Presagi. È una raccolta suddivisa in sezioni evolutive progettualmente necessarie in cui alchemicamente si riesce a tenere unite luce e oscurità, a separarne gli elementi costitutivi, a far precipitare quanto di splendente ci sia nel buio e quanta traccia di nero ci sia nell’ascesa zenitale. I versi di Rienzi si macerano in un percorso tortuoso e accidentato – dove la partenza è già per sua definizione ‘seconda’-, cosparso tanto di vestigia primitive, quanto di tracce ineliminabili del contemporaneo e del suo impossibile smaltimento:” quando scende non acqua ma metallo/e l’inodore dell’uranio”. (IL PRESAGIO, p.61, vv.8-9)
La sapienza che se ne deduce è incerta e non astratta, profonda nel senso di viscerale. È una fame inappagabile che vorrebbe farsi una ragione del languore e del tormento fisico del genere umano: “sembra che nell’addome s’occulti la sapienza” (IL PRESAGIO, p.63, v.9). La profezia è alla continua ricerca dell’incarnazione, nella consapevolezza di una fragile unicità valida per “ottomila milioni di antropoidi” (Ottomila milioni di attese (Daniele 9:24), p. 68, v.10), evoluti sino all’essere infantilmente certi “che il tempo è il nostro gioco prediletto/e durerà poco, come i giochi belli.” (VIII, Come i giochi belli, p.92, vv.11-12)
Questi due versi, tra i più semplici della raccolta, sono posti al termine della sezione “Conosco la data della mia morte”, in cui i riferimenti biografici sono più che altrove rilevanti, ma per tutta l’opera vale il presupposto junghiano che il personale sia sindone del collettivo e che l’incubo soggettivo diventi quello di un’umanità in sfacelo, incapace di creare una sosta al proprio impulso di aggressività e di autodistruzione. Le “misere apocalissi ad personam” (Θ, p.85), diventano in questo modo la realizzazione della maledizione di Caino e dei mercanti nel tempio come norma della vita umana sulla Terra: “Si giura, si mente, si uccide./Si ruba, si vendono umani/Si fa strage. Si versa sangue su sangue/si spostano confini/si inventano armi e si ammucchiano/(e scorie, biossidi,/ frutta e latte/scaduti). (Nella stazione di Rudra, in attesa, pp.71-72, vv.18-25).
La comprensione salvifica dell’essere polpa di un unico frutto è distolta da una percezione sempre più edonistica della propria identità, che non riesce a intercettare e comprendere, nelle miriadi che fluttuano nell’etere, il messaggio risolutivo, quello dell’individuo che ha conosciuto già la morte e potrebbe riscattarla: “Io sono Lazzaro, vengo dal regno dei morti,/torno per dirvi tutto, vi dirò tutto”/al termine del notiziario vi avrei/ davvero svelato tutto. O, almeno,/molto. Molto, davvero./Più di quanto vorrete mai sapere/ma vi siete dileguati, sedotti/dalla vostra quotidiana fine del mondo/come formiche ai comandamenti/dell’odore e del granello dolce”(Io sono Lazzaro, vengo dal regno dei morti, p.75, vv.1-10). La contaminazione fra tempo del chiacchiericcio e tempo della rivelazione è di ascendenza eliotiana e in una sua poesia il riferimento preciso è a “Canto d’amore di J. Alfred Prufrock: “in quale stanza dimoro?/in quale cavità della stagione/ morente io e te aspetteremo?”(Una visione, p.102, vv. 22-24)
Rienzi riesce a riportare sulla pagina poetica il rifiuto, la mancanza di accoglienza, il richiamo alla carità, senza nessun passo falso retorico, attraverso un processo di interiorizzazione consonante alla cronaca, poi restituita attraverso il rinvenimento di simboli universali: la partenza, il pane e il sale, il deserto, le case diroccate. Il tema del dono gratuito dell’ospitalità avvicina Rienzi alle tematiche e ai moduli espressivi cari a Edmond Jabès; il cercare e accostare simulacri di parole la cui denotazione è nello stesso tempo avvampante e oscura, lo indica capace di sostenere la rabdomanzia di ferite di Paul Celan. Affiora una radice ebraica del sentire attraverso il disvelamento di una lingua raffinatissima e tribale, alla ricerca del sacro salvo dal tempo (gli elementi vegetali e animali) e del sacro contemporaneo, preda costante del disinganno. Eppure, ieri come oggi, c’è l’esigenza primordiale e attualissima del partire, per scoprire, per mettersi in gioco, per salvarsi.: “Parto nottetempo/senza una parola, un addio/e quell’abbraccio che mi avrebbe inchiodato/(e quelle lacrime d’argento che non avrei potuto trattenere/di qua dall’occhio)./Vi nominerò uno ad uno, fratelli miei che lascio,/a ogni alba e parlerò alla luna come se fosse il volto tuo/sorellina, gocciolina di latte.”( PARTENZA E PRIMA PROMESSA II, p.42, vv.5.12)
E se si arrivasse alla constatazione che ogni partenza sia in fondo falsa e che tutto si muovesse in una giostra che ripete perpetuamente il suo movimento circolare? Se il succedersi sempre uguale di albe e tramonti avesse trascinato con sé questa conseguenza, ebbene si troverà per l’uomo, tra gli spazi siderali, la forza utopica di un rimodellamento delle leggi dell’universo: “Una differente origine del giorno/ è ancora possibile/è possibile, ancora/ se infinita è la notte./Schiere abitano l’arcipelago/prima del sole:/ moltitudini in attesa/dell’iride bianca/di qua dal guscio di Oort.”(Una differente origine del giorno, p.108)
Paolo Gera
I verbi rinunciano, i presagi non dicono
Dicono questi versi
di nulla che succede,
non descrivono fatti.
Resiste qualche raro verbo fossile:
sta, aspetta, disperde.
Questo vuole l’ebbra superficie:
al troppo dire, al morso dei ragni
opporre silenzî di arenili
boccheggii di meduse.
Sotto, dentro, diffidiamo delle albe:
ci serve notte, ancora
di radice e di seme
ci serve buio, dentro,
la sua morente schiera.
Qui, in superficie, i verbi rinunciano
i presagi non dicono.
Io sono Lazzaro, vengo dal regno dei morti
«Io sono Lazzaro, vengo dal regno dei morti,
torno per dirvi tutto, vi dirò tutto»
al termine del notiziario vi avrei
davvero svelato tutto. O, almeno,
molto. Molto, davvero.
Più di quanto vorrete mai sapere
ma vi siete dileguati, sedotti
dalla vostra quotidiana fine del mondo
come formiche ai comandamenti
dell’odore e del granello dolce
vi avrei confessato, come inizio,
che non fui mai veramente morto
che i vermi e le garze
e i pianti delle sorelle e il sepolcro
furono l’inganno per i Guardiani.
Come molti prima di me, come molti dopo.
Torno per dirvi il tempo che verrà
e sommerà sete a sete, caduta
a caduta, le sottilissime lingue
uraniche e le gialle e ferme nebbie
ma sono indifferenti ai vostri sensi
le grida intraducibili, la verità, il silenzio
uguali il presagio e il profondo sonno.
Ά
Non sia dissociato dalla realtà il sogno, la sua sintassi si faccia onda, il decimale vesta i misteri – prima e dopo la virgola – molto, molto dopo la virgola
la pietra e lo specchio sono sfuggiti di mano allo stesso dio, e noi abbiamo ammonticchiato fedi di comodo per l’una e per l’altro, e per ogni sciame d’insetti
ma il coraggio di respirare l’ossigeno dell’acqua non ci è stato donato, il desiderio non ha conosciuto la pronuncia che attendeva.
Per questo – anche per questo – non si separi il sogno dalla realtà,
le acque superiori restino con le inferiori, l’athanor abdichi al suo sigillo e l’amnios disciolga il primo concepimento della cenere.
Una visione
Ci sarà tempo, ci sarà tempo/ […]
Ci sarà tempo per uccidere e creare,
E tempo per tutte le opere/ […]
E per cento visioni e revisioni
(T.S.Eliot, Canto d’amore di J. Alfred Prufrock)
Sfilano in basso boschi densi di cerri e faggi:
sono io il fruscio
o la remigante? O la distanza?
Palpebre spesse (anche das innere auge
è diventato opaco).
E ci sarà tempo? ci sarà tempo
davvero, J. Alfred?
non per cento, ma per una visione
ci sarà ancora tempo?
(speranze e azzardi sono differenti
a vent’anni, l’avrai compreso questo,
questo l’avrai sentito – e presto, credo –
tra i denti e le dita, senza aspettare
che si disperdessero vini a sera)
e tornerei – e torno! – sulle mie orme:
minute creature una ad una le stanno cancellando
oh sì, Tiger il Navajo le saprebbe seguire,
nel suo alfabeto di fumo salvare
il racconto per l’attimo senza vento
le nubi piangono fuliggini e mirra
e sfilano, sfilano in basso boschi
in quale stanza d’acqua dimoro?
in quale cavità della stagione
morente io e te aspetteremo?
