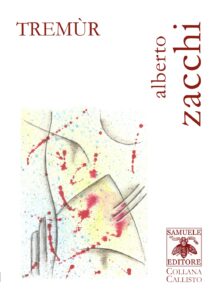
Dire la malattia è dire la fragilità del corpo, questo complesso sistema biologico che accoglie le nostre funzioni vitali e intellettuali, che ci permette di interagire e comunicare con il mondo e con gli altri corpi, corpo a cui dobbiamo il presupposto stesso della nostra esistenza: la malattia, in particolare quella grave e inguaribile, ci pone di fronte alla sua accettazione necessaria, qualunque ne sia la forma, quali ne siano le conseguenze, spesso dolorose e debilitanti. È questo il tema della raccolta di Alberto Zacchi (il titolo Tremùr è legato alla principale manifestazione della malattia di cui si parla, ossia il morbo di Parkinson) e questa centralità dà una cifra ben precisa alla poesia, che si fa testimone di una realtà bruciante e autentica, che non consente alcun compiacimento estetico ma una forte impostazione etica e rigore nell’uso dello strumento linguistico e stilistico.
La scelta, naturale per Zacchi, di impiegare il dialetto bresciano, nella sua variante della parlata di Flero, un piccolo comune della provincia, offre tutte le potenzialità di una lingua scabra, disadorna, poco incline al sentimentalismo (tutti elementi che caratterizzano anche come sonorità e espressività questo dialetto), lingua che quindi orienta a un approccio insieme realistico e essenziale. Tutte le poesie della raccolta si caratterizzano per la loro brevità e per la presenza di una prima persona singolare che si fa testimone del proprio dramma, ma assistiamo a cambiamenti nel punto di vista, il che lascia intendere la presenza di una pluralità di voci (di “io”) che vengono a creare una dimensione corale, comunitaria. Ogni singola poesia è un frammento esperienziale, un monologo ridotto ai minimi termini che espone la ferita, la sottolinea e la scandaglia: il procedimento è funzionale a una parallela resa teatrale, come ben notato nella sua prefazione da Franca Grisoni che ci ricorda come l’autore sia ancora attore e regista teatrale. Il verso è anch’esso prevalentemente breve o brevissimo, spesso ridotto a bisillabo o monosillabo, conferendo alla scrittura un ritmo sincopato e spezzato che rispecchia nella forma quelle che sono le principali manifestazioni e conseguenze della malattia, che mutila movimenti e gesti, compromette la parola e la scrittura, ma questi versi sanno mantenere la lucidità di ciò che occorre dire e che Zacchi sa esporre con incisività e naturale propensione alla sintesi. Si procede come attraverso le tappe di un percorso di consapevolezza e interiorizzazione della malattia di cui le poesie sono il tracciato in un gioco di echi e di rimandi, riverberi a distanza e riprese rafforzative, che fanno di questo lavoro poetico un organismo vivo e pulsante, come è proprio del corpo afflitto dalla malattia di cui si parla.
Se dal punto di vista stilistico è chiara la coerenza rispetto al tema trattato, dal punto di vista semantico a colpire sono la sensibilità e l’umanità con cui Zacchi riesce a dare evidenza del dramma della malattia, con dovizia di dettagli e situazioni, con una forte immedesimazione psicologica e con cognizione di causa, tipica di chi ha vissuto e toccato con mano questa esperienza. Ogni composizione è caratterizzata da concretezza, dall’intuizione del disagio e della sofferenza di chi è colpito dalla malattia, da un tono dimesso e al tempo stesso capace di definire, far emergere dalla pagina la dimensione profonda ed esistenziale con cui l’essere umano si confronta, cerca accordi, convivenze possibili. Ogni sintomo e conseguenza della malattia è un passo ulteriore verso la consapevolezza della propria fragilità e insieme della forza necessaria a sostenerla. Come si legge nelle ultime poesie del libro, la malattia diventa perfino dono, perché permettere la riscoperta e il riavvicinamento a Dio, alla prospettiva della fede come strumento di redenzione e di speranza: “Nel me pregà / en grassie / per chel che so dre a pröà”. Il corpo dell’uomo colpito dalla malattia rispecchia allora il corpo sofferente e straziato di Cristo sulla croce, condivide con lui la dimensione compiuta del dolore: è quello il momento in cui il tremore ossessivo della malattia sembra sospendersi, addirittura arrestarsi, perché il corpo va oltre sé, trova una ragione assoluta a questa esperienza dilaniante, scopre di essere parte di un senso ulteriore in cui l’uomo non abiura a sé stesso; anzi, si comprende, si completa.
Fabrizio Bregoli
Trübülà
L’è töt en trübülà
da chel che l’è ‘l vistis,
a chel che l’è ‘l laas,
parlom pò mia
de töt chel che l’è ‘l dafas;
l’è ‘n söghetà a desfà nel fa.
Tribolare
È tutto un tribolare / da quel che è il vestirsi, / a quel che è il lavarsi, / non parliamo poi / di tutto quel che è il daffare; / è un continuare a disfare nel fare.
La ucia
El me cuser el sta
nel’enfilsà la ucia.
L’ago
Il mio cucire sta / nell’infilare l’ago.
Scarabocià
La slonga la sò ma
e ‘n chel tremà
la me domanda
chel che sö la carta
so dre a scarabocià.
Scarabocchiare
Allunga la sua mano / e in quel tremare / mi domanda / quello che sulla carta / sto scarabocchiando.
I sò dicc
Töt l’è nassit
dal tremà dei sò dicc.
Le sue dita
Tutto è nato / dal tremare delle sue dita.
El cariulì
La pucia ‘l cariulì
per nà vià drit,
pò
la sè sinta zó,
la sculta e la ‘arda
chel che fó,
pò
sügat en lacrimù
la fa chel che la gh’ìa de fa,
la me domanda
chel che sul a me
la pudia domandà.
Il carrellino
Spinge il carrellino / per andare dritta, / poi / si siede, / ascolta e guarda / quello che faccio, / poi / asciugata una lacrima / fa quello che doveva fare, / mi chiede / quello che solo a me / poteva domandare.
Braa
Ta gh’ét capit
che ‘l tò tremà
el m’ares tocat
e ta sét stada braa
nel fal,
tat braa
che me pòs pö
desmentegat.
Brava
Hai capito / che il tuo tremare / mi avrebbe toccato / e sei stata brava / nel farlo, / tanto brava / che io non posso più / dimenticarti.
