Per il secondo anno la Redazione di Laboratori Poesia saluta i suoi lettori (si veda lo Speciale di dicembre 2022, QUI) con una scelta di libri letti e amati. I libri consigliati sono usciti per lo più nel 2023, ma le scelte di alcuni redattori ci portano indietro nel tempo, perché nella lettura spesso accadono riprese e riscoperte di libri che non passano mai di moda. D’altro canto, ciò che è poesia è senza tempo, dunque non di moda.
Alcune di queste brevissime recensioni, inoltre, verranno ospitate nello Speciale della rivista semestrale «Laboratori Critici», che uscirà domani in occasione del ventennale dell’«Almanacco del Ramo d’Oro». Un’importante ripresa che acquisirà il nome di «Nuovo Almanacco del Ramo d’Oro» e che diverrà un appuntamento annuale all’interno della calendarizzazione degli Speciali della rivista, accanto ai due numeri canonici semestrali.
Vernalda Di Tanna
VERNALDA DI TANNA
(LEONE, BELLINTANI, VIGOLO)
Andrea Leone, Ludwig (Fallone, 2022)
Andrea Leone ha pubblicato libri interessanti come L’Ordine (La Vita Felice, 2006) o il recente Ludwig (Fallone, 2022), dando prova sin da L’Ordine che l’assiduo, enigmatico, esistenziale dissidio del poeta – colui che sopravvive nel pericoloso intreccio ch’è la verità –, può essere esemplificato da quei «sostantivi monolitici e precisi» di cui scrisse Milo De Angelis in Prefazione. Il poema-partitura Ludwig si fregia d’un dettato eloquente, innervato fra lirismo e titanismo; ossessivo, disarmante e disorientante, rifiuta la contemporaneità, incline a rintracciare le orme di Benn e Trakl. Proseguendo il percorso idealmente avviato dal romanzo Kleist (2014) e dai versi di Hohenstaufen (2016) – dedicati a Heinrich Von Kleist –, con l’epos di Ludwig, ora Leone invischia i lettori nella tragedia dello «spavento», prestando la sua voce a un altro personaggio storico – l’«implacabile» Re di Baviera Ludwig II Wittelsbach –, inscenando così la polarità di quel «Tu che di colpo / sei chi sono».
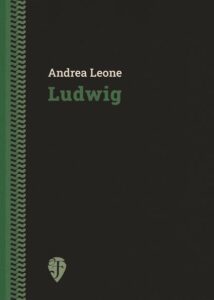
La stanza azzurra della mia testa –
gli infiniti
gli inflessibili
incidenti delle mie menti –
la galleria di specchi dei miei cervelli –
l’autore drammatico che mi ha creato –
il mattino che allestisco
in tutto il libro violentissimo –
Tu sei la pura
partitura che mi esegue,
tu sei esattamente
la lente
delle spietatezze,
tu sei l’implacabile
sole di sangue nelle stanze,
tu sei il delitto che dirigo,
tu sei il pericolo che indico.
Tu mio altro
tu mio inaspettato
attentato matematico.
Mio creato dal crollo.
Mio contemporaneo del canto.
Mio coetaneo dell’entusiasmo.
Tu mi stai accanto
nello schianto umano,
tu totalmente sorprendente
detti le regole della legge,
tu incessantemente
sei le mie idee segrete
vertiginose di perfezione,
tu sei la febbre,
tu stai oer vedere,
tu sei veramente
totalmente vivente,
tu hai scelto di essere
un dio nelle epoche.
Tu il miracolo
che un giorno mi ha edificato,
tu il prodigio
che da solo si è costruito.
Perturbamento perfetto
nome che ripeti
vivendo, mondo,
cosmo che allarmo,
biografia del palco,
annuncio in cui annullo,
avvento antico
in cui agisco,
individuo del mattino,
spirito che sanguino,
storie dello sguardo,
celebre di sequenze delle potenze.
Tu che sei sempre stato
il teatro dove batto
l’attacco all’attimo.
Le partiture pericolose,
le sale drammatiche,
le tattiche tragiche,
il mare allarmante.
Le vertigini di imperativi,
le scene nel coro del corpo
spartendo il portento,
la catastrofe marziale,
Marte dell’arte implacabile.
Trame adorate del nume tutelare,
siete ritornate ad entusiasmare
l’avvenimento geniale.
Umberto Bellintani, Nella grande pianura (Mondadori, Lo Specchio, 2023)
È trascorso un quarto di secolo dall’anno in cui Maurizio Cucchi sottraeva Umberto Bellintani al silenzio nel quale il poeta di Gorgo aveva rinserrato sé stesso. Prendendo l’abbrivio dall’ultima opera licenziata da Bellintani, l’omonima antologia Nella grande pianura (Mondadori, Lo Specchio, 2023) costituisce una succulenta novità libraria, nonché un’operazione di recupero. Vantando un’appendice d’Inediti in calce, lesta ci disvela quella felice risultanza delle indagini condotte da Rita Bellintani fra le carte paterne. Non è arduo ravvisare negli Inediti le inscalfibili peculiarità d’una autentica voce fuori dal coro. I suddetti componimenti presentano una densità espressiva tale da tradirne le radici, assecondando acutezza e inquietudini d’un dettato sempre bilicato fra due magnifiche presenze: l’una classicheggiante, l’altra animalesca. Difatti, «del tutto arcano insostenibile e gioioso» ogni verso è tuttavia di morte ingombro, ché «in noi s’alterna / timore d’essa e quieta attesa».

Fermiamoci un momento, amici.
Quest’albero era
quando ancora non erano
i nostri padri i nostri avi.
Ed ecco io sento che qualcosa gli devo,
ma non so cosa, amici, ma la mano
mia ecco lo accosta e lo carezza,
e tutta trema la mia mano, amici.
Sera di Gorgo
Ancora opache innanzi a questa
sera ed umane.
Ora sono delle anime viola
le figure d’intorno al carretto
di chi grida il bel rosso dell’anguria.
E l’asino è un’ombra che sogna
e mastica biada.
Là il cielo è un verde di giada;
una rondine vi si tuffa,
esce, si perde:
è quasi ora di accendere lucerne.
L’avo mio antico
Vorrei trovarlo con un’anfora bella
e le falangi della mano d’intorno
come petali di un sottile bianco fiore;
o con un segno patrizio, un monile
in figura di scarabeo, l’inciso nome;
e sia pur con catena di schiavo
e il cranio spaccato a pezzi a pezzi.
Giorgio Vigolo, Poesie. 1923-1982 (Le Lettere, 2023)
Critico, narratore, traduttore, esegeta dell’opera di Giuseppe Gioacchino Belli, Giorgio Vigolo (Roma 1894 – 1983) è stato soprattutto un poeta. Influenzato dalla cultura tedesca, ha subito l’influsso di Fichte, Schiller, Goethe e Novalis, plasmandosi attraverso la felice congiuntura di poesia, musica e filosofia. Molti, notevoli componimenti di Vigolo sono stati recuperati e raccolti in Poesie. 1923-1982, antologia introdotta e curata da Andrea Gialloreto. Pubblicata agli sgoccioli del 2023 dai tipi de Le Lettere nella collana diretta da Diego Bertelli e Raoul Bruni, il volume ripercorre tutta l’opera poetica di Vigolo, da Conclave dei sogni a La fame degli occhi. Una parola-chiave per un primordiale accostamento a Vigolo è «spirale»: essa condensa il «conflitto tra la gravità della materia e la levità del moto ascendente e spiraliforme» (p. 10), la si incontra in Lagrima caddi, testo sulla vita tratto da Canto del destino (1935-1957), ove il poeta cade «indietro/ nell’età riaperte» (p. 110).
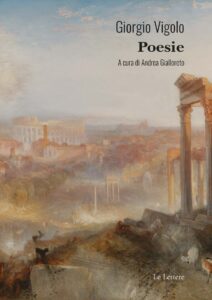
Andromaca
In te mi piaccio, tenera
preda d’antiche notti,
or mia fedele e schiava
di regina che fosti,
quando ti giunsi in cima
a delirate scale
d’incendio salva.
Il fiume che sale sul monte
I.
Intendo ora solo
il senso di quelle rovine,
come se il tempo
si mettesse a fuggire
a ritroso,
come se la sua spira
si riavvolgesse.
Forse la voluttà
Sperimenta una simile fuga
dei sensi tornati alle origini;
la durata dei giorni
precipita indietro
in un vortice.
II.
Aspiro dell’aria l’odore
il fiato dei ruderi immensi;
capisco le volte dei templi
spaccate sul piccolo fiore.
È il tempo che balza all’indietro,
è il fiume che sale sul monte,
riavvolto alla spira del fonte
il figlio ritorna alla madre.
L’amore abbracciato alla morte
conosce il folgore uguale
del cielo che tocca la terra,
che brucia la luce e sotterra
l’azzurro nel minerale.
Lagrima caddi
Temo del giorno e della notte fuggo
gli oscuri vuoti ove cadendo indietro
nell’età riaperte io mi rinvolgo
alla prima spirale
della nascita e salgo
sopra fulminee scale
il ciglio di vertigine
d’onde qui scesi.
Lagrima
caddi da un occhio immemoriale, in pianto
rigai l’immenso viso. Sono un uomo.
Amara stilla: ma trafitta splendi
dei raggi ancora di quel viso e il dio
recline come in frantumato specchio
in te si guarda e accende un mondo, un altro
sé d’esistenza effimera: la gocciola
estasiata in iride si frange.
SERENA MANSUETO
(IBELLO, SIMONCELLI, GHIOTTI)
Giovanni Ibello, Dialoghi con Amin, Crocetti Editore, 2022
Attraverso i Dialoghi con Amin il poeta Giovanni Ibello ci accompagna nella sua produzione lessicale in una forma di scrittura che tenta di sondare un segreto antico, cosmico, e che involve l’insistente, e l’urgente, esigenza di conoscere l’alfabeto dell’invisibilità, lo zenit del divino che sovrasta – e sovra-sta – l’essere umano: «ogni cosa rivela/ quel nulla che siamo già stati». È un dialogo con la personificazione dell’ancestrale, con un’era passata con cui è difficile essere in ascolto: Ibello sembra stringere intime alleanze con tempi trapassati, spostandosi e muovendosi in una sorta di a-temporalità, attraverso universi simbolici e quesiti esistenziali. Il poeta, in un linguaggio quasi fideistico, ci rammenta la caducità dell’uomo, lo stare nell’impossibilità e nell’impotenza, dentro «il cifrario di dio», all’interno, dunque, di una volontà inspiegabile come in una «giostra di tagliola e vento». La parola di Ibello si trasfigura in una posa profetica: «verrà la vergine dei seni ulcerati», il suo è un adoperare rappresentazioni che evocano il capovolgimento della spiritualità, del nutrimento divino, in una santità danneggiata dall’uomo del nostro tempo.

Amin, avrai una sola occasione,
una sola freccia da scagliare controsole.
Seleziona con cura
L’abisso entro cui esplodere.
Verrà la vergine dei falò
verrà la vergine dai seni ulcerati,
un altrove di baci
al kerosene
un altrove di spine e diademi.
Ma noi
dimenticati relitti
ci amiamo nel buio degli hangar
e ripetiamo giaculatorie
dinanzi a un dio demente
che scalcia
nel grembo della cancellazione.
Dentro un cielo che fu lunato/io, oscuro natante…
Rinuncio al cielo-ziqqurat,
baratro di uccelli.
Rinuncio ai falsi om,
al sacerdozio della luna.
Stanotte muoio cane e poi rinasco
ragno di luce estenuata.
Anche tu la chiami morte
questa armata/ silenziosa, senza luna?
La preghiera del giorno: siamo muti.
Tutto si separa per venire alla luce.
Stefano Simoncelli, Sotto falso nome, Italic Pequod, 2022
Sotto falso nome è il titolo-pastiche che, apparentemente, il poeta prende in prestito dal saggio di Cristina Campo ma che richiama un verso tratto da Ultime cartoline al tuo silenzio, una delle sezioni del libro la cui intensità e tensione emotiva supera quelle di altre sezioni. La raccolta, già finalista della prima edizione del Premio Strega Poesia, è cesellata da visioni a metà tra l’onirico e il reale, in cui prevale il desiderio di mettersi in contatto con il mondo fantasmatico dei defunti. Articolata in cinque sezioni, i cui titoli ne danno un’intestazione/introduzione, la silloge racchiude in sé un aspetto dedicatorio e memorialistico, mettendo in risalto la componente più intimistica legata alla perdita di persone care, ponendosi in alcuni tratti come una sorta di epistolario in poesia, in una corrispondenza irrealistica con l’Altro dipartito. Nella sezione già enunciata, Simoncelli, si rivolge in maniera diretta, e in un tono a tratti prosaico, alla persona amata e tristemente scomparsa: si tratta di una parte della silloge largamente costellata da angosce del vuoto, dal senso di colpa e dalla sfibrante attesa per il ritorno (irrealizzabile) di lei dall’aldilà.

C’erano notti in cui parlavi sottovoce
con le ombre sui muri e piangevi,
le spalle che ti sussultavano
come le mie che ti ascoltavo
dietro la porta, ma alle sei e mezzo
spaccate, sole, pioggia o neve, suonava la sveglia,
ti alzavi di scatto dal letto, ti lavavi come i gatti
e uscivi di casa abbandonando nell’aria
una inebriante scia di brillantina.
Impossibile sapere dove andassi
mentre io fingevo di dormire
come faccio anche adesso
succhiando pastiglie al tamarindo
con la speranza che mi infilino
in un sacco di posta veloce
verso la buca del tuo nuovo indirizzo
che ha il colore del niente e della fine di tutto.
Cesena, via Rosselli, febbraio 2021
È come se guardassi gli anni
dietro un vetro smerigliato,
opaco o rigato di pioggia,
sempre più indistinguibili, confusi,
ma è rimasta intatta nella mia memoria
ogni giorno più provvisoria, la tua comparsa
nella vestaglia di seta viola aperta sulle gambe
slanciate, eleganti, le caviglie impareggiabili,
mentre salivi le ripide scale di questa casa
a due piani («da vecchi la malediremo»
imprecavi) per venirmi a trovare.
È questa la scena che rivedo
nelle insonni notti solitarie.
Cesenatico, 12 agosto 2021
Dicono che me la sto cavando
e può darsi sia vero. Leggo, scrivo
e ogni tanto guardo la tua fotografia,
l’unica che ho conservato, carezzandola
con la punta del dito mentre sorridi
e sorridi benissimo
come le volte che ti raccontavo
qualcosa di divertente o una sciocchezza
se ti vedevo triste, malinconica, il muso lungo.
«Cos’è che non va, principessa?» ti chiedevo
sapendo che la colpa era mia,
sempre e soltanto mia,
ipocrita che non sono altro,
tale e quale a mio padre che detestavo
finendo per imitarlo e amarlo più di me stesso.
Non me la sto cavando. Affondo ogni giorno
un poco, invecchio, stravedo e se allungo
una mano dall’altra parte del letto
o se per uno spostamento dell’aria
si spalanca e si chiude una porta di colpo,
se mi sembra di sentire appena un respiro
alle spalle o se sussurrano il mio nome
da qualche parte che non vedo
è a te, principessa, che penso.
Cesena, senza data
Giorgio Ghiotti, Ipotesi del vero, LiberAria Editrice, 2023
Nell’Ipotesi del vero il legame tra poesia e biografia è fortissimo, quale indizio cogente per esprimere un certo esistenzialismo di fondo. È rintracciabile, tra gli altri elementi scorgibili, l’assenza in alcune sue declinazioni: come ricordo, o rievocazione, e come memoria che si pone in una posizione nostalgica rispetto al tema tempo: «non dovrebbero mai salire / troppo a galla i ricordi». I luoghi, quelli delle vicende umane e urbane da cui risuonano echi provenienti dal Pianto della scavatrice e dalla via Fonteiana di pasoliniana memoria, si mostrano nei versi di Ghiotti attraverso una «miracolosa luce di quartiere»: quello di Monteverde, sobborgo romano d’adozione, oltre che per Pasolini, anche per Giorgio Caproni e Attilio Bertolucci. Del tutto priva di superflue forzature malinconiche, la raccolta di Ghiotti ripercorre gli aspetti della vita con la tenera visione penniana di cui, per altro, in alcuni tratti se ne riscontra l’assonanza. Diversi poeti popolano i componimenti, da Umberto Saba a Patrizia Cavalli, da Gabriella Sica a Biancamaria Frabotta, riunendo tempi, luoghi e memorie: un trinomio nel quale si impernia tutta la poetica di questa silloge.

Poesie come sintomi – felici
e feroci, necessarie – quel tanto
da sentirsi ancora vivi –
il sangue che brucia appena,
la mente che da grave si fa cosa
cedevole leggera compromessa
felice carceriera del suo regno
ceduta in custodia di sé stessa.
Facile leggere nei cieli –
tra ritorni propizi e nuvole frondose
distese intonate al mio quartiere –
alla giornata – andata bene
andata male, dipende dal tuo
viso cerebrale – un’avanzata
anziché un regresso –
a me basta tornare per le vie
di Monteverde, adorate vie
in salita – in discesa – in rapida
contesa col tuo passo – per mia
fare una torcia da un lampione –
illuminare strade, invadere finestre
col mio canto – sopra il tuo balcone
il cielo riluce – di stelle è la cornice
– la luna è una stagione –
Roma è un santo.
Ho un cane che adori
lo chiamo “mio figlio”
con gli amici, allori
minori per quelli come me
(Saba, Bellezza, Testori…)
FEDERICO MIGLIORATI
(VIVIANI, FLORIS, SEUSS)
Viviana Viviani, La bambina impazzita, Arkadia Edizioni, 2023
Una poesia all’apparenza semplice, schietta, immediata eppure quella di Viviani in La bambina impazzita (prefazione a cura di Pasquale Vitagliano) dimostra maturità di stile e di contenuti, senza eccessive influenze «esterne». Nelle pagine che compongono le otto sezioni della silloge la poetessa ferrarese opera un’azione di decifrazione e di ricerca nel fitto groviglio delle relazioni umane (siano esse familiari, amorose o amicali) in cui immette il proprio vissuto, il senso più vero della propria esistenza, scevra di sotterfugi. Dalla sua lente d’ingrandimento finiscono sotto processo certe intemperanze maschili con un percorso a ritroso nel tempo che porta in evidenza conquiste quotidiane, un’infanzia lontana, il mondo fiabesco che appare e scompare. Viviani si mette a nudo, senza preconcetti o pregiudizi, offrendo di sé fragilità e forza, entusiasmo e disillusione. Significato il richiamo all’evoluzione della lingua, sempre più preda di un costante involgarimento e livellamento.

Fingo di non amarti
Fingo di non amarti
rispondo tardi
mi sento scaltra
se sbaglio apposta
il nome dell’altra
mostro indifferenza
distrazione e assenza
dico stiamo insieme
finché stiamo bene
viviamo il presente
senza promesse
sotto queste sciocchezze
da donna cresciuta
tengo nascosta
la bambina impazzita
Abigeato (prove per un abbecedario poetico)
Che bella parola
abigeato
che peccato
impararla a scuola
e poterla usare
così poco
e solo per gioco
se nel ciarlare
con gli amici tuoi
non si parla mai
di mucche e buoi
Mia madre
Mia madre quando legge un libro
inizia dalle ultime pagine
il suo cuore odia l’attesa
e non regge il mistero
per lei sono un romanzo
di cui non ha il finale
lo prova a immaginare
ma troppe volte
ricomincio da capo
mescolo i capitoli
vivo senza rilegatura
così per mia madre
sono una dannazione
Raffaele Floris, La macchina del tempo, Puntoacapo, 2022
Floris è tra i poeti contemporanei più attenti al rintocco del ritmo, a una metrica sapientemente impostata, all’uso accorto dei vocaboli, a un idioma che abita uno stile elevato senza eccessi, dall’eleganza innata. Nel travaglio dell’esistenza che la malinconia e il disincanto fanno risaltare, c’è una valvola di sfogo, una via d’uscita: è quella del sogno che di fronte a un io slombato ridà un poco di voce e forza per seguitare. I versi si «accendono» di contrasti, di contrapposizioni, si mostrano «preda» di un vivace colorismo e, lontani da cervellotici discorsi, giungono a offrirsi come primizia lussureggiante di bellezza, specula preziosa per cogliere pena e speranza. Mutevole, l’animo umano può trovare nel silenzio un elemento di forza e di riconciliazione con l’altro e con l’universo. In Floris si percepisce una sapienza antica, una forma di scrittura illuminante e consolidata che si nutre, al postutto, della più nobile tradizione italiana.

La macchina del tempo: un’occasione
che non vorrei per me, ma per i gelsi
custodi dell’autunno. È la finzione
degli anni, dei sentieri che non scelsi.
Sconfina la pianura, come sempre
succede. Lei che ha fame di radici,
di fossi: non c’è chiusa che abbia tempre
gagliarde e polsi senza cicatrici.
Così nasce il dolore. Non c’è scampo
la nebbia, come sempre, in controcampo,
la resa, questa volta, sulla scena.
Terra di confine
Vento sin dal mattino. Ha scosso i rami
delle robinie, i nidi delle gazze
ondeggiano al livore di gennaio:
i campi sono terra di confine.
La terra è attraversata dal silenzio,
da solchi lunghi, dalla corsa astuta
e folle dei cinghiali, inconsapevole
di quella forza quasi primordiale.
Cosa ci resta di quelle sere
nebbiose, delle rogge, delle chiuse?
Quanti bocconi amari, quanta pece
Nelle radici dei gelsi estirpati!
Damasco
La bimba alza la testa e guarda il cielo
Sola, nel labirinto degli androni,
gli occhi disposti a immaginare un mondo
senza fragore. Ondeggiano le case
sventrate dall’ingiuria del mortaio.
Quanti sogni sepolti, quante vite
Sotto scacco, quanti cieli perduti
sulla via di Damasco, ora Via Crucis.
Diane Seuss, La ragazza dalle quattro gambe, Edizioni Ensemble, 2021
I ricordi d’infanzia, le crudeltà incontrate sul cammino, la redenzione, il sogno, i poveri e i diseredati, ma anche luoghi e scorci iconici della periferia americana: le direttrici della poesia di Seuss si muovono all’interno di questo mondo. Tutto in lei è seme fecondato, è esperienza accolta, è catarsi di una vita: la prosa-poesia odora di fango e di sudore, di degrado e di assenze, poiché solo questo è il modo di riportare alla mente ciò che è stato e ciò che ancora è. Le pagine aprono costantemente a nuove forme espressive, a immagini dispiegate e tambur battente, in rapida sequenza come davanti a una pellicola cinematografica. Una mente vivacissima quella di Seuss che tocca anche il variegato elemento della natura, in inestricabile osmosi con l’essere umano. A prendere vita sono anche i fantasmi di un tempo così che tra realtà e immaginazione diventa tutto più difficile da decifrare. Un «punk rurale» che non smette di stupire a ogni lettura.

Birre gratis
Io sono quella che può reggere un boccone di sale.
Portatelo qui, il matto della prigione vestito a strisce.
Posso pregare per lui, anche se i suoi occhi sono feroci.
Posso spidocchiare il ratto.
Quando ero bambina li ho invitati tutti a uno spettacolo di marionette.
Non c’erano marionette; non avevo organizzato nessuno spettacolo.
Birra gratis, ho detto, e sono venuti.
Ho visto un teatro di marionette.
Si trova nella caverna nera dietro i miei occhi.
I pensieri sono marionette che pendono dai loro fili aggrovigliati.
Portatela qui, quella che gira sul girarrosto della malinconia.
Sezionerò un’arancia per questa miserabile bastarda.
Le servirò un boccale pieno di lacrime.
Birra gratis, dirò, anche se non c’è birra.
I miei pantaloni si stanno disintegrando. Sì.
I miei pantaloni rosa shocking. Rosa shocking, a strisce tigrate nere.
I pantaloni su cui ho costruito la mia nuova vita.
Pantaloni per cui sono nota. Modellanti. Scellerati.
Un giorno improvviso buchi. Vecchi appetiti, dolori spalancati.
Incisioni fessurate. Indecisioni. Quei pantaloni tigre
al tramonto che stria il cielo. Il rosa così familiare,
come tende per bambine, un letto a baldacchino. Il nero
che fa tanto inchiostro, tanto scrittrice, tanto mascara di
Cleopatra. Il rosa così spirale vaginale di Saffo,
così Of Woman Born. Il nero così Era delle Poetesse
Suicide. Così Tia Maria e Seconal.
Era tutto così simmetrico, così vivace, così pateticamente biforcato,
ingenuamente bi-curioso, così stordente, sordido, prima che
i miei pantaloni al napalm passassero all’azione, tutti batteri
mangia carne, tutti estetica della muta, tutti gloria a buchi.
Non riesco a non pensare a quella gonna newyorchese, dai lustrini marchesi applicati su cotone color del mare
L’avevo comprata sulla settima strada dell’Eastside, in un negozio aperto per un solo giorno. Kerouac aveva vissuto in quel palazzo, ma all’epoca era morto. Né zip, né bottoni, solo strisce di stoffa da annodare ai due lati della vita. Se solo fossi stata una che volteggiava…ma non ero una che volteggiava. Eppure, quella gonna funzionava come il miele per le mosche. Molti aspiranti boyfriend, uomini che mi venivano dietro e mi chiedevano il numero di telefono. Bramavo solo tenerezza, tutto qui. Quando me lo lasciavo sfuggire, il mio vero ragazzo avrebbe voluto picchiarli, fargli sanguinare il naso. Il mio ragazzo non si faceva da dieci anni e andò in overdose come un fulmine in un cielo azzurro. Come l’azzurro di quella gonna avrebbero detto alcuni. È sepolto in un cimitero di balenieri che si affaccia sul mare. Non chiedetemene la ragione. Non fui invitata alla cerimonia di tumulazione. Ora ho una zoppia e la gonna è andata. Perché ho una zoppia? Tutta colpa di un paio di scarpette rosse, mezza misura troppo grandi. Suole come vetro.
PATRIZIA BAGLIONE
(CARIFI, RUOTOLO, BIGNOZZI)
Roberto Carifi, Amorosa sempre. Poesie (1980- 2018), a cura di Alba Donati, Prefazione di Giulio Ferroni
Amorosa sempre di Roberto Carifi raccoglie gran parte delle poesie scritte dal 1980 al 2018. La poetica di Carifi accoglie e distrugge l’anima allo stesso tempo, poesia come mano scava nel ricordo più dolce e più tormentato. Vivi e forti sono il tema dell’infanzia, dell’assenza, di un Carifi figlio e amorevole nei confronti della madre. Un dialogo a cuore aperto è ciò che abita queste pagine mai ingiallite dal tempo. Carifi parla di una guerra mai vista, ma da poco conclusa; si presta con occhi e corpo per andare a scovare tra le macerie, quella che è stata per tutti una dolorosa ferita. E così, quasi tutta la sua poetica si intreccia con l’abbandono e la paura della perdita costante di quel ventre materno che accoglie e ripara dal male. Carifi desidera vedersi nell’immagine di figlio piccolo da accarezzare e rassicurare con teneri verbi. Vengono fuori tutta la fragilità e la dolcezza di uomo oramai adulto, la tensione che tutto possa frantumarsi in un solo istante.
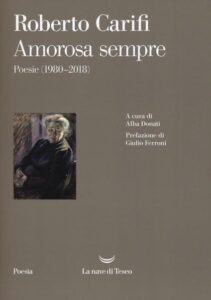
Riga d’alba
Si gettano nelle madri
con i visini appesi alla mischia
dove l’angelo li dissangua
bocca senza battaglie che ordina
di non crescere, a loro più a fondo
i massacrati
fino alla riga d’alba. Qui, sillabe
inginocchiate,
gelano al bacio della prima voce.
Ognuno ha una gloria
A volte l’azzurro è una piaga
che rompe il quadrato
dove il mondo riposa ed ognuno
ha una gloria da condurre
nel seno della terra, una ferocia
orfana che chiama amore
e stringe chi lo separa
dalle stagioni, il buio.
Nasce dall’esilio
Qualcuno viene con un nome indicibile,
una parola che afferra i corpi
e li sotterra dove non conta
il crimine degli anni. Allora i volti,
prosciugati dall’amore, tornano identici
al ritratto che fa crollare il mondo
ed una furia nasce dall’esilio,
una stagione in loro
sconfitti dall’inverno.
Elisa Ruotolo, Corpo di pane (Nottetempo, 2019)
«Usatelo bene, il vostro dolore / ché non diventi mercanzia / né attiri corvi al pasto della pietà». Con questi versi si apre Corpo di pane di Elisa Ruotolo. La raccolta, divisa in due parti, presta attenzione a due aspetti fondamentali della vita: il dolore e l’amore.
«Vorrei essere pane / perché tu avessi almeno / il dovere di poggiarmi / alla tua tavola».
La fame descritta in tutta l‘opera, non è certamente quella del corpo; ce n’è una davvero insaziabile e sofferta, che è quella dell’anima.
L’autrice indica con parole significative, dov’è che si trova la ferita – e lo fa con entrambe le mani. «Non la rivoglio, questa carne che trema / e balbetta alla vita»; non teme di confrontarsi con il dolore e la realtà dei fatti. Dolore che si sbriciola come pane secco su un tavolo di legno che ha già fatto i tarli. Vivere e morire per dell’idee ben precise. La dignità della parola che si fa verso, e guarda lucidamente l’effetto creato. L’indifferenza che uccide gli uomini, gli uomini che vengono inghiottiti per scomparire nel nero.
Il silenzio come vera e propria arma; con ‘silenzio punitivo’ si intende una situazione di violenza nei confronti del proprio partner.
Lo sa bene la poeta quanta forza – invece – possiede la parola; quanto amore incondizionato è capace di provocare. E di questo verbo, l’umanità tutta se ne disseta: per gioirne anche nella tragedia; per restare di carne e ossa nonostante tutto.

Ho paura di te, cuore mio.
Hai occhi disoccupati e ti fidi e dimentichi
e perdoni facilmente.
Hai anche desideri scomodi
come ginocchia sbucciate di fresco
sotto il vestito corto della domenica.
Ami come potrebbe fare una donna pubblica
e poi vorresti una morte comoda
-che una valvola, un ventricolo, un atrio
smettessero inaspettatamente di collaborare.
Hai la docilità degli agnelli alla tosatura
e l’oscurità del primo serpente
che tradisce ogni nato.
Lo so, vorresti trovare mani con cui spartire
le valigie, ma vai a spiegarla agli altri -questa tua
stanchezza.
Oppure spiegala a me, che di te ho tanta pena
se batti e batti
inutilmente.
Non lo sapevo
ma avevo come tutti
il mio punto di rottura
come i vetri
come la terracotta
come il ferro.
Incrinata sbreccata e fusa
cammino in questa stanza
coperta fino alle unghie.
Nessuno tranne te
può vedermi debole.
Non ho nulla.
E sono ciò che possiedo.
Vorrei essere utile
– l’anello che salva il dito dal taglio
– l’errore nella preghiera che fa sorridere Dio
– la carogna dell’animale a farti sentire vivo
e l’addio che accetti
senza rammarico.
Isabella Bignozzi, Memorie Fluviali (MC Edizioni, 2022)
In Memorie fluviali di Isabella Bignozzi, corpo e mente si fondono in un flusso potentissimo: «Si misura nel crollo / la premura d’amore».
L’amore per gli umani è il titolo che Bignozzi dedica ad un capitolo; amore che costeggia il cielo «e si spezza in verticale». La parola, che diventa luce, invade stanze e strade orfane – riverbera dalle persiane per posarsi sugli stati d’animo. Cura per gli umani; amore per il padre e Cristina Campo, alla quale l’autrice dedica una parte del libro. La voce che si fa verso è lieve, eppure incide ogni parola sulla pagina, quasi inchiodandola con pezzi di vetro.
«Spezzami piano», chiede poi l’autrice all’alba che deve farsi ancora giorno; timore assordante per le cose future, per la parte nascosta al resto degli uomini.
«Guarda la lealtà ancestrale perduta / che si addensa e riscalda attorno alle creature come / pulviscolo cosmico». Il ventre materno accoglie astri e viventi; il punto centrale di ogni dimensione.
Il male di vivere che a volte viene rinnegato – quasi a voler annullare la ferita – poi si fa visibile e si mostra alla stagione. Il glicine e l’insetto, nel frattempo, danzano una sola musica.

Alba
Sanguina il gelso
nel pianto degli archi
un adagio in minore
suonato di taglio
si misura nel crollo
la premura d’amore
negli steli recisi
la morte che ha cura
balsamo miele
mio barbaro
mia nuda tra le dita
preghiera
e tu
candido altare
alba di vetro
che ogni cosa sai
del nuovo giorno
spezzami piano.
Le mani
Dentro un vagone in corsa ci guardavamo le mani
avevamo la trasparenza di un’ora antica distesa
una sequenza di immagini noi due
i sorrisi piegati in avanti come girasoli
io piccolo animale ormeggiato a te
affidato il mio corpo al tuo grande
mio piccolo malato involucro
l’innocente premura dell’istante
un giardino d’inverno, un tepore di salvezza
la notte che ci vuole nudi e uniti ancora
nel più lontano amore che non conosce i discorsi
che non sa le parole.
L’amore degli umani
Essere toccati
in quel punto indifeso e segreto
dove depone il suo bene la parola esatta
che ci fa immobili in un battito da dentro
nella nostalgia profonda della cura.
CATERINA GOLIA
(FIORI, ZERBINI, TREBBI)
Umberto Fiori, Autoritratto automatico (Garzanti, 2023)
La raccolta Autoritratto automatico di Umberto Fiori è un’efficace testimonianza di quanto la fotografia influenzi la nostra vita e soprattutto la concezione che noi abbiamo della nostra identità. La fotografia viene intesa da Fiori, in molti versi qui raccolti, come un mezzo che ha l’uomo a disposizione per ritrovare il proprio volto. La cabina delle fototessere era una delle poche occasioni (l’altra accadeva se si possedeva una macchina fotografica) per non mettersi forzatamente in posa. Dunque, la propria identità poteva emergere nella totale libertà e privacy di quella che Fiori definisce semplicemente «cabina». Come già accennato, insieme al senso di libertà ce n’è anche di privacy. In una poesia tra le prime, dal titolo Seggio, la cabina per fototessere viene paragonata alla cabina elettorale. Questo paragone potrebbe sì motivare il perché questi due gesti siano considerati privati, ma più forte è ancora l’ipotesi che il seggio sia stato richiamato per simboleggiare il gesto fotografico come di importanza comunitaria e personale. Così come con la votazione, gesto fondamentale in una democrazia, indica una presa di coscienza e di responsabilità, anche la fotografia può essere intesa in quanto gesto attraverso cui si manifesta il proprio essere. Significa voler dire: io sono così.

Seggio
Ogni volta che accosti
la tendina, ogni volta che chiudi fuori
il mondo, infili cinquecento lire
e poi ti specchi nel vetro
prima di premere il pulsante verde, sale
questo languore:
come in piedi, con la matita in mano,
nella cabina elettorale.
Qui
Nelle foto normali
uno fa sempre qualcosa: si tuffa in mare,
alza un bicchiere, saluta dal finestrino,
scende le scale, sventola una racchetta,
si rotola nell’erba.
Qui, si presenta
nudo e fermo
senza cielo né terra, senza gambe.
Così si sporge
dalla mela
il verme.
Raccogliere
Non ci sono occasioni da celebrare
(un matrimonio, un compleanno,
una laurea, una comunione).
Non c’è da rinnovare un documento.
Soltanto identità, ripetizione,
addizione, raccolta.
E ogni volta la stessa solennità,
lo stesso raccoglimento.
Beatrice Zerbini, D’amore (Interno Poesia, 2022)
Il libro D’amore (Interno Poesia, 2022) di Beatrice Zerbini è suddiviso in quattro sezioni che indicano un percorso fisico ed emotivo dell’autrice, ma il suo sguardo autobiografico diventa anche universale. I titoli ne sono i primi indicatori: Sulla soglia, Anticamera, Dalla finestra, appena fuori e l’ultima Nel cassetto. Le sezioni del libro della Zerbini sono «stanze». Con riferimento diretto al termine più arcaico che moderno per chiamare le strofe in poesia, questo termine stanza sembra però riferirsi più che altro ad un riferimento spaziale, quindi elementare del significato. Difatti ci troviamo di fronte a dei nomi che sono degli spazi, probabilmente di una casa mentale. Il tragitto tracciato dalla Zerbini è un crescendo di sicurezza e confidenza col dolore portato dalla morte e dalla malattia: il lutto e la necessità di affrontare l’assenza. Forse è proprio per questo argomento limite (la morte, che segna una fine ma anche un inizio), trama della prima sezione, che questa è stata denominata Sulla soglia. Le seguenti sezioni si concentrano su alcuni temi cari all’autrice: l’amore e la difficoltà che comporta, la malattia (in particolare l’Alzheimer) e il lutto.

Ho impiegato tempo, traslochi e armadi,
piegato cento volte
le maniche,
cento volte schivato
i lembi, come tagliole;
non fosse mai che tu
muoia due volte
se butto via
la tua camicia.
(dalla prima stanza Sulla soglia)
Col preconcetto
che so avere, so
pensarti:
amorevole, un domani;
sorridente (stando bene);
a me accanto, se soltanto
io non fossi, o fossi un’altra.
(dalla seconda stanza Anticamere)
Mentre sbrinavo il congelatore
di tua figlia, un paio d’anni dopo,
ho trovato i tuoi cannelloni:
sul fondo,
batterici,
nell’urna di stagnola.
Con la scritta in corsivo incerta,
avevi decretato, vivendo:
“cannelloni/dicembre/duemilaeuno”.
Per un attimo ho pensato,
non potendo più amarti con le braccia,
di mangiarti.
(dalla terza stanza Dalla finestra, appena fuori)
È il tuo corpo inesprimibile, in cui pulsa
la pelle,
soda come le montagne
o le nostre
due bellezze,
debolezze;
risoluto, muto,
si compiace immobile
di accogliere,
come fosse
una tana, o una mano,
più che un luogo, è i luoghi
che non posso
toccare,
uno ad uno, non posso;
più che corpo, materia;
ma è il tuo corpo vivo,
non conosce le parole, a parlargli;
sembra capire solo
il verso della sete,
o i codici del pianto.
(dalla quarta stanza Nel cassetto)
Enrico Trebbi, L’incertezza del volo (Book Editore, 2017)
L’incertezza del volo (Book Editore, 2017) di Enrico Trebbi è una raccolta corposa, come scrive Alberto Bertoni in prefazione, e sebbene le poesie contenute all’interno siano state composte lungo un arco temporale piuttosto esteso (2004-2016) Trebbi ha mantenuto fede alla propria voce poetica. Prima delle sette massicce sezioni, che potrebbero essere intese ognuna come un singolo libro, troviamo un breve testo in prosa dello stesso autore. Centrali sono alcuni temi che poi ritroveremo come trame di sezioni e poesie: l’importanza della memoria, la presenza nella realtà e nel sogno del mare, delle paure e il lavoro su sé stessi che si intraprende per combattere queste paure, paranoie, angosce. Fondamentale, per l’autore, è stare bene con sé stessi, il che può essere raggiunto solo se ci si riesce ad ascoltare per accettare i propri limiti. Nei confronti dei vari temi affrontati da Trebbi, a volte sembra esserci una posizione apatica, convinta di una mancanza di senso. Specie in quelle poesie in cui l’autore torna indietro per ricordare avvenimenti e persone. Invece, nei suoi versi è costante la guerra con questa ingiustizia (appunto, la mancanza di un senso). Ciò fa sì che resti viva la speranza, e anche noi che leggiamo ne traiamo beneficio.
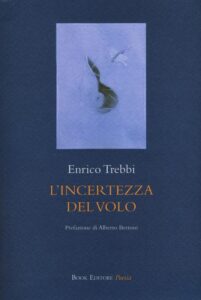
Tenerezze disabitate
Che cosa cerco qui
in questo abisso di dimenticanza
nel decadimento del legno e dell’intonaco
il serpentello morto di soffocamento
impigliato nella rete antizanzare
e tutte le velature dei ragni, la polvere,
gli elettrodomestici mal funzionanti
nidi di vespe e scorpioni rinsecchiti?
che cosa cerco nella desolazione
di questo luogo di tenerezze ormai disabitate
se non le nere voragini dell’anima
che la stagione precocemente invecchiata
rinserra tra confini di pioggia?
questa mia riserva di passato
così voracemente addentata
nello sfacelo progettuale
che mangia rose, muri
e tutti i petali del cuore?
(da I luoghi, le destinazioni)
Foglie secche
È una disciplina durissima e lascia segni
ingoiare ogni giorno porzioni eccessive
di un mondo così lontano dal proprio sentire.
Persa per sempre la speranza di un domani
diverso, resta l’astio, la cattiveria che corrode.
La ruggine inceppa i pensieri e non ci sono
orizzonti più larghi. Si vive acquattati
tra foglie secche e polvere, nell’arido autunno
dove non ardono ideali e si contano i giorni
a morire come fossero un sentiero salvifico.
La sera è l’unica pace, il desiderio di quiete
si appaga di tocchi e sussurri, le ore di luce
come una immeritata tortura passano lente
nell’anelito a chiudere anche questa giornata,
a correre verso la dolcezza della fine.
Eppure oggi, come ieri, spero in un lungo tramonto
nella brezza leggera che porti odore di pioggia
alla finestra della stanza e un ultimo barbaglio
ad esplodere e attardarsi sui vetri, prima che il sole
sia crepuscolo arancione d’ardori mai domi e letto
di teneri ricordi da portare in valigia per il solo
piacere di sfogliarli nell’inverno che viene.
(da L’anima e il male, le loro stagioni)
Crepuscolo
Questa sera a tavola
fino allo stremo della luce
mio figlio parla di Andrea
(l’amico morto
a poco più di vent’anni)
come a confrontare
il proprio dolore stupito
con il mio, immane e preventivo.
Parole come pietra.
Non è più il tempo degli abbracci
che tutto cancellano il male
in un vuoto di puro calore,
oggi che le prime fratture
incrinano il cristallo
della tua giovinezza.
Questo è
diventare grandi.
ROCÍO BOLAÑOS
(MALVONI, STORNI, ANTOLOGÍA DELLA POESIA LATINOAMERICANA D’OGGI)
Elisa Malvoni, C’è un sacco di spazio sul fondo (Edizioni Bette, 2022)
C’è un sacco di spazio sul fondo di Elisa Malvoni (Edizioni Bette, 2022) è una raccolta di poesia che ha il potere di dare significato a dettagli apparentemente insignificanti, descrivendo minuziosamente la realtà trascurata legata a luoghi, ricordi e tradizioni. Una prospettiva scrupolosa di una diversità di immagini attraverso una poesia sintetica che trasmette il piacere creativo dell’autrice. La poetica dell’autricice invita a interrogarsi sul senso delle cose, a vedersi come da fuori della propria finestra. «Anche senza i fuochi / ci saranno le luci». Riprende tutti i ricordi per non farle scomparire, per sentirli di nuovo e lascia partecipare al lettore del silenzio successivo, fissando figure e scenari quasi come un cortometraggio del quale lei è la regista. I versi mettono in tranquillità il lettore, anche di fronte a frammenti di vita che raccontano momenti che «sorvolano oltre il balcone / qui dove stiamo a deambulare» e creano sotto molti aspetti un distacco premuroso seppur si sia sempre lo stesso, nel fondo.

Lockdown
Nel 2042
racconterò delle chiusure.
Di quando c’era abbondanza di tutto,
di inventiva e di coscienza,
di quando nel temporary store
aperto per il tempo sospeso
abbiamo trovato copia persino
di farine e di mascherine
assieme
sullo scaffale delle rime.
Questi muri
Senza eros
né pensiero
non li accarezza nemmeno il vento.
Non asciuga più i colori dei vestiti
stesi a spatolate,
stesi all’estate,
non penetra il vaso muschiato
abbandonato a settentrione,
ma sì le vele sbrindellate
dopo un naufragio di donna
e ragnatele polverose.
In poltrona
Vissero infelici
perché costava meno
infilare turni identici
come perline per gioco
che dar valore al poco
del tempo che rimaneva
fra l’uscita e l’entrata
dell’ennesima giornata
fondata sul lavoro.
Alfonsina Storni, Poemas de amor (Edizioni Casagrande, 2023)
Alfonsina Storni è una delle figure più significative della poesia latinoamericana del Novecento, nata nel 1982, originaria del Canton Ticino ed emigrata poi, assieme alla sua famiglia, poco dopo la sua nascita. La sua produzione letteraria comprende opere teatrali, racconti per bambini, poesia e prosa.
Poemas de amor (Edizioni Casagrande, 2023) è un viaggio nella vita della poeta che ruppe schemi tradizionali, estetici e sociali, la prospettiva di una donna audace che riuscì ad ottenere la sua indipendenza anche come scrittrice. Un volume bilingue che ricostruisce il percorso dei componimenti di Alfonsina Storni, pubblicato inizialmente nel 1926. Un libro arricchito con illustrazioni, testi in prosa poetica che raccontano senza filtri l’innamoramento, l’abbandono, la passione, i suoi pensieri d’amore, le voci, le emozioni e anche le sue paure, l’agonia, passo dopo passo fino alla sua fine volontaria.
Una nota importante da sottolineare è la traduzione, che rispecchia con fedeltà i testi in lingua originale; sono state corrette alcune imprecisioni della prima pubblicazione e i testi sono stati adeguati alle regole attuali della lingua di partenza.

XX
Venite a vedermi. I miei occhi rilucono e il mio volto si è trasfigurato. * Se mi fisserete bene, vi tatuerò negli occhi il suo volto che porto nei miei. * Lo porterete impresso lì finché il mio amore non dissecchi e l’incanto si spezzi.
XLV
Gravida di te alzai gli occhi al cielo e lo vidi gravido di mondi enormi che, per non sgomentare gli uomini, fa intravedere piccoli, luminosi, inoffensivi al triste e timoroso sguardo umano.
LV
Una sera, passeggiando sotto grandi alberi, sopra un guanciale di terra giallognola, soffice come farina stacciata, mi accadde di guardare il cielo. * Lo percorrevano sottili, immateriali nuvole bianche ed io mi intrattenni, con esse e in esse, a tracciare le fattezze del tuo viso.
Antologia della poesia latinoamericana d’oggi (Di Felice Edizioni, 2022)
Una raccolta esaustiva della poesia latinoamericana, un’opera che traccia la continuità dello spirito che accomuna diciannove nazioni lungo gli ultimi sessant’anni, circa, a iniziare da Ida Vitale (1923) fino a Javier Alvarado (1982). È doveroso sottolineare che l’Antologia della poesia latinoamericana d’oggi (Di Felice Edizioni, 2022) è una proposta in stile campionario della diversità e ricchezza poetica che si è vista emergere nel panorama dell’America Latina. Questo volume raccoglie ottanta poeti, con una scelta di testi sufficienti per dare al lettore una prima visione anche dello scenario lirico del passato più vicino ma, soprattutto, del lavoro puntuale di poeti e poete che portano avanti una personale evoluzione partendo dalla tradizione, indagando nelle radici della parola dei padri e delle madri della poesia. Attraverso i poeti inclusi all’interno di questo lavoro a cura di Emilio Coco, si evidenzia e riconosce l’altissima qualità e l’importanza dell’opera poetica made in America Latina. Uno stimolo anche per i critici che potranno approfondire e integrare per comporre una mappa della poesia latinoamericana.

Nicaragua
(Daisy Zamora, Nicaragua, 1950)
Questa piaga aperta nel mio fianco
ha un nome che non devo dire.
Se lo dimenticassi, la ferita guarirebbe
e per questo lo taccio.
Ma addormentata, in sonno
‒ senza volerlo ‒
a volte lo pronuncio.
Vincolo invisibile
(Renée Ferrer, Paraguay, 1944)
Non ho età.
Non la vivo, né mi angoscia.
Dentro sono sempre la stessa.
Mi avvicino alla tua guancia e vi lascio
un sussurro di carne
che trema nel tuo tepore.
Il mio riso lava ingiurie.
Capisco che non esistono.
Che non sono mai esistite.
Siamo così limpidi
in questa istantanea equazione d’incontro.
Il cielo si copre di compiute tenerezze
che da noi si alzano per illuminare la notte.
Incastri di lucentezza fissi come fari che pulsano.
Mi rifiuto di dare udienza ai rancori;
non do un nascondiglio dove proteggere le loro spine
cancro di asfissia nera,
morso.
Non naufragherò nei tuoi pantani.
Non so cibarmi di silenzio,
né lesinare sorriso.
So solo di avvicinarmi,
senza tempo e senza belletti
– mio uguale, mio diverso –
per sentirmi legata dal vincolo invisibile
che tende la poesia.
Chiesuola
(Cristina Peri Rossi, Uruguay, 1941)
Non conosce l’arte della navigazione
chi non ha vogato nel ventre
di una donna, remato in essa,
naufragato
e sopravvissuto in una delle sue spiagge.
ALESSANDRO CANZIAN
(RUEFF, CESCON)
Martin Rueff, Icaro grida in un cielo di creta, Samuele Editore-Pordenonelegge, 2023
Tutti conosciamo la storia di Icaro, caduto dal cielo dopo essersi troppo avvicinato al sole. Martin Rueff, traduttore, poeta, filosofo, accademico di fama, ha raccolto con un atto quasi artistico quest’Icaro cadente ascoltando la sua caduta in mare, il suo affogare. Laddove la morte diventa estremo contenitore di vita e pensiero, di poesia, di letteratura anche, in piccole bolle che emblematicamente risalgono alla superficie. Cosa ovvia, priva di importanza, eppure fondamentale. Tali bollicine di letteratura salgono non a esplodere il senso della morte, ma a contemplarla con la pietas di chi sa che ascoltando è possibile rintracciarne un senso. Perché il morire non sia vano, né sia vano lo strumento poetico capace di cambiare forma, di seguirne le membra, le intenzioni disattese. Icaro grida in un cielo di creta è di fatto un dialogo perché suggerisce al lettore di ascoltare, di riflettere, fino ad arrivare all’atroce contemporaneità in Un Icaro Ucraino. Titolo che, come piace dire all’autore, in francese (lingua originale del testo), non è traducibile in quanto si perde l’anagramma tra Un Icaro e Ucraino. Che è più di un anagramma ma già un approccio, una sofferenza. Icaro cade, continua a cadere, come un figlio profondo.

Icaro XII
Nuoto scorsoio
Sullo sprofondare
sprofonda figlio profondo
Dedalo
portato via dalle correnti verso il filo spinato delle lettere scure
caduto nei roveti delle consonanti indurite
alla fine della corsa
Icaro sprofonda sulla sua corona di spine
di W coralline
crudele trespolo di X
doppie punte delle K e delle V
quando la H degli abissi lo trafigge
come il grande erpice che rastrella la sabbia
inscrive la sentenza dell’imprudente
proprio sulla sua pelle raggrinzita dall’acqua –
Noli altium sapere sed time
intoppi derivanti per un
San Sebastiano che galleggia male
conficcato nel suo percorso tracciato
da esche all’inverso
che ogni respiro affonda un po’ di più:
le gutturali sottomarine t’offrono un sogno addolcito
Icaro,
come il dorso dei muschi
ma i dentali ti uccidono, ragazzino
l’anima sorella di una L ti schianta al suolo
mentre dalla coda d’un occhio umido
la gola presa dalla saracinesca di una t minuscola…
contempli piangendo l’arpa molle di un ciuffo marino…
… piantato sul suo letto di corallo
Icaro piange nella culla delle onde
disteso nel fondo delle acque
sul suo letto di corallo sangue
il figlio fachiro singhiozza
un bouquet di rami
conficcati nella schiena
un bouquet di rami
per trattenere la sua deriva
per trattenere i suoi rimorsi e i suoi sogni
povero piccolo nenufaro tutto ribaltato
con le sue radici all’inverso
e le sue grandi corna di cervo come unico giaciglio
Icaro piagnucola tra le acque
le sue lacrime salate mischiate ai singhiozzi del flusso
risalgono come delle bolle rosee
tra le fiamme scure dei suoi capelli
e i suoi dolori diluiti
come ricordi sfumati
«Mi sono risvegliato sotto un grande cielo di mare
Il suo mantello è pesante e le sue tasche enormi
Mi sono risvegliato sotto un grande cielo di mare
un millefoglie nauseante in lingua cuneiforme
Mi sono risvegliato… sotto un grande cielo amaro»
Icaro singhiozza
volto imbrattato
sorriso confuso
batiscafo emotivo
in apnea solitaria
piange
sul suo volto sciacquato
ha indossato il suo abito di acquemarine
così largo e così ampio
con le maniche spalancate
come in un travestimento
di principe di kermesse
ha passato
l’età di tutte le bevute
e dei brindisi funebri
e l’anello dei matrimoni di mare…
«acqua pura mia sposa
tu fumi dal mio ferro rosso»
Icaro, Icaro nel fondo delle acque
come una volta nel bagno
a giocare al rallentatore
sotto le anatre di plastica rosa pallido
e le bolle di sapone blu
come una volta nel bagno
a immaginare che la sua acqua fosse di lacrime
o che i suoi occhi si annebbiassero nella vasca
e come al solito
solo come si è soli nelle proprie leggende
solo
ad aspettare le sirene
Icaro sottomarino
Narciso al rovescio
fiato mozzato
sotto il suo mantello scuro
di ampi fogli d’acqua
come poco fa per attraversare la vita
senza respirare
(Papà guardami, papà guardami sulle strisce azzurre
e le piastrelle chiare come degli incendi bianchi*)
Icaro silenzioso
Icaro senza melodia
Icaro sprofondato
col cuore scavato dal corallo
e dalle dita rosse pieno nei fianchi
ribaltato sotto il doppio peso del cielo e del mare
si mette a sognare di meduse e di pesci pilota
sogna di sognare piuttosto
o che qualcuno sogni per lui
al suo posto
«Meduse cara meduse
nuvole sottomarine
in gonne di lavanda
meduse dall’istinto gregario
che il vento delle acque orienta
io peso meno di voi
mi ricordo quei versi così belli come una canzone
mi ricordo quando la poesia…
Mi ricordo che… la poesia… mi trasportava
«au bain terrible des étoffes se pâme»
mi ricordo non mi ricordo più
mi ricordo non mi ricordo più»
e
«Piloti, pesci pilota
Chi vi conduce chi ci guida?»
e
«Carne profonda, carne fredda delle onde
Le tue carezze fuse mi hanno afferrato
Afferrato il tuo bacio profondo
E il tuo freddo labirinto»
fuggito sotto un testo marino
Icaro anche glauco e fangoso
sonnecchia in un formicolio di lettere
in una nota a piè di pagina
la grande barra sulla fronte
Pensare che una volta per me tutto era gioia
sotto il mare
amavo le giravolte tra le bolle
l’ampiezza dei movimenti
le piroette scivolate
al livello delle acque
e le lente capriole acquatiche
sui grandi trampolini
volavo libero dal peso della terra.
Ora che la vita ha ripreso il sopravvento
muoio inchiodato sul fondo delle acque
sotto l’occhio impaziente di una murena.
….
E
mi ricordo di come ti ho insegnato a nuotare
è stato in una baia bianca
costeggiata da dei grandi pini
avevi aspettato che la spiaggia si svuotasse
niente pubblico, niente pubblico
(come quando danzavamo nel salone…)
il mare era verde come lo amavi
il mare era verde e calmo
ti eri tolto il vestito…
… il tuo costume arancio…
illuminava la tua pelle bruna
… saltimbanco gracile
del quadro di Pablo
eri scivolata nella sera tiepida
i tuoi piedi appoggiati sullo sciabordio
hai guardato i fregi
pulchritudo vaga
non amavi le alghe scure…
amavi vederci chiaro
amavi vederci chiaro
did you ever go clear?
e
Roberto Cescon, Natura, Stampa2009, 2023
In Natura di Roberto Cescon (Stampa2009, 2023) immagini e riflessioni si intrecciano e interconnettono in una trama complessa che introduce il concetto di “continuo disfacimento degli eventi”. Se da una parte l’autore esplora vicende e relazioni prettamente personali, spesso affrontando la loro dimensione problematica e intima, da un altro punto di vista indaga il significato della poesia come voce che identifica (o non identifica) interrogandosi sull’origine del linguaggio, passando con agilità dalla parola dei grandi autori alla saggezza dei primitivi. Si snoda in un percorso originale che abbraccia incisioni rupestri, esplorando tempi remotissimi in diverse circostanze e luoghi suggestivi. Un viaggio poetico attraverso l’umanità nel susseguirsi preistorico e storico della sua mutevole natura che dichiara, nemmeno troppo velatamente, una disillusione sul mondo che non si apre. La ricerca dell’origine quindi appare non più come una ricerca di scoperta, ma conferma di un percorso che il verso è stato già in grado di identificare, e accettare. Che sia verso o prosa breve. Con l’indiscussa maestria di chi sa stare sull’orlo, sul confine, al di là del quale resta solo lo sguardo e la voce.

Sono i piedi nell’acqua e l’onda nuova
arriva negli occhi e non finisce
quante parti di te
nella sabbia e nel mare antichissimo
che in un tempo vasto che non vedi
avresti visto spaccato da rocce
e poi rocce spagliate dai fiumi
sfarinare in questa sabbia
e segni a non finire
nell’aria di opere e intenzioni
si parlano da un prima che verrà
adesso, altrove
mentre il sole sposta l’ombra
attorno a te esseri antichissimi
partoriti da millenni, millenni di volte,
come tutte le altre volte sono qui
quante parti di te e di loro sono state il mare
adesso, nella luce
dove trovarti
fuori dagli occhi.
Alla fine della strada aspetti
di vedere perdersi il tuo occhio
nel giallo sovrastante della colza
l’hai visto e lo stai vedendo
cosa ti commuove di quel giallo
nel verde, e resti ancora qui
o sei già nel giallo? E la mia voce
la vedi, nel giallo? La senti,
sei tu, nel giallo, e non c’è tempo
sto aspettando da un silenzio che è tuo,
è stato mio, sarà tuo.
Libertà, ma davvero
provi a immaginarla
nelle moltitudini che chiedono
incompiute e originali, anche tu
un tempo l’hai creduto, ma quanto te ne serve
per uscire dall’eterno
della scena che rincorri nella mente?
Magari la confondi con il desiderio
ma l’altro, le parole che pronuncia
sono per un altro, che non è qui
e forse neanche esiste, e voi, a tratti
lo intuite, siete ignoti l’una all’altro.
Tu sei questo corpo che spicca dalla terra
quando senti il profumo
di un dolce dal forno per l’indomani
magari sotto un porticato, d’estate…
ma dove vuoi andare
che qualcuno ti tira sempre giù…
Potresti dire che tutto accade
nel tempo in cui viviamo, ma è lo spazio
delle tue parole che fa diventare tempo
lo spazio tuo e degli altri.
Vorresti l’altra luce
che intuisci dal contorno dei palazzi
ma fissi i panni stesi, un oleandro
sotto il cornicione e questo muoversi
di tutti e di ciascuno
nel continuo disfarsi degli eventi.
Guardali, li vedi tutti così
organismi muoversi nello spazio.
Nei loro volti, nei loro amminoacidi
chissà da dove vengono
generazioni di esseri umani
fino a un principio
che non riesci a vedere.
Abitano case, mangiano seduti, fanno figli
come tutto fosse irripetibile
e lo è, perfino un momento come questo
nel succedersi di luce e venti
sopra noi, che qui mangiamo stasera.
Non pensi la tua mente
che cambia per restare in equilibrio
sempre in un istante e in tutti gli altri
come questo, e senza storia si ripete
nelle menti di chi vive finché vive,
e dopo ancora, più forte di noi?
Dici prima nella mente, prima del fiato
che esce grazie al controllo prefrontale
e ai muscoli, decine, poggiandosi nell’aria:
prima, sentire la vita di ciascuno
e di quanti nei tessuti e negli impulsi
sempre gli stessi, gli stessi di sempre.
