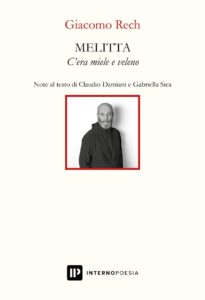
Melitta, C’era miele e veleno, Giacomo Rech (Interno Poesia, 2023).
Il libro
Metà donna e metà ape dalla vita in giù, Melitta è negli antichi miti nome di ninfe e di figure femminili. Simbolo di fertilità e di immortalità, intimamente connessa con l’anima, legata alla terra e alle sue insondabili profondità l’ape è anche un ponte con l’oltretomba. Rech non scrive un trattato di apicoltura. Sospeso sulla soglia di un alveare, lo sguardo puro e concentrato del poeta si posa sulla natura, esplora l’intelligenza delle api sui molti piani che la complessità della loro lingua gli consente, ascolta e parla con loro. Libro di apparizioni e metamorfosi, riflessione sulla eternità della memoria e della poesia, qui l’ape anche s’indonna, è «ragazza generosa», capace di dolcezze e di furie spiritate. «Melitta insieme succia e dà tormento / molce e minaccia. E non è abisso lieve». Come il poeta, ha voglia «di nominare il mondo e ogni sua gramma / voglia di fare». Ragazza di strada, ma anche Regina apium, è naturale identificarla con la divinità stessa. E Melitta ci risponde e ci conforta.
L’autore
Giacomo Rech è romano (1956), con forti radici a Feltre. Giurista, svolge lavoro editoriale presso la Commissione nazionale parità e quello di regista e autore in RAI. Nel 1978 a Sant’Agata de’ Goti, spazio romano di giovani poeti e artisti, conosce Claudio Damiani e Beppe Salvia e i pittori Felice Levini e Pino Salvatori. Negli anni ’80 è attivo nella redazione di Prato pagano, rivista di nuova letteratura diretta da Gabriella Sica, “l’unica vera che ci venga da Roma”, gli scrive l’amico Andrea Zanzotto. Tra i poeti romani Rech si distingue per la sua profonda preparazione classica, da vero umanista. Scrive prose, traduzioni e testi teatrali, dei quali Diana è rappresentato nel 1986 all’Accademia di Francia di Villa Medici. Pubblica Firmamento (Abete, 1988) il suo finora unico libro di poesia. «Trovo assai interessante quella sua ambizione di classicità» – gli scrive Giovanni Giudici – «temperata da una ironia lessicale che la fa decisamente moderna». Nel 1988 è invitato alla Fiera del Libro di Francoforte dedicata all’Italia. Nel 1995 traduce l’Arte poetica di Orazio, il primo libro di Fazi. Dopo di allora si isola per quasi trent’anni, durante i quali lavora a questo libro di poesia.
La metafora delle api
Conobbi Giacomo nel 1978 a Roma a Sant’Agata de’ Goti, uno spazio “autogestito”, come si diceva allora, da un gruppetto di artisti e scrittori ventenni (c’erano, oltre al sottoscritto, Giuseppe Salvatori, Felice Levini, Arnaldo Colasanti, Paolo del Colle, Marco Lodoli, Antonio Capaccio, Mariano Rossano, Stefano Donati, Vittorio Messina, Tommaso Massimi, Edoardo Albinati, Valerio Giannetti, Marco Canevari). Avevamo messo un annuncio su un giornale in cui invitavamo coetanei artisti e scrittori a confrontarsi con noi. Non ricordo se in quell’invito c’era già scritto qualcosa in merito alla nostra insofferenza per lo stato dell’arte, e del tempo che vivevamo. Un tempo superbo, separato da passato e futuro, isolato dal mondo, e dal tempo. Sentivamo che mancava la vita, e la lingua, che l’arte non era libera. Fuori imperversavano gli anni di piombo, spari, violenze, bombe, lo Stato sotto assedio, e la comunità anche, e la cultura. Era il ’78, l’anno di Moro. Avevamo desiderio di chiuderci in una stanza bianca, in silenzio, e ascoltare. Avevamo desiderio di silenzio e di ascolto, di studio. L’arte del passato non appariva, a noi, fra virgolette, come s’usava pensare allora in quell’epoca concettuale e concettosa, superba e ignorante, l’arte non era “espressione del suo tempo” come recitava l’ideologia, ma lo investiva il nostro tempo e lo sfasciava e smembrava, e dava segni di ricostruirlo e crearlo di bel nuovo. I classici antichi (latini, greci, rinascimento italiano, orientali anche) messi tra parentesi dalla cultura ideologica e avanguardista, ci apparvero più nuovi del nuovo, entravano nella nostra vita, la sconvolgevano e la cambiavano, era come rivedere terra dopo tanto navigare affannoso, e, insieme ai classici, appariva ai nostri occhi la lingua, senza la quale non c’è arte, né vita. Non più le cosiddette “poetiche” ci interessavano, isole di egoismo e presunzione, ma la lingua viva e pensante, che andava capita e compresa, prima di tutto ascoltata. Non dovevamo “sperimentare” istericamente spezzettandola e violentandola, come molti facevano, come su un tavolo di vivisezione, ma dovevamo ascoltarla, e lasciarla parlare. Riscoprivamo D’Annunzio (Salvia specialmente), Pascoli e Petrarca, e la musica meravigliosa e indicibile della nostra lingua. Non ci sentivamo più in colpa di avere una lingua meravigliosa, melodiosa, anzi ne eravamo orgogliosi. Sentivamo che per dire la vita, che urgeva come un animale selvaggio dentro di noi, ci voleva una lingua, che dovevamo imparare.
Giacomo Rech lesse l’annuncio e venne, collaborò con noi. Il suo apporto non fu da poco. E venne anche, sempre leggendo l’annuncio, Beppe Salvia.
Dopo Sant’Agata ci fu Braci, otto numeri dall’80 all’84, in cui era entrato Gino Scartaghiande, un po’ più grande di noi, che aveva esordito come neoespressionista ma si avvicinava ora al nostro classicismo. In Braci Rech non è presente, occupato per lavoro lontano da Roma, come anche Pietro Tripodo, che era già comparso anche lui a Sant’Agata. Ritornano tutti e due in Prato pagano, rivista diretta da Gabriella Sica, coadiuvata da una redazione di fatto in cui Giacomo è in prima fila, assieme a me e Beppe Salvia, e vede spesso la collaborazione anche di Lodoli.
Giacomo apre il primo numero di Prato Pagano con gli Hendecasyllabi beati di Pontano, che traduce. Amavamo i poeti umanisti. Tripodo tradusse in quei numeri Poliziano, Marullo e il Pascoli latino (di cui intraprese poi la traduzione integrale, interrotta dalla morte prematura). Imbustati dentro la rivista uscirono quattro volumetti di poesie, tutti primi libri: Estate di Salvia, La famosa vita di Gabriella Sica, il mio Fraturno, e Firmamento di Giacomo.
L’ultimo numero di Prato Pagano è del dicembre 1987. Poi in una collana curata da Arnaldo Colasanti per l’editore Rotundo usciranno Salvia, Del Colle, Giuliano Goroni, Scartaghiande, i primi libri di Silvia Bre e di Aurelio Picca.
Ma dal suicidio di Salvia nell’85 comincia una certa dispersione, ognuno va per la sua strada. Giacomo è un po’ appartato, ma quando nel ’95 apre i battenti la casa editrice Fazi (Elido era nostro amico e sodale già da anni) è lui che firma la prima uscita, l’Ars poetica di Orazio, la bibbia del classicismo.
Poi Giacomo tace, non pubblica più niente. È un lathe biosas (vivere nascosto) molto classico, fedele a quel desiderio di silenzio e di ascolto di cui parlavo prima, e che non è stato solo di Rech ma di altri anche: Giuliano Goroni che a fine anni ’90 ritornò nel suo piccolo paese nelle Marche e non si sa se scriva e che cosa, sicuramente cose bellissime, e Gino Scarthaghiande e Giselda Pontesilli, ambedue molto appartati.
E dopo questo silenzio, maturato, anzi distillato in questo silenzio, ecco Melitta.
Ritrovo in questo libro l’amore antico di Giacomo per le api, metafora di una vita minima e luminosa, una vita allo stato elementare e piena di vivacità, e insieme intelligenza. Natura pensante e cooperante, provvida e produttiva, positiva e previdente, conservativa, benefica, generosa e coraggiosa (“c’è un grande coraggio in quei piccoli cuori”). Le api che oggi soffrono, e la loro sofferenza, in quanto impollinatori, si riversa su tutta la natura, e su noi.
Le api su cui Virgilio scrisse meravigliosamente nelle Georgiche, come una comunità ideale e pacifica, un sogno per l’umanità. Lui figlio di un apicultore, che le aveva osservate e amate fin da bambino, e si era nutrito della loro bellezza. Le api del Rucellai, poeta umanista quasi dimenticato, e amato da Giacomo. La donna-ape dell’antichissimo Semonide di Amorgo (“con lei la vita è tutta fiori e frutti”), che chiude quella satira famosa contro le donne che Leopardi tradusse (calcando la mano) e Saba riformò (con la poesia A mia moglie), e Giacomo anche in questo libro traduce.
L’ape è anche, per Petrarca, il poeta, che prende da tanti fiori diversi ma poi produce un miele unico e inimitabile, diverso da tutto.
Giacomo, in una sorta di adolescenza perpetua, o in un ricordo di adolescenza, ama Melitta, un’adolescente ape bellissima (tota pulchra). Ma l’ape punge anche, e vola, e è difficile acchiapparla. E a un certo punto vola a Londra. Giacomo è contento anche solo di sentire la sua voce registrata alla segreteria telefonica (“ascoltarti mi dava / tanta energia e pace”).
Ecco, c’è malinconia in questo libro, ma anche la forza che ci dà l’amore, anche se incerto e non corrisposto, fine a se stesso come insegna Dante. La forza e la pace che ci dà la bellezza che è nella natura, anche nelle sue parti più piccole e meno appariscenti, che ci spiazza sempre e sorprende.
La natura inconoscibile e imprendibile, che pensa e sa più di noi, indistruttibile e tremenda: stando lontano da lei, ci dice Giacomo, abbiamo solo dolore; ammirandola, curandola, coltivandola, come Virgilio con le api, abbiamo forza e pace.
Claudio Damiani
Sunt mihi sex apium crebrae prope amoena vireta
Gentes, qua riguam pinus obumbrat aquam.
Paulus Segato
Io ho sei api, ragazze generose
in un bel praticello tutto verde
dove un pino fa ombra a una sorgente
di acqua buona per irrigare i campi.
Di un solo verso si accontenta Agilla
che per me è la più quieta e laboriosa:
le piace coi colori
dei fiori disegnare
percorsi aerei da un celeste all’altro.
Thellusa è un po’ che non la vedo
deve impastare la cera
poi costruire i fiali
staccare il polline dai vegetali
piglia, trascina, leviga e pulisce
indaffarata.
Attica è abituata ai grandi viaggi.
Risale la corriera
lenta la china: il diesel
la nafta in fumo nero
pompa e in un rombo che indietro mi torna
-“Ferma
sto attraversando sulle strisce, ferma!”
Attica riede. Conversione ad u.
Ambra e Amatusia stanno sempre insieme.
Dove passano loro
anche le piante sono più felici
danno più semi e hanno più vigore
vegetativo.
Come tra tutte le donne una sola
è buona, quella somigliante
all’ape, secondo la opinione
censoria di Semonide, io dico:
tra tutte le api una è la migliore
Melitta, che assomiglia ad una donna.
Bottinatrice, la caccia del miele
da saccheggiare alle sue scorribande
nel più solivo anfratto cellulare
del cuore mio
un arnaio ha impiantato, pungitivo.
Eccome ne ho paura se ora con l’ago
una vena mi piglia e mi avvelena
se ora mi lascia secreto dolcissimo miele
dal sudato liquore dei suoi baci!
Melitta insieme succia e dà tormento
molce e minaccia. E non è abisso lieve.
L’ape non è la vespa
che punge quando vuole, t’invelena
e dopo vola via. L’ape
punge una volta sola e dopo muore
lasciandoti il suo ago nella pelle
togliendoti così anche il gusto
della vendetta.
A me piace riparare le cose
che sono rotte e quasi sempre ci riesco.
Ricollego i fili. Chiudo le perdite.
Stucco, avvito, metto zeppe, pianto chiodi
meglio aggiustare che buttare via.
Mi piace fare da me tutti i lavori
e appena vedo qualcosa che non funziona
cerco di ripararla, ovunque sia
m’ingegno con quel poco che ho e ce la faccio
quasi sempre.
Soltanto non riesco ad aggiustare
questo nostro legame
questo filo sottile
che c’era un tempo e adesso si è spezzato.
Questa dissipazione è contro
la mia natura.
