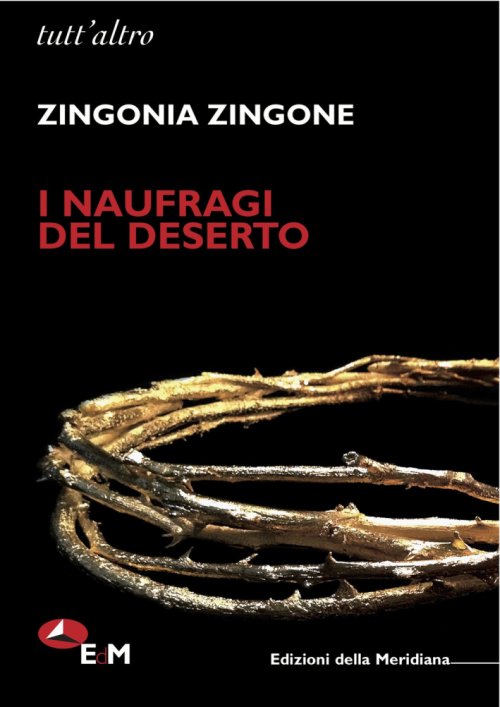Che la letteratura di questi anni ci stia consegnando, dal punto di vista della scrittura femminile, libri che sono veri e propri capisaldi della letteratura contemporanea, è cosa di cui ci eravamo già accorti. Per citare qualche titolo italiano potremmo chiamare in causa Olimpia di Luigia Sorrentino (ne ho parlato qui), Parva naturalia di Sonia Gentili (e ancor più l’opera che sta ancora scrivendo sul Minotauro), Il numero completo dei giorni di Giovanna Rosadini (qui), l’ultimissimo La fine di quest’arte di Silvia Bre (qui), e il bellissimo Serie fossile di Maria Grazia Calandrone (qui). Non a caso la succitata Giovanna Rosadini nel suo Nuovi poeti italiani (Einaudi 2012) coglie dal mazzo di questo periodo solo voci di poete.
In tutto questo leggere I naufragi del deserto di Zingonia Zingone (Edizioni della Meridiana 2015) significa confrontarsi con un capolavoro che si inserisce a testa alta in quella che (forse) potremmo già chiamare una tradizione. Un inserimento che però, per quanto riguarda il panorama nazionale, avviene di striscio. Perchè l’autrice, cresciuta tra l’Italia e il Costarica, sceglie come lingua letteraria lo spagnolo e I naufragi del deserto appare in Italia in traduzione a cura di lei stessa e Pietro Federico.
Il prefatore Davide Rondoni così introduce il volume: Poesia sapienziale o autobiografia in gran velame? Cosa ci dona questa poetessa cosmopolita e avventurosa, con i tre quadri scanditi dai versi dell’antico poeta scettico ed elegante? Cosa si celebra, con andamento sontuoso e visionario nei tre quadri, le tre figure? La vita cerca la vita, e nei tre racconti, malinconici e luminosi, Zingonia Zingone crea tre ritratti di figure immerse nel rischio della vita che può perdersi, che può essere cancellazione del destino invece che suo compimento. Giustamente sottolineando l’impossibilità di capire quanto autobiografismo ci sia tra queste pagine (anche se il dubbio resta che, tale interpretazione, sia un po’ una brutta necessità tutta italiana) che fanno del mito, di tre miti, il loro filo conduttore.
In realtà i tre miti, o meglio i tre personaggi che nelle loro rispettive storie creano dei piccoli miti, sono nell’avvicendarsi dei versi sempre più un elegante quanto delicatissimo pretesto per evocare (più che raccontare) la complessità delle storie umane, il loro controverso riconoscere come motore immobile il desiderio. Un desiderio che fa perdere e ritrovare le strade delle vita, che è chiaro e buio, rosa e satiro.
Tre sezioni intitolate: L’oracolo della rosa, Le campane della memoria, Il fiume nascosto, nelle quali si presentano rispettivamente Khalil, Soraya, Bâsim. Khalil è il principe schiavo del desiderio d’amore: Guarda negli occhi cristallini dell’alba / e la rosa non è una rosa, lui non è un principe / e l’abbraccio fu soltanto e non è più, ora. Un desiderio che è tanto pregnante quanto sintomo di smarrimento di sé nell’assenza dell’amata, del suo corpo: Afferra tre monete perforate, / le lancia nel vuoto e cerca / nel grande libro delle mutazioni: / trova luce e tenebre. Il naufragio dell’uomo è in questo caso il mistero della donna: La tempesta nasce da un’ira divina. / Khalil viene dal deserto e sa / che la donna è un mistero velato. […] Khalil è un uomo del deserto / dove il destino è nomade / e l’ira divina si scioglie / nella danza delle urie. La capacità di Zingonia di evocare, di far sentire, la profonda sensualità del desiderio, le sue enormi e ipnotiche sfaccettature, ha del magistrale: Abbraccia la ragazza, affonda la disperazione / nella morbidezza di quel seno. / Il principe vuole vincere la battaglia, / ma non sa come, e più avanti Di labbra, lei gli sfiora i piedi. Fino al testo conclusivo della sezione che riprende la metafora portante di queste pagine, la rosa (in realtà tutto il libro si appoggia a dei simboli chiave), in un’immagine polivante ma sicuramente densa dell’erotismo orientaleggiante a cui Zingonia chiaramente si rifà: Lui bacia i piedi / a sostegno del mondo: / le fragili, eterne dita dell’amore. / Si unisce allo stelo, consegna / la sua linfa, libero. Nutre / con tutta la sua esistenza la sua / bianca rosa.
Segue poi la storia drammatica di Soraya, bambina abusata dal padre e poi venditrice di se stessa. Una bambina che vive le zone più oscure del desiderio umano: La casa è la sua tomba, e più avanti La risata tra i denti, i denti / tra le cosce; il forare del ribrezzo / nella fessura che conduce all’anima. […] Intorno si sente l’orrore / il silenzio complice. La complicità del silenzio dà tutta la dimensione della tragedia di Soraya che Zingonia senza dubbio condanna pur arrivando a dire: Come ripudiare / il satiro che abita nell’uomo?. Ma come esistono le zone di buio anche la luce, in qualche modo l’ascesa (spirituale o meno), ha la sua possibilità d’essere: È il primo uomo che non la guarda. / Soraya si china e si siede, / la schiena dritta / e i sonagli silenziosi del ventre. Soraya incontra un uomo che non la può vedere e per questo lei si sente più guardata, più osservata in verità e liberazione. Ritornando al concetto di desiderio della prima sezione del libro: Soraya sfiora i piedi del cieco / con il deserto del suo sguardo (i piedi sono un elemento erotico ricorrente). La liberazione di Soraya è sostanzialmente un ribaltamento dell’oscurità in luce, una trasformazione del dramma in altro, come ad esempio il silenzio che prima è complice dell’orrore e in chiusura accompagna l’ascesa. Un’ascesa che però non è salvezza nel suo significato più superficiale, da lieto fine, ma più un’ascesa spirituale del desiderio stesso, una sua salvezza: In una chiesa d’oriente / le campane colpiscono il ventre del cielo.
Nella terza sezione ritorna una figura infantile, il bambino Bâsim, che presenta la realtà del desiderio come mancanza di sua madre per suo padre. Un desiderio che è vivo nello specchio della carne viva di Bâsim, che ne è ricordo, e nostalgia: I suoi silenzi, i suoi sospiri; / il desiderio le apre il volto / profumata rosa del deserto. E più avanti: Dalla sabbia Bâsim / si domanda perchè. Un gesto inesplicabile. / Una madre in apnea. Il figlio è l’incarnazione stessa di quella passione, anche nel momento in gioca e il desiderio è in quel gioco di bambino: Il palpitare di una madre nel deserto, / il gemito sepolto nella sabbia. […] La dimensione del tempo in bilico / tra la stella della sera / e un bambino che grida “campana!”. La stupefacente capacità di Zingonia di evocare la sensualità umana tocca in questa sezione un livello tanto intenso quanto commovente. Perchè Bâsim è un bambino ma è anche la lunga tela / che giorno dopo giorno tesse in silenzio sua madre (quel medesimo silenzio che in Khalil era segue il silenzio, in Soraya complice dell’orrore e poi compagno dell’ascesa). Quello stesso bambino che di fronte a uno scorpione in fuga si domanda perchè. Un gesto inesplicabile. / Una madre in apnea. Bellissima immagine che inevitabilmente riporta al padre lontano e alla mancanza di lei per lui. Il deserto ostacola il cammino / e la trasparenza, fino all’incontro con ciò che è non-deserto ovvero un fiume irredento del desiderio che segna la strada per oltrepassare quelle dune del naufragio: Se il fiume esce dal tempio / dà vita ai suoi argini aridi, / risana le acque del mare; / la Fonte di quella fonte / feconderà i nostri argini, / sanerà le nostre anime inquinate. Tale costante del libro, il riuscire a trovare una cura che è più una pace col desiderio, diventa infine la tela della madre di Bâsim che si disfa liberando la farfalla prigioniera nel deserto.
Tre sezioni che parlano dello smarrimento (il naufragio) umano all’interno della complessità del desiderio e delle sue conseguenze, reazioni, nostalgie (il deserto). Dall’oracolo della rosa che canta la sacralità della donna che porta il seme dell’amore, alle campane della memoria che ne cantano la drammaticità, l’oscurità, e la liberazione che ascende a memoria (perchè anche la memoria è in fondo desiderio), fino al fiume nascosto che fa della viva memoria il segreto desiderio della donna, che poi nel figlio trova pace.
La chiusura del libro I naufragi del deserto, dopo le tre sezioni poetiche e con un tuffo nella storia della copertina del libro, diventa un vero e proprio compendio commovente e ulteriormente esplorante il concetto di desiderio che Zingonia riesce a evocare. Una storia vera, un mito vero, un quarto personaggio del libro che completa e riassume Khalil e Soraya e Bâsim. Un quarto naufrago: Avevo due anni la prima volta che sono morto. Il fuoco di una stufa a legna, incautamente aperta, a devastarmi e deturparmi il volto e l’esistenza. Poi il coma, la ripresa quasi totale, l’estrema unzione. Una madre, distrutta, si allontana di notte dal capezzale del figlio e si reca nella piccola chiesa dell’ospedale. Prega. Implora la Madonna Madre offrendo in voto tutto l’oro in suo possesso e si impegna a rinunciare a ogni forma di vanità, per riavere il suo bambino vivo, anche se offeso e non più normale. Al risveglio, il mattino seguente, il miracolo: io, Giovanni, apro gli occhi e nell’incredulità dei medici, contro ogni speranza, parlo, riconosco. Il volto è sfigurato, ma gli occhi vedono, le orecchie sono distrutte ma riescono a sentire, le piccole mani bruciate accarezzano. Tutto si è compiuto in quella notte di cinquant’anni fa. Dopo è il vivere: altre felicità, altri dolori, tutto difficile ma tutto accettato per il solo fatto di esistere, di esserci. Quella madre, Marianna, mia madre, affronta il dolore della malattia e in quel dolore, l’ultimo giorno, prima di chiudere gli occhi alla vita chiede scusa al figlio per il dolore che gli ha causato. Quel figlio, artista, si ricorda l’amore che sua madre nutriva per le rose coltivate e fatte crescere ogni stagione nel proprio giardino (da La storia di Giovanni Manfredini, a spiegazione dell’opera riprodotta in copertina).
Come è più che evidente è difficilissimo scegliere quali testi possano esemplificare un poemetto, tre poemetti, che vanno letti nella loro interezza. Trascrivo quindi solo alcuni brani raccomandando il lettore di fare riferimento all’opera completa, dove testi lunghi fluiscono e si intervallano a testi brevissimi, a volte di un solo verso o due, che nelle storie sospendono il respiro, ne evocano la vita.
Il principe ama la rosa e conosce il suo aroma.
Con minuzia percorre il suo sinuoso contorno.
Gioca con la corolla, attraversa il monte,
morde il frutto spaccato, il fico i coralli.
Bagna il volto nelle onde, affonda
la sua carne nella carne,
demonio! L’urgenza mendicante.
La sua malefica impronta è il ricordo.
Il principe non conosce l’essenza,
il mistero; è solo un vampiro
che mendica amore
non sa altrimenti.
Di giorno perde la sua corona,
ritorna alla solitudine,
corteggia il ricordo.
Ostenta i petali della sua nostalgia.
Un uomo alza dal letto
i suoi occhi, lucerna del tempo.
Depone ere di piombo.
Dorme la rosa nel suo letto.
La contempla, avvolge
i suoi petali tersi.
La luna gira muta, senza sosta,
intorno allo stelo; le stelle
s’intrecciano in un nuovo ed antico
firmamento. Lui bacia i piedi
a sostegno del mondo:
le fragili, eterne dita dell’amore.
Si unisce allo stelo, consegna
la sua linfa, libero. Nutre
con tutta la sua esistenza la sua
bianca rosa.
Soraya vende il suo corpo, compra
allegria. Vende allegria, compra
oblio. Si libera dal presente
inchiodandosi alla croce della lussuria,
martire del piacere e della vertigine.
Erotismo, fantasma che la abita
e spaventa: seme catapulta
che l’ha scagliata in questo mondo.
Soraya condanna i racconti.
La sua sventura si porta dietro
il sussurro di una favola orientale.
Come struccarsi le labbra
della carne azzannata? Come ripudiare
il satiro che abita nell’uomo?
– Soraya, vedo nascere un arcobaleno
sul tuo volto; le lacrime lavano
l’anima, sollevano la luce
inabissata nei nostri precipizi;
dell’aureola restaurata
forgiano colori nuovi. –
Il vecchio non la guarda in volto,
perso nella nostalgia ridente del cielo.
Il fetore dei suoi abiti dichiara
la sua indigenza; i suoi modi
le alte insegne dell’onore.
Soraya sfiora i piedi del cieco
con il deserto del suo sguardo:
– Sono un fiore marcito nel vizio
imposto dalla sorte, maledizione
che sopporto e compio ogni giorno
con la puntualità del diavolo;
mi disgustano l’uomo e le curve
che accompagnano la mia carne.
Odio queste mani schiave,
questa bocca affamata di orrore.
Impotente nel chiuso dell’odio,
dove niente vive in pace,
filo spinato teso, pavimento schiodato,
sgambetto.
Come un cane,
sento desideri che diventano morso,
ferita, voce che ritorna
nel tamburo dell’orecchio
una danza tribale che chiede
acqua per uccidere l’arsura,
ad irrorare una speranza screpolata,
morente, senza voce per gridare
l’odio che le cresce nelle viscere.
La poca linfa che scorre
in questa pianta del deserto.
Lei non disfa la lunga tela
che giorno dopo giorno tesse in silenzio.
Crede ancora nell’amore.
Nell’impeto del cuore
che al fiorire si chiama Bâsim.
Lei aspetta nell’ombra.
Il bimbo ride e insegue il frullo leggero
dei suoi pensieri, farfalla delirante
sopra i cactus del giardino.
Un uomo brucia nel ricordo di sua madre.
Il bimbo salta, segue il volo
fino ad arrendersi alle fiamme
che rigenerano il mondo.
Lei baciala chioma crespa di Bâsim,
amuleto contro il mal consiglio.
Crede nell’amore e nel ricordo
splende vivo un uomo. Lei carezza
suo figlio e riprende tra le mani
d’ombra la tela dell’attesa.
Bâsim non chiede
dov’è mio papà.
Sua madre tesse e ripone la tela
in un baule di madreperla.
Tra i gomitoli affonda un ricordo.
Il bimbo salta la corda
e conta uno, due, tre…
Una palma si scuote al confine,
fa scudo alla duna dal vento feroce.
Gli occhi umidi di una donna
nel doloroso trascorrere delle ore.
In Andalusia vive un giovane
di nome Bâsim. Sul suo volto
splende il sorriso del futuro.
S’inchina all’altare della Concezione.
Nella destra, un rosario.
Grano dopo grano, disfa
la lunga tela. Libera
la farfalla prigioniera nel deserto.