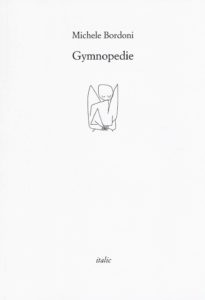
Gymnopedie, Michele Bordoni (Italic 2018).
Per affrontare il libro d’esordio di Michele Bordoni, Gymnopedie, è necessario soffermarsi un attimo sul titolo e soprattutto su quanto afferma il prefatore Emanuele Franceschetti a proposito dello stesso:
«Nel titolo di questa raccolta è nascosta, a mio avviso, una implicita dichiarazione di poetica che ben oltrepassa l’immediato e ovvio riferimento ad Erik Satie ed alla sua terna di pezzi per pianoforte solo (Parigi, 1888). Non al dondolio misurato e vitreo, minimale, contrassegno inconfondibile di quello che era stato il modernismo “a bassa voce” del compositore francese; Michele Bordoni (che, a dirla tutta, la musica la frequenta, respira e coltiva da sempre, come ben suggeriscono i titoli scelti per le sezioni del testo e i numerosissimi riferimenti, diretti o indiretti) sembra pensare più che altro allo sforzo disciplinato cui i giovani officianti spartani si sottoponevano in occasione delle Gimnopedìe, celebrazioni in onore delle divinità maggiori. Esercizi ginnici per vivificare una liturgia rituale. Esercizio che è anche prova di resistenza al dolore, come la poesia.»
In maniera estremamente puntuale Franceschetti sottolinea quanto la tripartizione del libro di Bordoni sia la tripartizione dell’omonima opera di Erik Satie: Lent et douloureux, Lent et triste, Lent et grave. Allo stesso tempo è però fondamentale, per approcciarsi a questi testi che, si ripete, sono d’esordio (e lo si ripete proprio per sottolineare la luminosità degli stessi), prendere atto che (sempre dalla prefazione):
«Quella di Michele si mostra come una operosità paziente, una ricerca tenace e mai frettolosa, una vocazione al nascondimento e all’ascolto. Questo basterebbe, ammesso e non concesso che abbia senso ragionare ex negativo, per porlo in chiara controtendenza rispetto al fare bulimico ed autoreferenziale che attualmente sembra caratterizzare gran parte delle giovani voci poetiche.»
La scrittura di Bordoni è a tutti gli effetti misurata, calma, che non implica necessariamente un autore calmo e misurato ma ne dichiara la scelta, l’intenzione e l’esercizio. Gli studi musicali si sentono soprattutto nella cadenza metrica (quasi sempre endecasillabica) e nella perizia con cui costruisce il verso anche nel momento in cui, come in Luzi, lo spezza e lo sposta a destra:
Il tempo non dà tregua né risposta
quando si fa minima ed angusta la distanza
dalla partenza.
Segni allora, segni
lasciati dall’uno all’altra dentro l’anima,
bruciati in sacrificio della vita
che sola sa e discerne le sue tracce.
Il lavoro del musicista (come non di rado abbiamo visto in un altro poeta/musicista: Federico Rossignoli) è un lavoro di esecuzione manuale e ripetitiva che costruisce un ritmo armonico nella certezza della forma. Ed è tale certezza a dire la scelta di Bordoni: affrontare un’esperienza personale, un pezzo di vita vissuta, attraverso i modelli di un’esecuzione musicale che sono anche i modelli di una scrittura poetica che, come dice bene Franceschetti, si discosta dalla scrittura spesso autoreferenziale dei suoi coetanei. E in questo il riferimento alla resistenza che trova ragione e spiegazione anche nel pezzo in prosa a chiusura dell’opera:
«Resistere ed avere un’eleganza… parole che risuonano nella mia testa da anni, donatemi da un vento di passaggio in una pineta marittima durante la stesura della mia tesi su Rilke. Resistere ed avere un’eleganza. Vorrei che la parola avesse un cuore, che amasse queste donne come me, e avesse un’eleganza che ci manca.
Gymnopedie, esercizi per resistere al dolore.»
Una resistenza attraverso l’esercizio della parola che ricalca l’esercizio dell’esecutore musicale che, per definizione, tende a sparire, a sottrarsi, affrontando l’opera nella consapevolezza che non sarà mai un’esecuzione oggettiva e neutra ma, per quanto ritratto, l’esecutore resterà sempre come impronta nel pezzo. Ed è il restare uno dei temi portanti di Gymnopedie. Restare dopo una perdita, restare dopo un incontro, restare dopo se stessi. E restare è esso stesso un esercizio complicatissimo e Bordoni lo dichiara in diversi testi:
Ma il riscatto è di là di questa attesa.
Resta quel che si tace
ad insegnare
l’ impossibilità del dire e del restare.
[…]
Non è cosa da poco l’esercizio
se scava fino in fondo nella forma
e ne distilla un varco, un davanzale
d’alba.
[…]
Ti resta in gola questa non urlata pace,
il lascito dolciastro d’una muta
resistenza.
Ma il restare è una anche una forma di relazione che implica un’alterità, un immaginare qualcosa al di là di ciò che è successo, di chi è successo, e di noi. Non a caso Bordoni echeggia l’infinito leopardiano nel testo di apertura, nel primissimo verso:
(a S.)
Sempre bianca rimane questa riva,
immacolata l’acqua, benedetta
l’impossibilità della distanza:
e noi poveri, pochi nell’ascolto
che si nega e dilaga nell’udito.
Si resta ad aspettare la parola.
Imparare lo strascico delle onde,
limitarsi a raccogliere sul lido
gli avanzi di quel mare che straborda.
E al fondo scomparire, ritornare
a casa, le mani ancora insabbiate.
Ma forse questo chiediamo sull’orlo
alla spuma, di trovarla in un difetto
di pronuncia, sepolta troppo dentro
la quotidianità. Di parlare
quasi a doverla masticare a vita,
dimenticando di doverla dire.
Il Sempre caro mi fu quest’ermo colle diventa Sempre bianca rimane questa riva ponendo in relazione due concetti fondamentali: rimanere e riva. Se il rimanere indica una staticità, uno stare qui, la riva porta in sé una valenza d’apertura che però non si oppone, non è antitetica al rimanere, ma ne condanna il significato in uno specifico: l’impossibilità della distanza.
La distanza che in Leopardi è fascinazione per l’infinito al di là della siepe viene rivissuta da Bordoni come un limitarsi a raccogliere sul lido / gli avanzi di quel mare che straborda, come un parlare / quasi a doverla masticare a vita, / dimenticando di doverla dire che apre comunque al dire, pur nella consapevolezza della distanza. Il secondo testo infatti non a caso ha riferimenti a un’apertura, un’ampiezza:
Maggio, gracilità d’ampie giornate
tu, preludio di forme e di distanze,
tu, già un tempo garbato nell’accogliermi.
L’aria tua è densa di tonalità
impercettibili, come se fosse
un intenso passare di linguaggi
il tuo apparire prima dell’estate.
Ci si dilegua in polline e profumo.
Ah, come, come può chi nasce in te
restare appeso al ramo come un frutto
se tu saltasti il limite del parto?
Come, se tu per primo t’arrestasti
alla tua prossima maternità?
Innominabile la fioritura
a chi ebbe il compito
d’abbandonarsi al suo essere fiore.
Il mare torna nel terzo testo, come l’acqua di sovente tra queste pagine, a sorreggere l’immagine iniziale di un infinito che esiste ma è distante:
L’organismo di ferro in riva al mare
si muove piano, stempera il calore
fra la ruggine ed il fischio delle ruote.
Lo copre una ventata di salsedine
tornata proprietaria del suo mondo,
dell’aria assottigliata, impercepita
se non per il passaggio non previsto
di un treno o due, di una vana ricorrenza
a perpendicolo di un ricordo:
“qui è vostro dimando”.
Dimmelo se veramente è in questo
esiliarsi di rottami che ci appare
il purgatorio umano, la piuma bianca
dell’angelo che vola controvento.
Dimmi se è da qui che si ritorna a casa
dopo l’arsura, se è questa negligenza
di storia che ci salva
o il vuoto sotto il balzo del gabbiano,
la sua vertigine di voce.
La riva/ermo colle del primo testo è bianca come il purgatorio umano, la piuma bianca / dell’angelo che vola controvento, a indicare non tanto un infinito simbolico quanto una relazione che ricalca la relazione leopardiana. Una riva percorsa, vissuta non solo metaforicamente e che comunque ha in sé, attraverso una ritmicità quasi matematica, il tentativo di resistere alla distanza.
(a mio padre)
Seguivo sulla sabbia le tue impronte
rimaste a raccontare il tuo passaggio;
sapevo l’andatura,
la distanza fra un piede e l’altra esatta.
Era, la mia, gioia d’appartenerti,
orgoglio acceso da una somiglianza.
Ma ora che l’acqua si ritira evapora
la terra, si apre e crepita il tuo passo,
la luce si fa vento e rende sordi.
La pietra ha un tacere che non so
sulle creste di un vivere più adulto
e non su sabbia, su arida erba corri
senza rumore ch’io possa ripetere.
A seguire, e per molti testi, appare un tu nella forma di una storia d’amore dove la distanza è rappresentata dalla difficoltà dell’esperienza, dalla vita con i suoi accadimenti:
Suite veneziana
È nel nero dei passi fra le calli
che ti ritrovo, amore, irraggiungibile sorella
e mi confonde il tuo volto, la postura,
il sangue che è il mio sangue e la tua voce,
l’oltremondo che s’apre sulle labbra
rosse della sera.
“Potessi accarezzarti il sesso, l’anima”
mi mormora un chiarore di gabbiano che intuisce,
che sa con esattezza quanto pesa
il corpo e la sua legge
e questa solitudine di mare
umida, disperata:
avvicinarti piano, non sfiorandoti
che con la punta delle dita, dolce,
e ricomporre il tuo profilo verticale.
Ma amore non è questa emorragia
che lascia esangue, intimiditi. È nell’attesa
comune delle cose che la cura
si fa altro, legame e precisione
con cui potersi dire veramente.
Non fecondare – attendere, ascoltare
È questo amore, rimanere immobili.
Fermi, come i leoni alle bandiere,
come le gondole ai pontili,
mandibole che masticano buio.
Il restare diventa un trattenere, un pronunciare:
tibi, Amarilli
Di te, scomparsa figura nel vuoto
delle scale, dolcissima mi resta
questa tua fuga dal mondo alla memoria,
il tocco delle labbra che s’immola
ghiotto sul ciglio del bicchiere.
S’impiglia la parola a quell’impronta,
riporta me all’inerzia di un silenzio
da te incrinato e inabile ad uscire
dal cerchio indistruttibile del vetro.
Svanisce pure il solco del ricordo:
ne trattengo come posso l’odore
perché del tutto non si perdano gli anni
nelle parole non dette, stampate
in un profilo grigio di sambuco.
Lì la tua bocca pronuncia il mio nome.
Appaiono poi nomi di donne tratti dalla mitologia greca (non si dimentichi la matrice greca del termine Gymnopedie):
Perdona se la voce ti racchiude
dove in realtà non sei, non sarai mai;
non sarai libera se non dispersa,
irriducibile al di là del tocco.
*
Cercavo il nome a volo sulla pelle
dove più eri l’enigma irrisolvibile,
la speranza della rivelazione.
Solo ricordo la tua schiena, Euridice,
e il vento che correva inferocito
nelle morbide trame dei tuoi fianchi.
Avrei voluto stringerti più forte,
ferirti nell’abbraccio.
Rinunciarti
invece era previsto, l’abbandono
al posto della presa.
Penelope
I
Coincidenza o destino? Forse amore.
Chissà da quale nodo siamo stretti,
se l’abbraccio fugace degli amici
oppure la pazienza della terra,
il folto di radici e il gorgo d’epoche
salito per le vene e fatto carne.
Il tempo non dà tregua né risposta
quando si fa minima ed angusta la distanza
dalla partenza.
Segni allora, segni
lasciati dall’uno all’altra dentro l’anima,
bruciati in sacrificio della vita
che sola sa e discerne le sue tracce.
Personaggi scelti evidentemente non a caso, se prendiamo atto che sono figure della distanza (Euridice muore, viene perduta e poi riperduta da Orfeo, Penelope attende Ulisse per anni).
Il secondo periodo dell’opera, Lent et triste, consiste in due soli testi che in maniera più marcata rispetto ai precedenti colgono l’esercizio, spesso la sensualità dello stesso:
É tutta li, nella cassa armonica,
la voce sterminata del non detto,
il mormorio silenzioso che inghiotte
la melodia e la rende impercettibile
monologo di altro alle sue spalle.
É lì, nello scarto impalpabile del cuore,
da voce a voce, da bocca a bocca,
che combacia la storia col presente
e la pronuncia che pareva propria
si fa atomo eterno, primordiale,
dove si folgorano inizio e fine
e il futuro rientra nel suo simbolo.
L’essere autentici, unici, per sempre, per una volta…
è angoscioso quando resta impossibile.
Tutto è stato già detto dall’inizio,
sepolto nella tomba della lingua,
nell’alfabeto.
Ci viene dato un la
profondo a cui rispondere
ma non c’è libertà nella variazione
non si hanno più risposte ma rinvii.
*
Ma quell’unica, la necessaria, l’umana
ma la pena
della corda percossa, della vita
chiede d’essere tesa, ripercorsa alla radice
salvata dalla sua ripetizione.
Non è cosa da poco l’esercizio
se scava fino in fondo nella forma
e ne distilla un varco, un davanzale
d’alba.
Il terzo e ultimo periodo rappresenta invece un’apertura a diversi tu incontrati. Persone, amicizie, affetti, luoghi, che comunque rispondono alla domanda della distanza, della misura della distanza che c’è tra il sé e il mondo nella forma di un atto di osservazione vissuta più che di una vera e propria conoscenza (cosa che, quest’ultima, forse appartiene a una fascia d’età un po’ più matura rispetto a quella di Bordoni).
(a E.)
Ci tiene in vita una comune reticenza,
la pudica distanza dal dirci interi
al di là dell’appunto scritto in fretta,
della linea del telefono che cede.
Raccontarci il vero sarebbe il buio
o la luce soverchiante dell’esistere.
(Uso parole non mie, le ripetiamo
nei dialoghi.
Sapere che è salvezza
questa maschera tiene in vita il gioco,
ci apre ad un destino di gesti donati
al fermento di una vasta superficie
che non nasconde il fondo, lo promette)
Gli echi letterari non mancano e sono continuamente trattati come un tavolo d’appoggio su cui scrivere, rielaborare, eseguire. Come in Ur Geräusch che fa riferimento al breve saggio Rumore primigenio di Rilke (1919) in riferimento a un grammofono (rimanendo quindi nell’ambito musicale):
Ur Geräusch
Le voci si ripetono nei dischi
nei solchi del vinile o attorcigliati
alle bobine, all’usura dei gesti
soltanto all’apparenza indeboliti.
Un atto perpetuato nella storia
trascritto qui, su supporto durevole.
Chissà se in qualche luogo, come inciso,
il graffio che hai lasciato nella vita
raggiunge una possibile frequenza,
se in un minimo spiraglio d’ascolto
si possa avere dentro tutto il tempo
che inconsciamente creava quel suono
e andava arando, cauto, la dura superficie
di una dimenticata partitura.
Il tema è quello del mutamento delle cose (caro anche al succitato Luzi, amato dal Bordoni) secondo il saggio rilkiano, dell’ipotesi di una realtà diversa, altra, di un accadimento distante da ciò e da chi resta. Il concetto di frequenza e vibrazione come metafora di una vita quotidiana vengono messi in relazione al concetto di appartenenza e inappartenenza come domanda rivolta a se stessi:
Una cicala a intermittenza vibra
il suo lamento d’inappartenenza,
traccia segni, apre solchi nella calma.
Gli rispondo io
col mio evidenziatore da una pagina
aperta in una camera assolata, dissolta
nel ritmo regolare dei suoi fremiti.
Tentiamo di risponderci l’un l’altro,
di accordarci a un’impronta di suono
graffiata su pareti di silenzio.
Fino all’ultimo brano in prosa che a tutti gli effetti spiazza il lettore (al lettore il giudizio) proponendosi come un qualcosa di stilisticamente diverso da quanto gli precede:
«Ricordo i suoi occhi pieni di lacrime, occhi che tradiscono un’ingenuità pacata, infantile, umile. Vedo gli sguardi delle due donne che amo, la dama nera del Kenya e la mia ragazza di un paesino sperso fra il crocevia di incontri. Hanno gli stessi occhi, le stesse lacrime. Entrambe mi urlano contro; le mie parole muoiono in bocca e senza accenti, indifferenti alle sonorità germaniche o africane, diventano proiettili contro loro due. Un omicidio intenzionale, terribile, iroso. Il cuore cede, di nuovo. Mi chiedo se sia possibile rispondere a quei pianti, accogliere quegli occhi, farsi lacrima con loro. Parole liquide sì, ridonate all’impossibilità della domanda di quegli occhi che amo. Parlare e rispondere, tentare di farlo.
Resistere ed avere un’eleganza… parole che risuonano nella mia testa da anni, donatemi da un vento di passaggio in una pineta marittima durante la stesura della mia tesi su Rilke. Resistere ed avere un’eleganza. Vorrei che la parola avesse un cuore, che amasse queste donne come me, e avesse un’eleganza che ci manca.
Gymnopedie, esercizi per resistere al dolore.»
Gymnopedie è sicuramente un’opera d’esordio riuscita che va letta cercando di seguirne i movimenti, le intenzioni, le piccole variazioni. E questo porta a un’ultima osservazione sull’opera nel suo complesso: non sembra infatti fuori luogo ricordare che Satie, da cui il titolo, ha scritto i brani per pianoforte con la volontà di creare una musica statica, quasi da arredamento. La qual cosa, rileggendo certe immagini e metafore di Bordoni, fornisce un’ulteriore sfumatura di significato sul modo dell’autore di restare di fronte alla distanza, all’appartenenza e all’inappartenenza. Forse addirittura una critica o un’autocritica agli esercizi per resistere al dolore.
Alessandro Canzian
Misuravo il tormento delle ore
pregando la tua fretta d’annunciarti
precoce. Eravamo bravissimi
a spendere quel tempo irrevocabile,
a divorarci insieme con la fame
reciproca di esistere.
Ora il preludio da solo ci basta;
non credo manchi il fiato per la fuga,
non il brivido accorto dei ventenni.
Ricomponiamo a brandelli le pause
ripetendoci di nuovo, ogni volta
col fondo minimo d’incomprensione
che non dischiude i cuori, li riapre.
Li riapre o li dilacera? non conta…
Già allora sapevamo (sapevamo?)
dai nostri quarant’anni in due
che era importante
ferirsi e mancarsi
che era importante rimanere in due.
Che è l’amore il pericolo più grande.
Gymnopedie
*
Ha tutta la tua voce quest’assenza
di base e fondamento,
dolore confermato in un dolore
più grande, universale.
Lo avevi immaginato più feroce,
ma non dolce, più chiuso nel suo male
ma mai figura pari alla tua vita
abbarbicata stretta alle colline;
e adesso senti che quasi ti somiglia
che quasi ti promette la dizione
di sé, quindi di tutto.
*
E allora il suo silenzio, la sua attesa,
il non poter più dire niente
non è esercizio di dissipazione,
non è la morte, la morte veramente.
È qui,
è qui che si fa urgente e necessaria
la parola, quand’è la sua impotenza
a farsi indispensabile
ed il gesto.
*
Resistere ed avere un’eleganza
che sia preghiera e perimetro di voce,
la fioritura nell’apnea del canto.
Resistere com’è giusto
rituale
del crepuscolo
com’è tutta Venezia nelle strette
se si apre una finestra, ne esce il sole
l’acqua ne ride un poco e lo sprofonda
nel fondale di pietra e non dimenticanza.
Bisognerebbe estinguersi, aderire
alla parola che genera la storia
e in essa sbracia, si risolve in fumo.
Oppure basterebbe amarla l’aspra
pena del corpo, l’irriducibile
testarda rimanenza di se stessi
che sfugge all’armonia, all’architettura.
Saggezza della pietra di Trieste
spazzata dalla fredda ala del vento;
misericordia altissima dell’acqua
che sempre la disgrega e la conferma.
