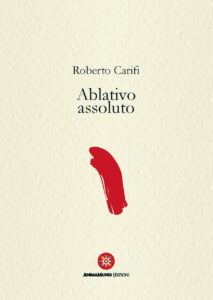«Se la vita è sventura, / perché da noi si dura?» Questa domanda Leopardi ci pone, nel Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, con parole che fanno eco ad un’angoscia profonda, a un’ombra che sembra avvolgere il cammino dell’uomo sulla terra. Se l’esistenza è avvolta da dolore e sofferenza, perché allora la tolleriamo con rassegnazione? La parola tollerare porta con sé un significato complesso, un riflesso delle ambiguità della condizione umana. Tollerare non è solo sopportare, è piegarsi alle regole del destino, è accettare ciò che sembra inevitabile, pur lottando nel cuore per la ricerca di senso. Il pastore solitario, vagabondo tra brume sconosciute, sembra essere l’unico a conoscere la verità: la vita è un perpetuo dolore; quale sia il suo fine, si interroga il pastore guardando la Luna. Forse, insinua il pastore, l’infelicità è una condanna per l’uomo, un destino ineluttabile che lo distingue dagli animali, che vivono la propria esistenza con semplicità e istinto. L’umanità, dal canto suo, porta sulle spalle il peso della memoria, anche del dolore, che l’affligge come un implacabile tarlo. Infastidito, insofferente, sfiorato da una fredda accidia, l’uomo si lascia corrodere da queste sensazioni sgretolanti. Ma è proprio nel contrasto tra l’infelicità e il desiderio di felicità che si scolpisce il suo destino, la sua ricerca di un senso profondo. Chi può rispondere a queste domande esistenziali?
«Se tu parlar sapessi»…
Alla fine, le risposte sfuggono anche a chi legge, come sabbia tra le dita, e noi restiamo soli a interrogarci sull’enigma dell’esistenza, navigando nel mare oscuro della coscienza.
Leggendo Ablativo assoluto di Roberto Carifi (AnimaMundi Edizioni, 2021, a cura di Domenico Pelini, postfazione di Benedetta Silj), si rinnova questo sentire leopardiano, dove la solitudine, prima tra le emozioni, avvolge il lettore, lo stringe con forza fatale. La contemplazione si fa maestosa, in un turbinio di pensieri e sogni, mentre la melanconia, come un velo, incede nella sua triste danza. La natura, dolce specchio dell’anima, sussurra misteri antichi e profondi, come la Luna, amica silente e muta, che con la sua candida luce ci guida. Ma oh, come ferisce l’indifferenza della Luna, dei cieli infiniti, che non rispondono ai quesiti del pastore. Delude sapere che il suo candore non può lenire il nostro male di vivere, la nostra infelicità nativa che ci tormenta. Eppure, è grazie all’ingegno che si schiude una consapevolezza senza limiti, e l’uomo, nel suo cammino tormentato, sperimenta la noia, il vuoto, la vanità.
Se Leopardi si rivolge alla Luna, Carifi invoca il «monaco» affinché lo possa liberare dalle «disgrazie». Il tempo dell’uomo, però, scorre implacabile, i ricordi diventano incerti, e nel bilancio della vita, rimangono solo «i rovi», «la muta piramide dei corpi» e «il freddo vento di ottobre». Rimane solo parlare con pochi, rimane solo morire insieme agli animali, ognuno nel proprio destino e nel proprio tempo, «in fila» uno dietro l’altro. È arrivato il momento di permettere alle barche di tornare a riva, perché la fine è ormai avvenuta, ma non senza scopo: «qualcuno si ricorderà di me».
Si affollano nella mente i ricordi, l’infanzia, la propria madre, figura che riveste un ruolo centrale nella poesia di Carifi, guida nella sua vita e presenza costante nel suo cammino poetico. A questi ricordi intimi d’infanzia evidentemente è necessario tornare per nostalgia, ma anche per la riscoperta di antichi sentimenti, finanche per riconciliarsi con il proprio passato, sublimando così momenti difficili e a volte traumatici e dando un senso alla propria esistenza, catturando nuovamente la bellezza e l’innocenza altrimenti perdute: «mio padre volle la mamma / senza curarsi di me»; «andammo assieme al mare, / al Forte dei Marmi»; «corri e ti sbucci le ginocchia / con quel balocco arrugginito».
Si torna, quindi, al tempo presente: «siamo di passaggio, / reduci del mondo», in una meditazione sul tempo che si conclude con un’orazione, forse un’invocazione: «dirò in solitudine le preghiere», «reciterò a voce bassa»; «sarò compassione e ritorno», «la terra entrerà in cielo».
Dopo Auschwitz nessuno abita più
le ceneri dei comignoli
dei pochi ebrei a righe.
Incidentalmente, ha senso scrivere ancora dopo l’Olocausto? Molti poeti hanno sentito, a ragione, l’urgenza di testimoniare e dare voce alle vittime dell’Olocausto, cercando di comprendere la portata della tragedia e le sue implicazioni per la storia umana. Uno di questi è Paul Celan – «negro latte dell’alba noi ti beviamo la notte / noi ti beviamo al meriggio, la morte è un Maestro di Germania» –, anche Carifi non si sottrae al compito, perché una poesia degna di questo nome non può chiudersi in se stessa e dimenticare l’orrore, non può non farsi civile.
Carifi cerca, e forse trova, una risposta alla domanda di Leopardi nella filosofia e nella fede, «alle falde del Tibet», là dove «nascita e morte si equivalgono». Versi limpidi, quelli di Carifi, con una capacità di sintesi che si conviene non solo alla poesia, ma anche alla vita che così compie la sua rivoluzione. Quanto al titolo, occorre considerare che l’ablativo assoluto è una costruzione grammaticale utilizzata nella lingua latina. Si tratta di una frase composta da un participio passato e da un sostantivo o pronome in ablativo, i quali sono accoppiati tra di loro e fungono da un’unica unità sintattica, indipendente dal resto della frase, ad indicare una circostanza di tempo, modo o causa.
Come l’ablativo assoluto, così queste ultime poesie di Carifi attestano una cifra di autonomia e indipendenza del poeta. Come questa costruzione si separa dal resto della frase in latino, anche nella poesia Carifi sembra distaccarsi in un certo senso dal passato, dalla tradizione, perfino da se stesso, riuscendo così ad agire e scrivere in modo del tutto libero, come occorre quando si tratta di tirare le somme di un’esistenza: un’operazione che qui Carifi compie con somma maestria.
Maurizio Lancellotti
Nel luogo dove non ci sarà più niente
solo un riparo, un intimo inferno
parlerò a pochi, a delle quaglie
oppure a dei ramarri
sempre più solo
accanto ad una fonte.
La povertà è un miracolo
di queste sciarpe rosse,
la malattia si arrende
quando la ringraziamo
con la rovina dichiarata a bassa voce
mentre codesta lingua non è più straniera
e morte, nel mio tedesco, è una preghiera.