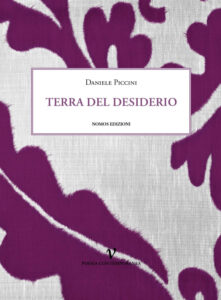
Oggi che è morto Bauman mi sono trovato a leggere questo straordinario libro di Daniele Piccini: Terra del desiderio (Nomos Edizioni 2016). In relazione al desiderio mi affascina un passo del sociologo polacco estratto dal suo Amore liquido (Laterza 2003):
Ma… forse parlare di desiderio è eccessivo. Come per lo shopping: oggi chi va per negozi non compra per soddisfare un desiderio, ma semplicemente per togliersi una voglia. Ci vuole tempo (un tempo insostenibilmente lungo, per gli standard di una cultura che aborre la procrastinazione e postula invece il soddisfacimento immediato) per seminare, coltivare e nutrire il desiderio. Il desiderio ha bisogno di tempo per germogliare, crescere e maturare. […] Oggigiorno i centri commerciali vengono progettati pensando a desideri facili a nascere e rapidi a estinguersi. L’unico desiderio che la visita a un centro commerciale deve instillare è quello del reiterare all’infinito l’eccitante momento del lasciarsi andare, del dare briglia sciolta alle proprie voglie senza un copione prestabilito. La brevità della loro aspettativa di vita è il pregio maggiore delle voglie, ciò che le rende preferibili ai desideri. Togliersi una voglia è soltanto un atto estemporaneo. […] Nella sua interpretazione ortodossa, il desiderio va curato e coltivato, implica una cura prolungata, un difficile negoziato senza soluzioni scontate, qualche scelta difficile e alcuni compromessi dolorosi, ma, soprattutto, cosa peggiore di tutte, comporta il procrastinare del suo soddisfacimento, il sacrificio senza dubbio più aborrito nel nostro mondo fatto di velocità e accelerazione. Nella sua radicalizzata, condensata e soprattutto più compatta reincarnazione sotto forma di voglia, il desiderio ha perso gran parte dei suoi fastidiosi attributi e si è concentrato maggiormente sul proprio obiettivo. Quando è pilotata dalla voglia, la relazione fra due persone segue il modello dello shopping e non chiede altro che le capacità di un consumatore medio, moderatamente esperto. Al pari di altri prodotti di consumo, è fatta per essere consumata sul posto (non richiede addestramento ulteriore) e può essere usata una sola volta e con ogni riserva. Innanzitutto e perlopiù la sua essenza è quella di potersene disfare senza problemi. Se ritenute scadenti e non di piena soddisfazione le merci possono essere sostituite.
Quando Bauman parla di negozi e supermercati non possiamo non ricordare la definizione di non-luogo di Augé che include proprio il negozio, portando la ricerca del togliersi la voglia a un livello de-individualizzato, de-storicizzato, anonimo insomma nella sua accezione più assoluta. Ed è con questa chiave di lettura (molto personale, opinabile) che mi sono avvicinato al desiderio di Piccini per capirne le maglie.
È la bellezza altèra
quella che fuggo e da sempre mi segue.
… … … …
Questa da dove viene
comparsa in un negozio
di una eleganza triste fino a ieri.
Adesso ingombra con la luce chiara
dello sguardo ogni spazio.
Non so da dove venga
ma non da queste valli
senza chiarori se non dello spirito.
Mi brucia la bellezza
come la prova più alta, l’estrema
che non avremo bene, che bruciando
forse bruciando nel nulla,
meglio del poco, avremo dato varco
a inizi che non sono qui né ora
ma in grembo all’abbondanza del creato
che vuole il desiderio,
che vuole che io paghi la mia parte.
Il desiderio di Piccini si rapporta indiscutibilmente a un presente che però non riconosce, che non soddisfa, che ha bisogno umanamente prima che letterariamente di riferirsi ad altro, a un’alterità tanto concreta quanto da pagare e che però tende continuamente a un punto d’origine, a una provenienza che sia (forse) identità.
Sono colpevoli di desiderio,
una ferita centrale che sanguina
di tempo in tempo e che non si rimargina,
fonte d’acqua battesimale e fango.
Tu, di tutte le cose la più pura,
non riesci a compiere la loro ansia
stai inchiodata alla povera fattura
vulnerata dai fuochi, rivoltata.
E non rimane angolo del tempo
sottratto al divenire della mente
che riconcilia, ridipinge, immagina:
tutta la vita fatta e ricreata
dentro il buco della mancanza, il tondo
in cui respira, da cui ancora vieni.
Spesso i testi in Piccini si legano gli uni agli altri anche a distanza di pagine, non esaurendosi nella loro singolarità ma diventando tessere di un corpo più grande. Come puntualmente sottolinea Giancarlo Pontiggia in postfazione questo dialogare a distanza dei testi è certo uno degli aspetti più significativi del libro, che d’altronde, proprio per la sua natura antologica, spinge il lettore a misurarsi sulle ragioni che hanno spinto l’autore a scegliere o a escludere i testi già pubblicati. E la poesia di Piccini, per sua natura, è poesia di scavo e di ricerca, una poesia in cui il senso non riposa nel singolo testo, ma nel movimento complessivo, nell’infittirsi dei segni e delle ragioni che lo hanno determinato
Oh se almeno nei sogni lei si facesse incontro,
ma non può: il creato
è desiderio che si sparge invano.
Vero è che appare spesso di tra i volti del tempo,
prende la foggia d’una
delle più ingenue o delle più sventate
che offrono la loro primavera,
ma come suscitate, così il vento le turbina
e spariscono agli occhi: non al cuore
che per mancanza tremola, vien meno.
Devi desiderare, finché avrà fine il fuoco
e potrai, nella cuna, riposare.
Devi desiderare è la formula chiave che forse più di tutto definisce il significato di desiderio in Piccini. Così come la formula Dio è definisce Dio anche quel devi definisce e racchiude l’intero significato del desiderio. Che è il significato della storia e dell’uomo, e la sua possibilità nel presente. Un desiderio che arriva a definire la creazione stessa e la trasferisce su un piano di possibilità umana.
Oh tenera, ci sono
più cose nei tuoi occhi
che sotto il cielo… nelle carte fitte…
dentro le lingue materne e paterne…
più cose nei tuoi occhi
che nei milioni di segni graffiti.
Ci sono nei tuoi occhi i duri verdi
di primavera che frange l’inverno
e nel tuo corpo la valle distesa,
aperta per la pace
e il desiderio – ancora.
Ci sono nei tuoi occhi
i primi segni
della creazione che trema nel petto
teneramente – come appena nata.
Quasi a dire che attraverso il desiderio possiamo essere la storia (non oso dire costruire) e al contempo che la storia ci chiama attraverso il desiderio. Che poi appunto si rapporta con la nostra stessa esistenza.
Io che non credo al mondo
penso tu sia dentro di me da sempre,
ma forse occorre il soffio di una morte
lo schiaffo del presente
perché tu dica «io»
perché tu venga sopra
a questa nullitudine; e verrai
come ancora si scrollano
i rami della neve
o tornano alla tana gli animali.
Io non ho fede in niente che ci accada,
guardo nel petto nascere le nubi
e il punto dove il buio fa il suo nido:
neanche lì posso vederti, adesso.
E quante stanze Dio ha nella mente
per piangere e vegliare
le specie innumerevoli,
le destinate a morte,
le selvatiche e svelte, le regali.
E quante cose la natura macina
che mi sembra impossibile
tenerle a mente, sciami e sciami d’astri,
costellazioni, bestie numerose
come il battito cardiaco del mondo.
Niente e nessuno, niente rassicura
sulla tua onniscienza,
anzi ti prego, abbi
appena pietà del piccolo perso:
forse ti riconoscerò in quel punto.
Dove la morte non è paradossalmente la conclusione dell’uomo quanto un’alterità necessaria nel momento in cui rapportandocisi emerge la possibilità del ritorno, del riconoscere.
Una poesia quella di Piccini che non si esaurisce in un solo libro e che lascia intendere un intreccio del pensiero, della narrazione del pensiero che l’uomo fa a se stesso ponendosi le domande sulla sua esistenza. Esistenza non solo filosofica ma anche quotidiana, concreta.
Una poesia che non si esaurisce nemmeno nella sua ricerca, nei suoi rimandi e riferimenti interni (Luzi, Caproni, Leopardi, Dante eccetera eccetera eccetera), ma si oltrepassa e lascia trasparire il magma dell’autore. Una metrica spesso rigida, talora perfetta, controllata in ogni sua minima parte ma che lascia intravedere un fuoco interno che ha necessità d’essere misurato. L’uomo che viene in qualche modo controllato dal poeta. Senza nostalgia s’intenda, anche se essa viene chiamata in causa da Piccini stesso in riferimento a suo padre.
Dov’eri allora, mentre gli operai
lavoravano chini, in un silenzio
acuto, rotto da frotte di vento,
da suoni di volatili, brusii?
Ossa su ossa, cenere di cenere
la nostra comunione che non cede,
nemmeno nella fossa, nelle tenebre,
e che si duole a lungo, nostalgia.
Abbiamo fatto in tempo a darci vita,
tu prima e io nel tempo che rimane,
a consolare di un fuoco la stesa
senza respiro delle vecchie estati
che non danno riparo: solo in te,
solo nelle tue ossa è il caldo seme.
E in questo diventa il poeta di ciò che non sarà, del e niente è più sicuro. O come dice Pontiggia non è un poeta di facili certezze, nonostante sia in lui – come in pochi altri – la volontà di pensare il mondo, di pensarlo fino in fondo, anche nel dolore e nello strazio delle sue parvenze, di non rinunciare insomma alla forza simbolica dello sguardo che fa combaciare visibile e invisibile.
Se in qualche posto della terra sei,
forse è meglio saperti
al sicuro dalla prova finale,
rimani a lungo a preparare intrugli
per la sera terribile
del nostro incontro, un tavolo,
una sala operatoria, un caffè,
dovunque avremmo forse
avuto appuntamento.
Tieni a lungo segreta la ricetta
dell’odore di fieno del tuo seno,
nascondi i tuoi capelli sotto cuffie,
confondimi: così sono dette
per non essere intese le parabole.
Parli all’orecchio del cavallo,
sussurri, soffi
nella cassa armonica
e lei diventa una conchiglia
che espande le lingue sottomarine:
porgo orecchio e non sento soffiare,
non ascolto il gorgoglio che suona
internamente nel cranio, strumento
da fiato del cavallo che hai amato e ripeti
di amare anche adesso.
Mezzogiorno lunghissimo
di un lunedì che ci separa, mentre
prima i giorni ci univano:
continua a dare voce alle orecchie
pazienti che risuonano.
Ti sentirò un giorno,
ti sentirò.
Mi sfugge il suono delle tue parole,
di quando chiedi il vino al ristorante
quando scherzi,
una musica sorda mi percorre.
Aggiungi la tua voce alle molte
perse nel mondo, confuse tra le acque
gorgogliate, inudibili
che qualcuno districherà un giorno
dalla stiva del creato,
rifacendole nuove
come il vento d’aprile.
Sotto il fiato del cielo
sono rimasto solo
e guardo questa estate
senza leggenda andare.
Tu sei la mia fortezza, il grano alto
degli anni infiniti che non tornano
e di quelli incalcolabili, dopo.
Solo non ti dimenticare e abbi,
anche solo un istante, quel tuo volto
di ragazzino punto da uno spino,
quel sorriso che buca la tristezza,
così ho imparato a vivere.
Non importa che nulla sia accaduto,
c’era l’àlea purissima di sogno,
il verzicare cieco per il mondo
di certa primavera.
C’era il collegio, turrito e nascosto,
e un bruciore nel volto
che sapeva di marcite e di stelle.
L’anno della nascita era appena esploso,
non sapevo di scendere le scale
verso la terra che trema di attesa
per ciò che non sarà.
I muri della patria sono miele
che lega la tua sorte e forma il mondo,
nulla vi è conosciuto: in questo lago
avvenne forse l’Odissea, vicino
la nascita della specie, le guerre
che hanno lasciato torri smozzicate.
Non anni, ma millenni nelle arterie
del bambino che apprende il tempo cavo
e prova orrore sacro a ritornare
dove è iniziato il film, e lampi e bestie
che visitano la memoria, eterna.
Non generare figli che dovranno
pagare questo prezzo, ma una bolla,
un soffio nel creato, che ci liberi.
L’anima di una donna è anche nel fianco,
nello scatto con cui accenna e ritrae:
altri fida nel gesto della mano
che lo rivela uomo: lei attrae
destini nuovi, diversi, che durano
una mattina intera di miracolo,
la garza di vacanza che si estende
fin che l’ovale è tenero alla mano.
Lo pensava guardando – nella camera
oscura – il lampo di parmigianina
giù dal tassì: “monto in macchina e andiamo”…
Andiamo dove vuoi: tempo del gioco
è il fianco che contiene già il guizzare
del nuovo nato, e niente è più sicuro.
Dove sarai a quest’ora di sera,
l’ora più dolce del giorno a chi pena…
Il desiderio è una fitta del sogno,
sospende il fiato, la gravitazione,
mentre i cani dalle aie si lamentano:
il tempo astrale si ferma nel cuore
senza che nulla si possa cambiare,
solo si rompe il ritmo delle ore,
il respiro si mozza alla tua immagine.
Sei un diamante che rompe la luna,
buca di colpo la quinta del petto
dove invecchiano solo vecchi amori.
Sulla bergère di una stanza d’albergo
vedo il tuo corpo di spalle in ginocchio
aprire un arco colmo
come un dorso lunare: già mi spoglio
le luci calano (è un sogno?) e nel punto
di essere al tuo dosso, con le mani
che premono, il respiro…
Sento un fiato di vento tremolare,
una scossa che fa di te una torcia
e di me, in tanta notte, un fil di fuoco
dentro il buio di te.
Non le ritroveranno quelle forme
apprese da bambini, forme vuote
dell’abitare il mondo senza tempo,
perché di poi il flusso li travolge
e come tutti devono viaggiare,
perdere il filo e per questo fermarsi
in un diverso ventre non materno,
che ridiventa cuccia del respiro.
Dovranno anch’essi accettare quel prezzo
venire a patto col buio più antico
che li prende alle spalle, dare nome.
Saranno in pace a volte nella sera
dove anche noi, oltre la cruna, siamo
per qualche ora a riva dalla pena.
Il concetto di pena infine si lega intensamente al desiderio e si intuisce essere un elemento costitutivo dell’esistenza. Una pena che poi si rapporta alle possibilità della parola con una soluzione dichiarata, un lasciarsi e portarsi che non è abbandono di se stessi ma, forse, un’ulteriore definizione di desiderio.
a Giorgio Caproni
Se t’incontro è di certo
in una delle viottole
lungo i fossi, all’accendersi
della sera – un fiammifero ? –
verso il nero dei campi:
ho la cicca, per scena
e mi brucia la rossa giovinezza
come una mancanza.
«Giorgio – dico – qual è stato il tuo canto?».
«Non ho avuto un canto
– mi rispondi, senza stupore o foga
di ritorno seguìto
dall’odore di foglie –
ma una voce tesa,
aguzza come un vetro
a ferire l’imboscato nemico,
spicciarne un soffio o sangue:
l’ebbi a volte, lo tenni
e il suo sguillare nuovo
fu la mia libertà,
la mia caccia oltreconfine furiosa».
Sì lo sapevo, e ora
non mi viene da chiederti
se fu amore o pena
quel seguitare passi sulla rena
solo «posso, caro Giorgio, sedere
con te alla panca del locale, bere
giusto un bicchiere, per farci coraggio?».
«Zitto – porti il dito alle labbra – zitto.
Non senti l’abbaiare
dalle cascine già perse nel buio,
l’affondare di serpi
nell’erba alta, e il fresco,
il fresco delle acque?»
e mi lasci, ti porti
il crollo della luce,
vai dove devi, rimasto io solo
nell’ardenza estiva della campagna.
Alessandro Canzian
