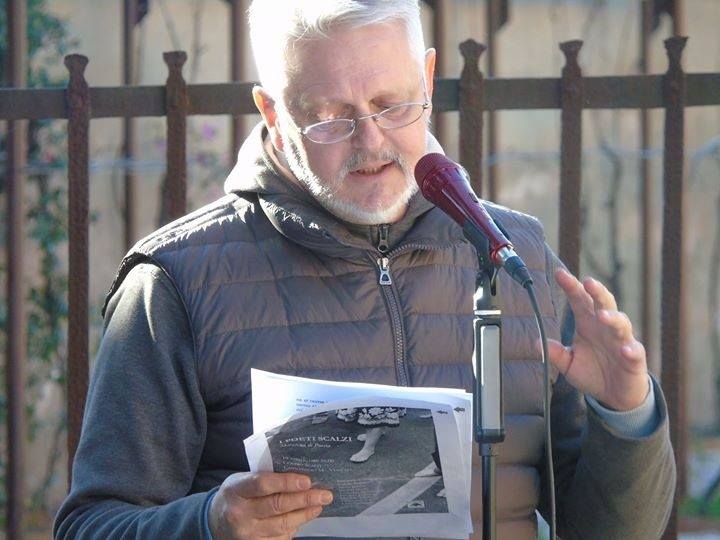
perché andare via
è calpestare giorni
senza chiedersi
e preservarli eguali
mentre il tempo accade
se il tempo accade
non mantenerlo eguale
ricalcare i giorni
è già
morire
oggi non posso ancora
questo odore di pareti svuotate
l’esporci altrove
non ho appreso
l’etichetta della perdita
i rituali dell’andare
l’esilio permane
anche per chi resta
non è la vocazione dei viticci
sviluppare rami e fiori e ombre
non è questo
l’essenziale è arrampicarsi
per sforzare i legami
e frantumarli
se non li manteniamo
è virtù e colpa nostra il perdurare
così ti parlo – non a te
con i tuoi fili indistruttibili –
e niente posso
che occhi limpidi che hai
(Sandro Pecchiari, L’imperfezione del diluvio, Samuele, 2016)
In questi testi di Sandro Pecchiari si assiste a una disamina del senso della perdita, sviscerato sotto diversi punti di vista: la perdita di una persona cara, di un legame, della vitalità quotidiana soffocata da un immobilismo mortale.
Il punto di partenza è proprio l’assenza di un dinamismo evolutivo, che diventa un’ombra di dissolvimento, una forma di morte quotidiana: “ricalcare i giorni … e preservarli eguali … è già / morire”, soprattutto se tale forma di resa si traduce in un’assenza di dubbio, di mutamento, uno stare “senza chiedersi”.
L’invito è però positivo: “se il tempo accade / non mantenerlo eguale”: il testo in qualche modo ricorda Burroughs, quando sostiene che “quando si smette di crescere si inizia a morire”, e anche qui il senso che perviene dal testo è quello di esperire il cambiamento e la trasformazione continua del vivere come una crescita necessaria, vitale.
Il secondo testo si concentra sulla perdita di una persona cara, o meglio sulla difficoltà viscerale di lasciarla andare, che Pecchiari definisce l’apprendimento de “l’etichetta della perdita” e dei “rituali dell’andare”. Ricorre nuovamente il contrasto tra dinamismo e immobilismo, reso drammaticamente in chiusa con la permanenza dell’esilio, la condanna di chi sopravvive alla privazione dell’altro, e il già citato andare.
Si avverte nitidamente il desiderio di riuscire ad accettare la trasformazione continua insita nell’esistenza e nelle relazioni umane, come si avverte il profondo dissidio con il desiderio di trattenere ciò che di prezioso le stesse ci offrono, e che non vogliamo sparisca o dissolva.
Queste istanze continuano a intrecciarsi nel terzo testo, letteralmente, quando si paragona l’intessersi relazionale alla “vocazione dei viticci / sviluppare rami e fiori e ombre”; ma anche qui, l’invito è quello a non accontentarsi dello status quo, cercando di trattenerlo sempre eguale a se stesso, ma piuttosto “sforzare i legami / e frantumarli / se non li manteniamo”, perché “è virtù e colpa nostra il perdurare”.
Mettere in discussione e alla prova non solo il nostro esistere quotidiano, ma anche il tessuto delle relazioni, come a dire che se non sopravvivono a tale sforzo, è persino meglio (“essenziale”, rectius) frantumarle.
Eppure anche queste sono parole – e la chiusa del testo lo indica chiaramente in quel “così ti parlo – non a te” – parole rivolte soprattutto all’io lirico, che infine si arrende con un semplice “e niente posso” di fronte agli “occhi limpidi” del suo interlocutore, creando un espressivo corto circuito: da un lato, la tensione razionale ad accettare le dinamiche di mutazione continua dell’esistenza, il continuo trasformarsi del quotidiano e delle persone care che entrano ed escono dalle nostre vite, con un invito a non mantenere le certezze sempre eguali in una forma di confortevole stato anticipatorio della morte; dall’altro, il cadere alla sorpresa della persona cara di fronte a noi, del suo sguardo, dello stringente senso della sua mancanza, al desiderio di trattenerla e di non lasciarla andare.
Nel mezzo l’imperfezione e il conflitto, tutto umano, che consente un sentire vivido e l’aspirazione ad una crescita continua – un dinamismo a volte doloroso ma, appunto, essenziale e vitale, da opporre con decisione a un mero sopravvivere, che rischia di tradursi in una comfort-zone asfittica – una sepoltura in vita.
Mario Famularo
