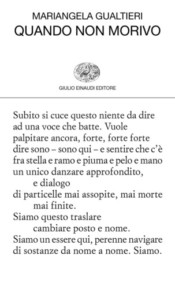
Quando non morivo, Mariangela Gualtieri (Einaudi, 2019).
L’ultima raccolta di Mariangela Gualtieri, Quando non morivo (Einaudi, 2019), si scinde in sei sezioni (Ecce cor meum; Animali di silenzio; Riassunto della creazione; Divinità domestiche; Specie con orchi e animali estatici; Requiem).
Il titolo della prima sezione è tratto dalle Confessioni di Sant’Agostino (II, IV, 9) e non può che voler esprimere quell’esporsi «a tutte le correnti» per «cadere nell’ebbrezza / degli slegati», caratterizzata «dalla burrasca che abitiamo» e in cui «siamo». Mariangela Gualtieri sembra domandarsi cosa sarà mai essere al mondo, in questo mondo dove solo la voce e la preghiera sono un pretesto che invochiamo per sentirci vivi, noi che siamo «a volte / ripetente dolore». Il dire sbatte contro il muro latente del vuoto, per cui il nostro essere voce, essere al mondo, trova ostacoli non indifferenti ne La celeste pazzia a cui Mariangela Gualtieri osa abbandonarsi:
Procedi piano. Lascia che la mano
esegua il fragile dettato.
Abbi fede in quel niente
che viene – quel niente
che succede.
Non prendere la parola.
Lascia sia lei da sola. Diventa tu
la preda. Sia lei che ti cattura.
La seconda sezione, Animali di silenzio, riveste un ruolo fondamentale in tutta la raccolta, poiché gli animali sono creature abili nel dilatare e nell’aggiustare la nostra percezione del vivere, condizionata da una «inutile fretta», dal nostro «cattivo padrone», che ci sprona a correre a perdifiato, «senza neanche un dono / per nessuno» fino a seppellirci sotto un cumulo di «faccende». Non resta nulla a sottrarci dal silenzio, anche se la nostra è una «voce che batte» e «asseconda una invisibile venuta». Gli animali sono il fil rouge che la natura concede all’essere umano, per ritrovarsi intero anche durante lo sfacelo che comporta «la disadorna morte», insolente e duplice. Nel «putrido canto» della morte siamo inermi, siamo animali anche noi. O, molto più semplicemente, siamo creature arrese al destino. Inoltre, la terza sezione, Il riassunto della creazione, è un breve «imbrunire» che fa «del morire / un’epopea di colori». L’animale che imita il respiro della natura, immerso nel naturale corso degli eventi, si raccoglie in sé e non fa altro che calzare, nel sonno, il preludio della morte, di quel silenzioso, «geniale modo di sparire»; un «concerto grande e misterioso» le cui spore tracciano la meraviglia sul volto dei bambini, «pollini d’altro mondo» che ci fanno sentire «ancora capaci di amare qualcosa».
Vernalda Di Tanna
Lei getta il cuore
oltre la ringhiera.
Sì – qualche volta
ha chiesto di finire.
Noi siamo questo.
Siamo a volte
ripetente dolore
e le maestre nuvole
con quel loro tesoro
restano anticaglie
appese al cielo.
Le maestre ritornanti
foglie. Le maestre acque.
E i maestri gigli
il gran maestro sole
i donatori di parole
poeti – care poete
Tutto scompare
dietro l’evidenza
loro obbedire
senza resistenza.
Il bell’animale selvatico
che siamo resta non-nato nel petto
quella specie di vittoria
fallisce la presa di noi
e così ritorniamo
sempre da capo – nel corto
dell’anno e dell’ora.
Nell’ammassato mondo.
Non si cuce più il nome alla
sua voce. Il sangue riconosce
più larga parentela che traluce
fra squame e venature e linfe
e pietre e fuoco e cadute e colpi
dalla piccola, dalla grande,
una balbuzie di foglie – un incompreso
abito cucito a poco a poco nella profonda
sete, nelle stellate ondine increspate
giace un non sapere che riposa, che nutre.
Dies irae, dies illa,
solvet saeculum in favilla,
teste David cum Sybilla…
Tu preghi, tu invochi. Giorno dell’ira
giorno del tremore. Questo dici. Ma adesso
ti chiedo, adesso, in queste ore di tormento.
Il Dio che invochi? Tace. Quanto tace.
La sua imperturbabilità – non me la spiego.
E non mi spiego di non udire
il suo grave lamento, il suo urlo di collera
o d’amore. Sentire almeno
il suo avvilimento, sentirlo piangere
come piangiamo noi
guardando le facce serie del dolore
facce in sgomento davanti alle macerie.
Giudice giusto, punitore dici.
Io non so invocarlo questo tuo Dio
né bestemmiarlo. Troppo duro per me.
