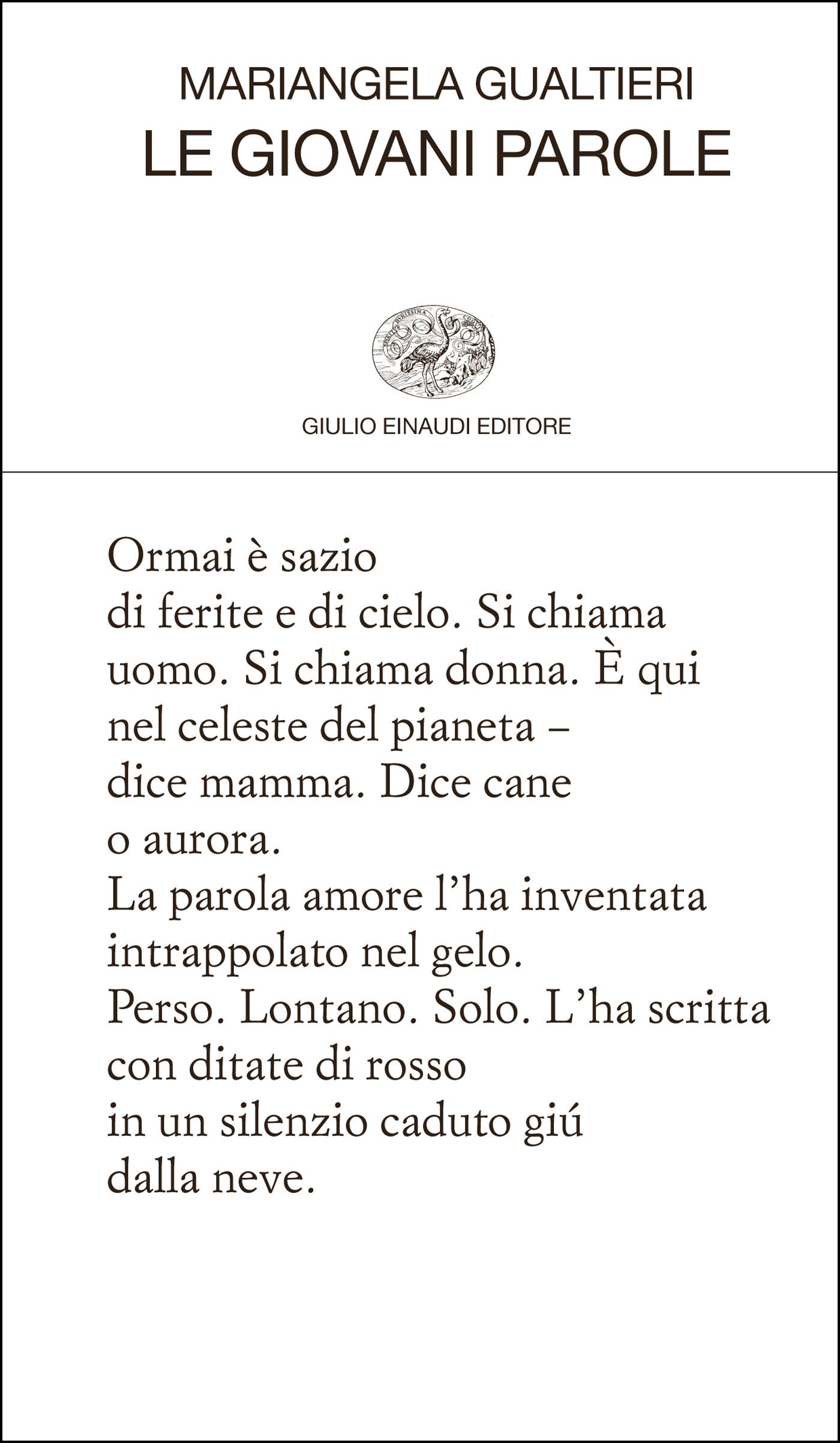
L’ultimo libro di Mariangela Gualtieri tradisce l’origine teatrale della sua poesia. Teatro, deriva dal greco e significa guardare (oltre). Di sguardo innanzitutto si tratta, infatti, in queste poesie. Di piccoli quadri icastici che affacciano la quotidianità sull’universo. L’autrice, insieme a Cesare Ronconi, ha fondato il Teatro Valdoca negli anni Ottanta. Il titolo della raccolta, Le giovani parole, è tratto da “I begli occhi del ladro” del poeta Beppe Salvia, e altri sono i riferimenti: Borges, Sant’Agostino, Amelia Rosselli, Ezra Pound, ecc., da Bruno Schulz prende i titoli di tutte le poesie di Tua Prodigiosa Visione. Non solo il teatro è presente come messa in scena del mondo, del microcosmo e del macrocosmo, come prestito di altre storie, ma soprattutto come volontà di elargire il mistero della parola-pane a noi, ascoltatori che udiamo e che vediamo, è il caso di dirlo, il suono […] E vediamo l’occhio che sente il panorama umano. C’è, nelle poesie di Gualtieri, una gioia infinita, antigravitazionale, che si sente e si persegue con tutto il corpo […] Si scrive di ombre, di nuvole che attraversano lo sguardo, come attori di antiche rappresentazioni greche: entrano, si fermano, escono dalla scena. Non puoi vedere questa scrittura altro che come danza. Tensione fisica, sanguigna. Ecco perché la semplice lettura dell’opera non rende tutto il merito alla poesia: bisognerebbe anche affidarsi alla voce. (da Satisfaction, qui)
Con queste parole, chiare ed efficaci quanto il libro a cui si riferiscono, Gianluca Garrapa descrive la poesia di Le giovani parole di Mariangela Gualtieri (Einaudi 2015). Un libro che per ammissione della poetessa stessa nasce o meglio emerge da un contesto teatrale: Le giovani parole è un verso di Beppe Salvia. L’ho pensato come definizione della parola poetica: la poesia è parola inconsumabile, parola che non invecchia e dunque è sempre giovane parola. Questo titolo mi piaceva talmente che dal rito sonoro l’ho fatto transitare al libro, mentre di solito si fa il contrario (da un’intervista della Gualtieri rilasciata a Michele Pascarella, qui – dove tra l’altro mi fa molto piacere leggere una piccola argomentazione in merito al termine poeta usato al femminile: Voglio pensare che la parola “poeta” comprenda entrambi i generi. Poeta è una parola bellissima e la preferisco, mi pare della famiglia di atleta, di asceta, parole che stanno molto bene vicino al poeta, quasi ad indicare che è di secondaria importanza il genere, in certi casi). Trovo di particolare interesse in questa intervista, posta la mia ignoranza per quanto riguarda il teatro, il concetto di rito sonoro: Anche se i miei riti sonori sono in apparenza semplicissimi, essenziali, vi è una tessitura ritmica molto importante nel determinare l’attenzione del pubblico e il mio agio nel proferire, una tessitura calibrata nelle venature minime. In questo Cesare viene sempre interpellato, e ogni volta porta le sue critiche, fa le sue lodi, propone e disfa e io lo ascolto sempre con grande attenzione.
Che ci sia una ritualità non solo teatrale ma esistenziale sono i versi stessi a dircelo: È un trapasso di forme da una vita / ad un’altra. Concerto in cui / cambia solo l’orchestra. / Ma la musica resta, è là. Una ritualità che non è circolo vizioso della vita ma apertura alla sua complessità in senso epifanico. E che tale poesia abbia la capacità di recitare il mondo vestendolo di un rito sonoro che è svelamento del mondo stesso, è di fatto il significato della prima poesia della raccolta:
La migliore cosa da fare stamattina
per sollevare il mondo e la mia specie
è di stare sul gradino al sole
con la gatta in braccio a far le fusa.
Sparpagliare le fusa
per i campi la valle
la collina, fino alle cime alle costellazioni
ai mondi più lontani. Fare le fusa
con lei – la mia sovrana.
Imparare quel mantra che contiene
l’antica vibrazione musicale
forse la prima, quando dal buio immoto
per traboccante felicità
un gettito innescò la creazione.
Una poesia epifanica e luminosa, orante e che si avvicina molto a un altro grandissimo poeta delle epifanie quale fu Mario Luzi. Ma è ancora questa componente teatrale, questo affondare carne e voce nel pathos, che mi porta a cercare ulteriori punti di appoggio per riuscire a descrivere la semplice complessità di Mariangela: mi ha aiutato (fra le altre cose) a comprendere che il teatro non è soltanto dramma, regista, attori, spettatori e sala, ma che può essere anche qualcosa di incomparabilmente superiore, un centro del tutto particolare di vita sociale e spirituale, che allo stesso tempo crea “lo spirito dei tempi”, manifestandone e partecipandone della fantasia e dell’umorismo, che è uno strumento vitale e irripetibile di autoconsapevolezza sociale inserito in uno spazio e in un tempo concreti (da Lettere a Olga di Václav Havel, Santi Quaranta 2010). Havel a mio avviso arriva quasi a recensire quella prima poesia di Le giovani parole (La migliore cosa da fare stamattina) della Gualtieri attraverso la distanza poetica che nel palcoscenico teatrale diventa punto di aggregazione umano, o come dice Havel di autoconsapevolezza sociale. Un’autoconsapevolezza che dall’epifania sa anche chiedersi il limite umano:
Da qualche parte duole
il tempo spina, la goccia avvelenata
che m’inquina, l’antico virus
sempre alle calcagna. Ospite a me
voce che si lagna vergognosa.
E questo piccolo vaso con viole
canta sul tavolino un sì di perfezione –
il suo essere qui, la sua canzone esperta
di rondini. Altissima visione.
Ingrata me. Non è abbastanza oggi
in mia disperazione
il patrocinio altissimo dei fiori.
E della sua mancanza di perfezione, della sua transitorietà:
Lavate i vostri morti. Non perdete
quel giorno del tesoro quando tutto
il caro corpo loro è una mappa
di terra d’oltremare. Piano piano
lavate gli irrigiditi morti,
con le mani toccate quel deserto,
il guscio inabitato freddo e vuoto.
Sentiteli diffusi – spalancati –
vivi più – di quando furon vivi –
liberati. È allora che s’apre
l’ostrica dura dei morti.
Una liberazione, questa della Gualtieri, che definisce un concetto del sacro comprendente un Dio che similmente alla voce è e può appartenere a tutti: Nel giorno di quel sudore /quando un Dio era nel panico / verso il tramonto, esserino anche / lui. Una poesia di luce e dolore che però in ambedue i suoi aspetti (luce e dolore) ha il pregio d’essere senza polvere senza peso (per citare un’altra raccolta della Gualtieri). Ha la capacità di una leggerezza difesa e composta da precisi e specifici ingredienti:
Questo giorno è un giorno di spine
di cose ghiacciate dentro cose nuove.
Di parole chiamate fin dal mattino
a pulire la camera mentale
tutta intasata di faccende.
Ma bisogna fermare ogni locomotiva
del pensiero, ogni muscolo servile
mettere toppe alle fessure perchè il mondo
non entri nella casa, col suo assillo
di urgenze messaggere. Cosa volete da me?
Lasciatemi un po’ sola. Un po’ silente.
Lasciatemi alla scuole dei morti
dove senza rumore si apprende
un vuoto appeso, presente nutriente.
Soprattutto il verso perchè il mondo / non entri nella casa apre a un concetto che emerge in maniera importante in questa raccolta: Sono stata una ragazza nel roseto […] sono stata una ragazza di sedici anni […] Una donna appesa. / Sono stata un uomo duro e forzuto […] Un albero / forse. Un topo. Un elefante […] Un giuramento. Un’attesa. / La corsa della gazzella. E proiettile […] catacomba. Un credo – un lamento […] E dunque – di cosa dovrei avere paura / adesso. Perchè se il silenzio chiude le porte alle urgenze, in realtà l’essere una molteplicità di attori nel teatro del mondo porta l’uomo a non avere più timore di nulla, ad essere pronto al mondo stesso proprio perchè lo ha recitato tutto. Nulla fa più paura e in questo le ferite (o almeno questa è l’opinione che mi sono fatto leggendo) perdono il loro connotato di cicatrici e diventano aperture alla conoscenza. Il corpo che si apre (e anche il cuore) non solo perde nel mondo il suo sangue ma permette anche al mondo di entrare, permette quell’atto di conoscenza che diventa un po’ di luce, abitare un bene.
La conoscenza, che in questo caso diventa orazione, non è tanto desiderio quanto contemplazione. Un’intero periodo del libro infatti nasce dall’osservazione fatta utilizzando un microscopio (Esercizi al microscopio, Mariangela ce lo dice in nota) che le è stato prestato e che continua a usare: Ogni parte / una precisa mansione. E tutte insieme / dalla vetta degli occhi / sotto l’immensa volta della notte / per meccanico alzarsi della faccia / tutte le particelle insieme sobbalzano / un istante – quasi rammentando una / sgomentante felicità. Una contemplazione che diventa certezza (e quanto bisogno di certezze abbiamo oggi!) nel senso di un punto di appoggio, di riferimento. Che poi in effetti il rito sonoro succitato, la musicalità stessa della poesia (che qui è particolarmente accentuata, non ricercata ma naturalmente fluente) siano anch’essi punti di riferimento e appoggio che Mariangela usa per avvicinarsi alla dicibilità del mondo (similmente a quanto facevano gli aedi non solo per ricordare ma letteralmente per fissare le storie narrate) è cosa che sottolinea ulteriormente questa certezza che è a tutti gli effetti una certezza del mondo. E che non potrei spiegare in maniera migliore di quanto già fa lei nel testo conclusivo della raccolta:
Io non vi credo cose che vedo
perchè chiudendo gli occhi
una vitalità di costellazioni
d’altro mondo
vi sopravanza
e la supremazia del visibile
s’incrina in felicità.
Non c’è spina
oltre le vostre sponde
niente confina o crolla
niente s’impolvera
in quella luce.
