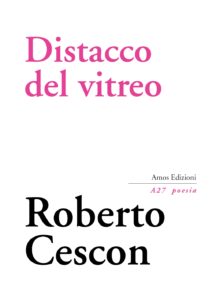
Distacco del vitreo, Roberto Cescon (Amos Edizioni 2018)
Sarebbe relativamente facile per me parlare di Distacco del vitreo di Roberto Cescon facendo riferimento alla sua storia. O a quel poco che un’amicizia alla lontana (nonostante la vicinanza geografica) mi consente. Ma considero compito della scuola comprendere i significati di una poesia e di una poetica in riferimento alla biografia. A noi, semplici lettori, il compito non di capire cosa vuole dire il poeta ma cosa dice a noi. Insomma l’opera a prescindere dall’autore.
In questo ultimo libro di Roberto (che fa seguito a La gravità della soglia, Samuele Editore 2010, e La direzione delle cose, Ladolfi Editore 2014) c’è l’impressione di un abisso persistente di sottofondo. Non tanto di una natura avversa, crudele, leopardiana, quanto di una provvidenza avversa al quale l’essere umano non si adegua non perché non voglia, ma perché non è nella sua natura.
E quando si vive tale divario tra il sé in quanto essere umano e la vita in quanto umana, ecco allora prodursi il distacco, la frattura. E per tradurre questo Roberto trova l’immagine del distacco del vitreo che bene esemplifica la dinamica appena suggerita.
Il distacco del vitreo è infatti una condizione in cui l’umor vitreo (la sostanza gelatinosa contenuta nella camera vitrea dell’occhio) tende a staccarsi dalla retina ritirandosi verso il centro del bulbo oculare. I sintomi sono: visione di corpi mobili, fotopsia e visione sfocata.
In particolar modo sono i corpi mobili a rendere tale distacco sintomatico e in qualche modo utile all’osservazione poetica. Si legge infatti che Il segno sono mosche e ragnatele / ovunque si posi il tuo sguardo, / un inganno della mente dietro / i bulbi, ma col tempo / il cervello riassetta la visione / come per la ferita che hai dentro: / presto saprai sopportare / il diaframma che preme, / tu pericoloso superstite / con la gramigna / a un dito dal cuore vedere sarà / nello spartito la nota in più. Osservazione che non resta relegata nella parola ma è riflesso e riverbero della vita, dell’osservazione della vita. Il distacco crea la necessità del riassetto che comunque si presenta come iter non facile (come per la ferita che hai dentro).
L’abisso di cui sopra è la consapevolezza che ogni percorso è greve e grave, che il distacco è la vita stessa che ci pone fuori posto (Sei uno iato fuori posto / ti allontani dalla casa / disparato contro i muri). E le reazioni umane in questo non sono misurabili, non lo sono più, perché riflettono l’asprezza del contesto.
Ma misurare se stessi è una delle condanne culturali che l’Occidente ci ha dato dopo secoli di Storia, Ecco quindi che l’autocritica, il giudizio di sé, il senso di colpa diventano il muro di fronte al quale specchiarsi e rispondersi (non potendo). Si legge infatti che Solo mai, ma sempre con / il mio nemico reticente e tenace / più della risacca, picchio sulla spalla / il frinire della colpa che mi ingessa […] Non c’è doppiofondo nella ferita, / ma occorre l’estate perdonarsi / perché la vita è sempre nel giusto. / Riva non esiste / nel cieco fiume della colpa.
La conclusione di questo percorso, che qui si è voluto fare a ritroso partendo dalle ultime poesie del libro per arrivare alle origini del distacco, è il motivo del distacco stesso: Il corpo arriva prima della testa / quando è tempo di cambiare. / Ora sogno che muoio mentre dormo, / in gola pulsa una pietra / il soffio strozzato del tuo nome. / Ho scritto al buio perché temo / di vedere quale parte si stacca di me. L’azione umana che si oppone alla realtà producendo quel distacco che alla fin fine non è conseguenza ma svelamento (L’inverno non arriva e non va, / si conficca il dilemma ad ogni passo, / ma io non ho impero / di tenere i venti dentro me […] Non so / dove ovunque andare / per sminare dubbi dagli incroci. / Un passo un respiro, un passo un respiro, / perché sei già caduto quando cadi).
Emblematici i primi versi delle prime poesie del libro: Vulnerabili andiamo verso niente / esposti alla ferita della perdita […] Il corpo arriva prima della testa / quando è tempo di cambiare. E soprattutto le rispettive chiuse: Tutto è già accaduto nella lingua / lo sguardo in apnea, in gola una roccia […] Ho scritto al buio perché temo / di vedere quale parte si stacca di me. A dichiarare la necessità del dire la realtà, l’abisso, anche se non completamente visibile perché offuscato dalla propria natura fondamentalmente contrapposta all’abisso stesso.
E se è vero che in chiusa Roberto cerca comunque di sfuggire a se stesso o meglio alla propria parola dedicando un testo al figlio Pietro, testo nel quale dichiara che Per conoscerti devi perdere, però non troppo. / Aggiusta i pezzi con coraggio, è la vita che ti è data. / Non temere di cadere, qualcuno ti raccoglierà. / Dopo il temporale l’aria si pulisce. / Ridi, che la vita è una, tale libro resta comunque uno sguardo quasi nietzschiano sulla realtà e l’abisso che sottende, sull’equilibrio che l’uomo deve tenere sulla superficie delle cose. Equilibrio che anche stilisticamente viene comunicato con una scelta estremamente particolare, sicuramente evoluta e più specifica rispetto ai libri precedenti.
Si veda ad esempio un testo tratto da La gravità della soglia:
La gravità della soglia divora
nel sangue l’istinto maroso
gettarsi in avanti come un migrante
perché c’era sempre qualcosa, avere
periodi, le mezze misure,
la paura di spingersi più in là,
persino dell’endecasillabo,
ma dovremmo essere un’altra generazione,
invece ci hanno insegnato a pensarci
neutrini senza saperlo.
La distanza del diventare è vivere
o scrivere tutti quei passi
e, mentre ti volti, già sei entrato
in un destino, come i mughetti
che fanno profumi senza saperlo.
E allora far la pace con gli anni
basta solo ricordarsi e sperare
con le immagini che sanno qualcosa.
Un testo tratto da La direzione delle cose:
La mano sulla sveglia ferma la notte
nel tempo che ancora ci prendiamo.
La tapparella taglia i contorni.
L’acqua nel termosifone è l’inizio
del giorno, le cose da fare.
Se dico ciabatte, armadio, servomuto,
so come arrivare alla porta.
La direzione delle cose è nelle parole
che dico, ma esiste prima.
Quando mi colpisce, cerco parole
per dirla, ma spesso non bastano.
Forse nel buio le cose
hanno una loro intelligenza
perché sono più di quello che siamo.
E infine un testo tratto da questo Distacco del vitreo:
Non voltarti, primavera che infiori
sopra un campo di battaglia,
come puoi salvare
chi dovrà spaccarsi il cuore?
Fatale è ferire senza volerlo.
Ma l’aragosta ricorda il carapace
che lascia sul fondale?
Non temere, ancora ci sarà gioia
e freddo: ricorda
che l’indaco si spegne
se pensi a misurare
dal centro gli anelli che verranno.
Si nota subito che il verso tende a tornare meno discorsivo rispetto a La direzione delle cose, più controllato in una struttura che comunica crudeltà dell’osservazione che non vuole schermi né filtri, che anzi si nutre della crudeltà dell’osservazione stessa. Non un vero e proprio stile aspro o involuto (si vedano certe scelte lessicali come occiduo, carapace) ma rifinito come ferita a intagliare non l’abisso né l’uomo di fronte all’abisso (che diventa abisso egli stesso), ma il rapporto di osservazione che si viene a creare.
Un rapporto fondamentalmente di conoscenza: perché non sai cosa vuoi: / solo se ti avviterai vedrai tutto / l’innumero alle tue spalle, tutto / il possibile sporgersi sul ciglio.
Alessandro Canzian
Alcuni testi tratti dal libro:
Il corpo arriva prima della testa
quando è tempo di cambiare.
Ora sogno che muoio mentre dormo,
in gola pulsa una pietra
il soffio strozzato del tuo nome.
Ho scritto al buio perché temo
di vedere quale parte si stacca di me.
Entra solo se credi
che non puoi condividere nulla:
raccontarci non doma l’abisso,
devi accarezzare la bestia
per capire che il perduto non torna
se non cucito come un’ombra
che assedia le occidue ferite.
Come bere ancora
dal bicchiere che si è franto?
Dovresti, avresti dovuto, dovevi.
Tu premi sul mio sterno con i palmi
accanita tra le grinfie dei rovi
vuoi strapparmi gli occhi e ricucirli
ma la fame combatte coi fantasmi
per franare nell’abisso.
La casa si è rovesciata nell’ombra,
il cielo esangue tra i pruni.
Non premere cieco sui remi
neppure a ritroso.
Saprai l’estate a perdita d’occhio
quando nudo ti coglierai nella nebbia:
nessun canto di sirene ti avvince
da prode contrarie
perché non sai cosa vuoi:
solo se ti avviterai vedrai tutto
l’innumero alle tue spalle, tutto
il possibile sporgersi sul ciglio.
Il mio nemico vive un passo indietro
coltivando giunti tra rotaie
perché aspettare come tutti
l’orizzonte illude che a cambiare
siano gli altri. Per questo tenta curvo
di togliere l’alone con lo straccio
ostinato a pulire, ostinato a restare,
sul punto di squartarsi
per le contrapposte conseguenze
perché la bestia brucia quando spinge
fuori l’aria e resta l’unghia.
Solo mai, ma sempre con
il mio nemico reticente e tenace
più della risacca, picchio sulla spalla
il frinire della colpa che mi ingessa
quando contumace sono con me
e ritrovarla nei cippi
ingoiati fino a farmi orrore,
perché in tutto c’è una colpa,
liberarsi è il divenire di sé.
Esposto sotto vetro ti conobbi
come una medusa di cavi
intontito dal colpo di un’accetta.
Vedevo sul tuo torso sfigurato
l’inganno dei binari da seguire
perché prima non esiste dopo,
ma da ogni punto dietro gli occhi
una luce inaudita
eri tu a vedere me –
devi cambiare la tua vita.
Distacco del vitreo
Il segno sono mosche e ragnatele
ovunque si posi il tuo sguardo,
un inganno della mente dietro
i bulbi, ma col tempo
il cervello riassetta la visione
come per la ferita che hai dentro:
presto saprai sopportare
il diaframma che preme,
tu pericoloso superstite
con la gramigna
a un dito dal cuore vedere sarà
nello spartito la nota in più.
