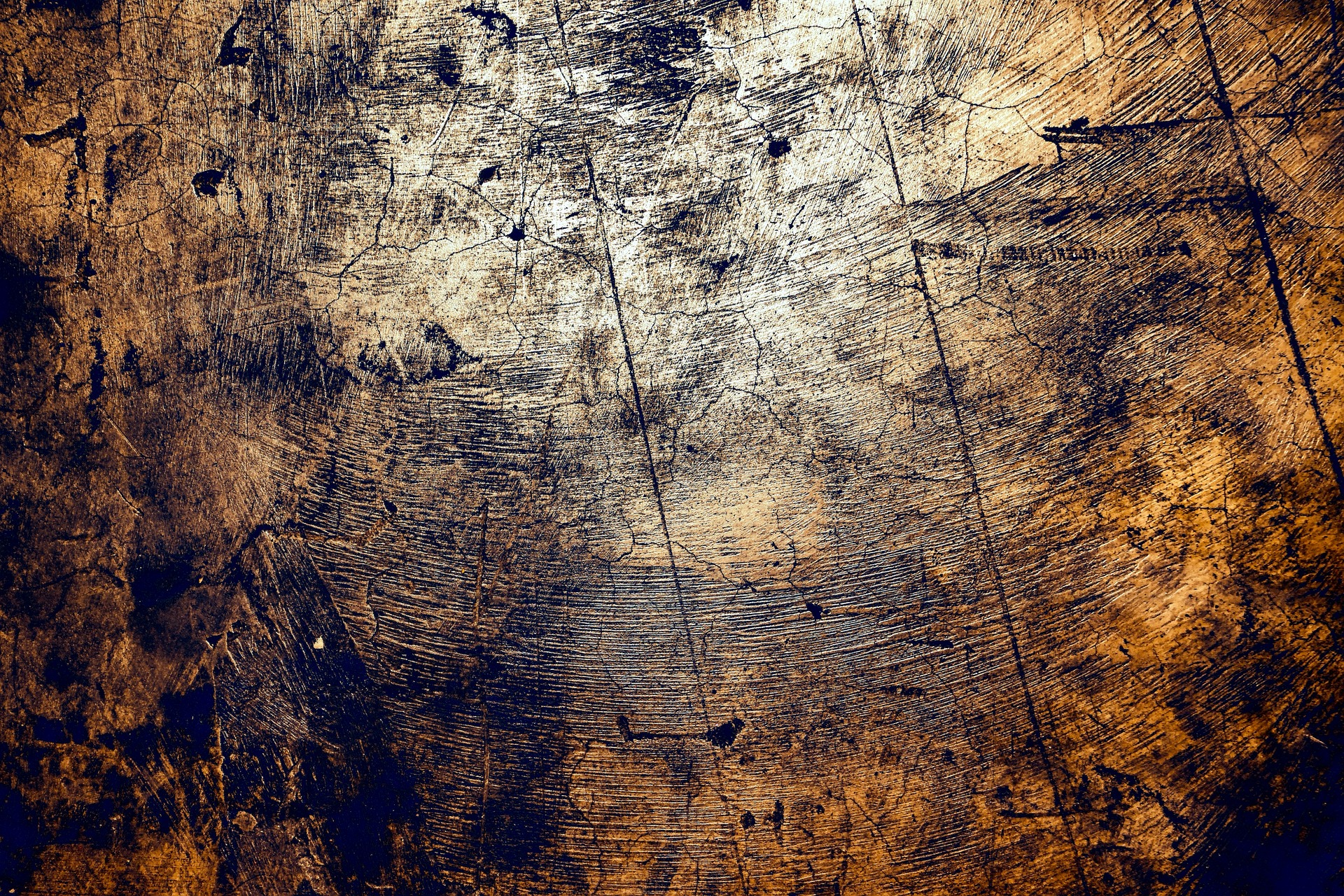
Continuano gli speciali di Laboratori Poesia. Questa settimana presentiamo Bestia divina di Mario Fresa, anteprima di un’opera in pubblicazione nel 2019.
JAVIER
1.
Sono uguali o mi conviene cominciare?
Hanno allarmati pesi: forse un parziale viso quando,
in un eccesso di verità, fanno passare
le voci intere in ospedale.
Il respiro comune perde il bicchiere; la ferita la scuso
come un cosmico libro.
Siamo più umani senza una lingua? Il fatto è che
Luisa ha un marito dimostrante; si veste, da sola,
un corpo-orecchio fino a tardi.
È un miracolo disastro: se tutto fosse buono.
Invece ha proprio una fatica da pavimento; così sta lì,
più disperata di un santo.
2.
Le ripeto: è una vacanza buona, sottile;
ma non mi crede né lei né in calzamaglia.
Tra queste cose, Luisa vuole un giorno di fame;
siede a fondo, come racconta, in un demente amore.
Che inutile memoria capitale:
sarà uno sbaglio o no?
COLAZIONE
Curiosa storia di mani che non vedo.
I due, solitari di altissima corsa, ora salgono insieme
alla vista di un lenzuolo; e stanno sulla soglia
di un cane violentissimo, gentile.
L’amica è bruna e sedia. Non è cerimoniosa,
ma si scrolla di dosso, come vorrebbe, la sua età.
Però al confronto, ripeto a Emme, noi possiamo
non parlare, non vederci; ma sarebbe,
alla fine, solo una stanza vocabolario.
La giornata, cioè, capisce lei, mamma da esclamativo:
e il cuore, se lo vedeste, ci ha un odore
marziale; fuori così.
Che fare, allora, se la testa non viene
come vorremmo noi?
Diciamo solitudine, come una specie
di sudario, interminabile caffè.
Tavolo e mostro si fissano, a lungo,
raccontandomi di te, del tuo famoso
carnivoro amante.
Papà, che somiglianza da tirannia che abbiamo noi,
partendo dalla voce fortuna di un amico mortale.
Ma loro lo conoscono, il terreno scivoloso? I tuoi veri
genitori forse sanno qualcosa, quando aprono grembiuli
o discorsi quasi ufficiali da nemico bastimento;
si salpa sui malumori parvenu.
Ma vi dicevo dei rapporti accumulati tra di noi;
così deciso a tutto, papà rinchiude
nel suo armadio, ben mantenuto,
la buona Anna e i suoi stanotte desideri-soldati.
Rimette ovunque, allora, il primo udito;
e il resto della camera sta fermo
sino al lago. Non lo perdo più di vista, mi assicura;
ma non lo sento più.
PREMI E CASTIGHI
I
Avete visto com’è spettro e bicchiere, questo corpo?
Quando la noti, si fa destino intero, come stazione in posa:
viaggio di lingua e orrendo viso di terrore.
Quasi il nostro colloquio rende
come un insetto-male che ad ogni
dolce notizia spara, dalla ringhiera, in due:
stomaco sogno che ingoia tutto.
II
Si soffre di respiro televisore; e dentro guardo te,
lucente cura: piega il muso
di dosso, forse al posto di tutto il corpo.
La soffio bene e la detesto.
Come sarà per sempre, se una volta
ogni mezz’ora cade e poi rivede
il tarlo della mano che diluvia senza fine?
Le carte s’aprono segrete sull’emicrania. Peggioro bene.
Era più vuoto e sosteneva, infine, di essere almeno
un guaio di giornata: uno che ha sempre, con sé, mobili antichi
e fame. La solitudine giura che non è bello ma piuttosto
se ne andava, a nome bianca o Sara, con una certa severa
vitalità. Anzi, una sera, fu come un cane breve
da dimostranti: e spesso, proprio da qui, tra le pareti inganno,
mostrami a dito queste carte da risposta gentile:
mostrami te; cane di vanità, sorpresa della morte.
L’amica del vento magro si chiama
con due nomi di silenzio; un po’ fune
(domani le avrei detto: giusto un po’ meno)
e, per esempio, il colmo del destino.
Ed è per questo che lei delira di anarchia.
La fissa dolce con gli ultimi, sottili rotoli
notturni sopra di sé; e sta bene sulle ossa
che si credono, quasi, un miracolo
di carne. Appena entrati nella testa delle parole
siamo mercurio, intimità.
Il regalo, nemmeno a dirlo (lo spiffera lui,
dal pieno del suo treno suicida) è essere
legati, o immobili, proprio al ragno
di questo cieco pulsante inizio:
schiacciarsi o no?
Oppure, certo, l’alternativa è diventare
un altro nome; o una mosca, diciamo, d’allegria.
Così, appena arrivati alla stazione,
mia madre cade nel dopocena
e li fucilano a salve, il giovanotto che raramente
ride e il gesto di fare piano:
converrà bene, allora, giusto
per noi – povere tigri – armarsi come fuochi
tubolari; sarà che, forse, riesco a malapena
ad essere un negozio tornato in sé,
buono per la parola fine, per le commesse
rimostranze degli ultimi arrivati; senza pena,
senza libri, sparì che fu un piacere.
E poi nemmeno sente, non bisbiglia:
fa sorrisi d’inciampo, stringe
un Valzer d’incendio
che dà vertigini; sorride.
Mi addormento, quasi sempre, mentre pesto
il respiro su tutto il corpo nube:
ci amiamo da soli la terra grassa e la marcia ruberia.
Sta nella staffa di una barca tutto insieme,
da colabrodo padrone: fuori di te, dal mondo.
Ce la scrolliamo la bestia radente
dai ragnateli puri; o forse lo rificcano
soavemente lì, col gusto
di fumarsi tutto il corpo, di andare al mercato
e poi disobbedire?
Si spezza la sete della schiena: o asfalto ricamato
oppure, a tuo piacere, si dilaga come un sogno
nell’orto. Che bucato di lampadario che sei, così
pulito da incendiario! Nemmeno il sale o un cencio preso
da una partita nuova. Anzi l’enorme cruna che fa battaglia.
Parla come le scarpe ricadute nel sentimento; brava notizia
che forse per fortuna non lo vide, nemmeno urlando
contro di me: lussuria di torace
e un incredibile virtù di patimento. E sia così.
Si dà sul viso con quella vera, cruda distanza
che c’è tra il suono e un monumento: capace appena di tirare
i piedi nudi, come un asceta piccino
che non sa contare più.
Qui le rotaie, invece, e qui l’intera linea del cervello
celeste, possessivo. Il diluvio mi starà bene, vedi;
per te abbandono mamma. Ma l’uomo sa
quanto fa specie questa sete dimora, come una santa
che non ti scrive più: certo lo ignora, chiama, risponde.
Più che altro un padrone o una scommessa:
insomma, compiere l’azione di una sommossa
anatomia di luoghi;
o un ragno di speranza.
Il paladino sta con il suo collo sotto e le parole in armi.
Il babbo, come sai, lo amò con tanti
saluti e poi sparì. Ma risero insieme del ciclone,
di un tale Servo di paesaggi, traversa dritta
che si trasforma in una fiera amica;
né sicura né interminabile casa.
Allora è un fallimento, mi direte.
Il forsennato si barrica con una certa calma; risponde
alla fame come può. Ha un sapore defilato
che gli ha lasciato addosso chi volle aprirgli,
per un secondo, un muscolo miracolo
d’attesa: e tutti a muovere giardino,
tutti a tornare al cane della pena,
alla testa dei licenziati di Merlino.
Oppure una radice, un ospedale pianta
che infine ci renderà feroci,
ricomposti.
Era una lingua, un salto. Mica per noi, mica un insulto.
Invece un asse, un panorama da ripagare presto;
se muore ovunque, starà dritto come un Goya
visto dal vivo; al re delle leggere scienze.
Così la giungla stordisce,
s’alza presto dai ragazzi ed è ben fatta:
una leale rivincita dello spavento,
prossima al colmo o a trasformarsi in un
gemello puro, in un fulmine lavoro di altri tempi.
Oppure che sia fatta, di sicuro,
di un’altra lingua più aceto:
e qui c’è madre orologio, come un istante nervo;
e poi gambe di esclamativi, miracoli di
atomici pittori.
A un solo fischio questi orecchi valanga
non vorranno più nessuna
maniera, più nessun quadro.
Non è una novità. Cadiamo.
