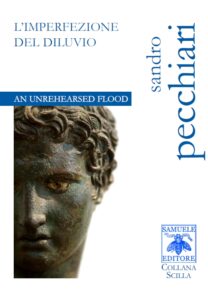
An Unrehearsed Flood/L’imperfezione del diluvio, Sandro Pecchiari (Samuele Editore 2015, prefazione di Andrea Sirotti)
Venezia, con la comparsa del carattere mobile, divenne nel ‘500 patria incontrastata della produzione libraria in Italia. Tutti i grandi autori del passato, tramandati manualmente nei monasteri benedettini, potevano ora essere stampati nelle loro maestose monografie. Tuttavia non tutti gli esemplari stampati e pubblicati erano composti da un’unica opera di un unico autore. Era anzi in voga, un po’ per economia ed un po’ per arricchire un esemplare, stampare miscellanee contenenti più opere di più autori. E queste miscellanee giravano un po’ tutta l’Italia e l’Europa. Io stesso, anni addietro ne possedetti una nella quale si trovavano assieme le Favole di Esopo, la Batracomiomachia di Omero (?) e L’Ero e Leandro di Museo. Un libro di immenso valore culturale ed artistico. Ma ciò che realmente rendeva quell’esemplare meraviglioso era la scelta dell’editore di pubblicare quel volume in un testo a fronte bilingue greco-latino.
Sarebbe stato così che l’umanista cinquecentesco avrebbe potuto approcciarsi a quei contenuti nelle due lingue, all’epoca, in auge. Il greco era la lingua del puro spirito umanistico mentre il latino era correntemente lingua d’espressione intellettuale universale. Non è certo un caso che in quel secolo nove libri su dieci fossero stampati in latino.
Ora, nel volume di poesie di Pecchiari, accade più o meno la medesima cosa, con un esito d’intento artistico pari al gemello pubblicato parecchi secoli addietro.
Accade così che l’inglese, lingua amata e studiata dall’autore, in questo caso venga utilizzato come strumento per ri-scrivere una “vera” silloge della nostra letteratura italiana. Perché Pecchiari è poeta vero e di indubbia statura artistica.
Italiano e inglese, appunto. Ma qui, precisamente difronte cosa ci troviamo? Un libro in inglese tradotto in italiano o un testo italiano reso nella lingua di sperimentazione intellettuale dell’autore, ovvero l’inglese?
Rispondere sarebbe quantomeno inutile. L’opera è da leggersi come cosa unica e, sia in una lingua che nell’altra, la sua poetica risulta costante e completa. Di certo, comunque, questo bilinguismo è qualcosa di sanguigno appartenente alle vene dell’autore.
Triestino tradotto nelle lingue di confine di là da Trieste, triestino come “quei” triestini culturalmente distanti dalle mode tematiche e stilistiche del resto d’Italia. Triestino come quei triestini che parlano di loro attraverso Trieste, i suoi tetti e campanili, le proprie appartenenze sentimentali.
Trieste, è quindi, l’inizio del libro, della prima composizione, dell’arredo scenico di una vita vissuta, inconsapevoli d’averla, nel tempo di poi, riscritta.
Dicevo di un corpus unico, di un poema come unica cosa, queste diciannove poesie legate tutte da un sommesso afflato ininterrotto. Così dopo la prima si leggeranno le altre, notando ed annotando, l’andamento di un “precipitare” verso la fine.
Già dalla seconda poesia, per il suo attacco come al centro di un discorso, si ha l’impressione di un’opera in divenire. Ed è proprio così. Così avviene che chiosando “la storia l’avremmo scritta dopo”, la seconda composizione, indubbiamente epifania di tutta l’opera, assume per ampi tratti l’andatura del “ritmo”, che negl’ultimi versi crea un moto sincopato nella lettura, quasi a volersi fare farsa e celia di singulti di un pianto asciutto. Così se la seconda poesia si chiude con quel “ricalcare i giorni” che “è già morire”, la terza ne continua, intrisa d’amaro, i motivi con quel “è virtù e colpa il nostro perdurare”. Poiché se “omnia vincit amor” la morte pone beffardamente il sopravvivere come una colpa, instillando un senso di colpa tutto tipico del reduce.
E del reduce “restato”, più in avanti esule, il quinto componimento porta l’altro “blu fondo”, oltre quello degli occhi come di una notte, che è il mare. Un mare al quale arrendersi, poiché il “non farlo insinuare” è “un gioco perso”. Il poeta, come il bambino, gioca con gli strumenti a disposizione: il mare, una “bestia”, la virtù. Ma appunto quell’insinuarsi del mare, o del male, va pari all’infiltrarsi di un fuoco in vena. È solo l’inizio di un processo fisiologico dove vita e morte, con le stesse parole, si fanno eco l’una dell’altra. È inutile, in questa blasfemia provare a portare luce che dirima le ansie, le cure e le attese insensate di un soldato in trincea cui può deflagrare, anche nel cuore della notte più quieta e timida una granata improvvisa del nemico, è vano. La vita del fronte è già un addio, uno scollamento tra la vita del “prima” e del “dopo”. Ciò che ne nasce è il “perdurare” poiché la tua notte può durare eternamente.
Ma nell’assenza patisce chi rimane, il suo continuare a pestare una terra che ha inghiottito anche quegli spazi di quotidianità che sanno solo di “vuoto”, di “senza”. Il “diluvio” che tutti torre si rivela imperfetto nel risparmiare, e così condannare, chi voleva morire “assieme”. E qui anche la silloge si prepara alla “fine”. Resta, fisso nel sempre di un tempo che ammanta l’ultimo momento, quel dolore all’apice che non scema e non scemerà. Sì, potrà creare fantasmi che si muovono nell’ostinato silenzio, quel silenzio che vince e vincerà per sempre, tra l’oggi e l’altro oggi, ma non il domani che compete ai vivi. Il reduce, anche lui, ha già dato commiato alla vita, e non farebbe rumore in questa vita nemmeno sbattendo, forte, nel silenzio le porte. Si può passeggiare, per non incontrare nessuno, puoi andare altrove, ma quell’altrove che conosci non ti appartiene più perché sei altro da questa realtà da residuato, un evanescente risultato di casi di vita svanita.
Si è ospiti in questa nuova vita. Così come ospite è colui che ospita e colui che viene ospitato sarà vera la chiusura, della raccolta, per cui chi muore va via ma, spesso, l’esiliato è colui che resta.
La messe, seminata da altri, rimane sepolta due dita sotto il fango, il fango limaccioso del “primo” biblico diluvio che uccise molti salvandone, figuratamente, i pochi migliori che meritarono di vivere. Ma nel rovesciamento della giustizia umana, dove non trova spazio nemmeno l’esclamazione di un laico “peccato”, il diluvio meschino è imperfetto, affogando a caso qualcuno e condannandone “a vita” qualcun altro a piangerlo.
Marco Strano
I
Trieste soars upstream
its gusts of air
spare with words
spears steeples
inside the horizon
exiled en route
from childhood
up there along past paths
we desert life
provided we recall
history would be written later
I
Trieste rincorre
scostante di parole
l’aria inerpicata
fiocinando campanili
dentro l’orizzonte
esuli nella rotta
dall’infanzia
lassù nelle vie di ieri
dismettiamo la vita
purché la ricordiamo
la storia l’avremmo scritta dopo
III
sprawling twigs buds or shadows
is not tendrils’ deepest calling
it’s just not that
it’s twining
to twist to bind
and then unbind them
if we can’t keep them
endurance is both a virtue and a fault
so I talk to you – not
to your unsolvable threads –
and I feel useless
ah, your clear eyes
III
non è la vocazione dei viticci
sviluppare rami e fiori e ombre
non è questo
l’essenziale è arrampicarsi
per sforzare i legami
e frantumarli
se non li manteniamo
è virtù e colpa nostra il perdurare
così ti parlo – non a te
con i tuoi fili indistruttibili –
e niente posso
che occhi limpidi che hai
VIII
to be bereft of the narrow straits
between what’s left to live
and you
freezes me in its reduction
we are the outcome of impossibility
I will not forget the cuckoos
hatched for our displacement
we fall
for want
VIII
l’essere privato di un passaggio
tra il vivere che resta
e te
mi fa immobile nella diminuzione
siamo conseguenze di una impossibilità
non perdóno i cuculi
dischiusi per la distruzione
si cade
per mancanza
XI
I can’t go before you go
witness of a life
stuffed with chemo
you shall die here inside me, in my arms
telling the spare beads of the night
but I’m losing count if I’m watching you
and with your hands I trespass
the non-time that binds
an unrehearsed flood
XI
non poter andarmene prima che tu vada
testimone di una vita
ingozzata di chemioterapia
dovrai morirmi qui dentro, tra le braccia
sgranando i secondi rimasti della notte
ma perdo il conto se ti guardo
e varco assieme alle tue mani
il non-tempo che allaccia
l’imperfezione del diluvio
