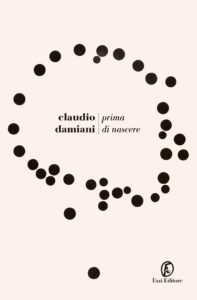
Prima di nascere, Claudio Damiani (Fazi Editore, 2022)
Come una profezia auto-avverante o una pre-visione apodittica che puntualizza e accoglie l’horror vacui originale dell’uomo, “Prima di nascere” di Claudio Damiani (Fazi Editore 2022) è un canzoniere che sonda, attraverso undici sezioni dai titoli simbolici o esplicativi, le stratificazioni cognitive e percettive dell’essere umano contemporaneo.
Non a caso, l’immaginazione di un tempo prima del tempo così come lo si ri-conosce lungo la vita, affiora nell’autore in tenerissima età: “Quando ero piccolo, quattro o cinque anni,/mi immaginavo prima di nascere/come sospeso nel cielo” e, ancora “non capivo come potevo stare, così in alto nel cielo,/dove potevo poggiare i piedi”. Tale ragionamento, frutto del pensiero stesso in giovane età – proprio come un pensiero che si pensa -, continuerà a turbare e, contemporaneamente, consolare la percezione esistenziale del poeta lungo l’arco della sopravvivenza biologica che sembra un cerchio adatto a ripercorrere sé stesso.
La sensazione di straniamento – necessaria o soggettiva che sia – si profila come un’immersione differente – ma non meno partecipe – nel magma storico-antropologico, attraversa la convivenza dell’anima con la carne e, poi, l’espatrio doloroso e inaccettabile del sé da sé e dagli altri.
La silloge inizia con l’allegoria della guerra, come se l’atto stesso di vivere fosse una risoluzione etica e politica alla battaglia, una battaglia istintiva e morbida, dagli echi epici pienamente calati nella quotidianità: “non ci fermiamo mai/-da quanto tempo che siamo partiti-?”.
Affiora, tra i versi, l’ipotesi di coesistenza della tragedia come status umano con l’imperturbabilità.
Si può (si può?) osservare la battaglia da fuori – prima di nascere – o dall’interno della battaglia stessa che può risultare, per avventura, un inaspettato locus amoenus, almeno per qualche giorno: “Stanno bombardando la città,/io oggi non combatto, sono in vacanza”.
La meta-visione nella visione, lo scenario archetipico che manifesta una modularità ripetibile, l’estrazione dell’immagine dall’immaginazione sono categorie di pensiero che diventano modalità esistenziali e che mettono a nudo la capacità dell’uomo di accettare di non bastare a sé stesso: “e io restavo solo/in un cielo completamente vuoto,/completamente solo”. Una rielaborazione all’indietro di ciò che è stato, d’altronde, ingenera un’involuzione della socialità acquisita fino all’assoluta solitudine del grembo materno e, ancora prima, del silenzio pre-esistente.
La predazione istintuale dell’uomo sulla natura (“Sì, quella lì è la farfallina azzurra./Vedi, noi le prendevamo con le dita/e ci restava sulle dita una polvere d’oro”) determina il capovolgimento del destino nell’azione, nella consuetudine delle ere personali e sociali che si accavallano in vortici centripeti il cui nucleo, ancora, è oscuro e ritorna all’uomo in dettagli non trascurabili di realismo: “Quella polvere, se tu strofinavi/per mandarla via/diventava nera/e non andava via”.
Un dialogo tra soggetti indeterminabili apre la via alla trasfigurazione dell’avanzamento antropologico futuristico in una tensione futuribile. Il mutamento della forma verbale da attiva a passiva (tu lasci, ti lasci) sancisce un moto di abbandono della particella pronominale al vuoto. In tale abbandono, il soggetto si scopre capace di conservare la radice di partecipazione proattiva a sé stesso, pur nella consapevolezza di non poter controllare molte delle condizioni ontologiche che lo ineriscono.
Una visione intera è ex-straniata: accetta la macchinazione aliena all’uomo, se ne rende compartecipe in un “salto nella comunità” che vuol dire morte o ritorno, evoluzione e involuzione sincrone.
Da un punto di vista invertito, l’evento della nascita è l’accesso all’inconsapevolezza, è il trauma del nulla che si rivela nel confine o nell’assenza di confine con l’ontologia, è l’impatto della tecnologia ambientale con il logos strutturale.
L’ipotesi del decisionismo esistenziale affiora nel flusso discorsivo dei versi, i quali manifestano la loro vocazione maieutica attraverso locuzioni apparentemente colloquiali. Il linguaggio è semplice, conciso e disinvolto pur mantenendo il fascino dell’irrisolutezza onirica: “E se fosse che siamo noi/che siamo voluti essere,/siamo noi che abbiamo voluto nascere/con una spinta”.
Un eracliteo scorrere si palesa nella narrazione lirica del paesaggio che si riflette negli occhi, prende parte allo sguardo pur rimanendo separato nel suo spezzamento a opera dell’uomo. Un attimo più tardi – che può coincidere con l’attimo stesso della creazione e della distruzione – l’ambiente si ricompone in una posa memoriale che ha lasciato andare via il tormento dell’esperienza: “Adesso però il poggetto è ritornato intero/e nella memoria giace dritto contento”.
La nominazione di elementi naturali (“Femio e Demodoco, i due cipressi in fondo al giardino”) con nomi umani e letterari rielabora la relazione della storia dell’uomo con quella della natura nella puntualità aforistica del verso: “sì che io mi accorsi che la natura ogni giorno/era diversa, e non la storia).
Avviene una sorta di contaminazione epistemologica tra la natura e il sapere, tra il paesaggio e l’uomo che lo abita e lo vive. “E se fosse che è tutt’altro? (…) ci hai mai pensato?”.
Torna l’abbandono del sé come ritrovamento della propria impronta nelle cose. È la disinvoltura del ricordo unita all’insolenza della dimenticanza che potrebbero svelare qualcosa del futuro e non soltanto di cosa è stato.
Il centralismo monolitico dell’oggetto si staglia a confronto del repertorio di finitezza (e finalismo) della materia organica vivente che arranca in un breve perdurare, e poi scompare. Il confronto della mortalità dell’uomo con la durevolezza delle cose sancisce uno squarcio emotivo e, poi, restituisce la sopravvivenza dell’essere proprio attraverso la sua tensione alla scomparsa.
La sospensione dal non essere è un trauma revocato dalla nascita, dall’esperimento del tempo nella pienezza del tempo stesso. Questa pienezza, però, è irrevocabile: “ora invece so che ho vissuto/tutto il tempo per tutto il tempo che è stato/e non c’è nessuna cosa che non ho veduto”.
La natura sembra sopperire alle lacune delle costruzioni umane, che siano le cittadine o le scienze dell’attualità. Non manca nulla nella triangolazione sofferta tra natura, artificialità e soggettivismo umano.
L’idea di immutabilità parmenidea – quell’essere antico che continua a dirci che non può non essere – si relaziona all’intuizione epicurea della casualità degli eventi. In che posizione si trova il poeta nell’atto di vivere attraverso la poesia, essente necessario eppure incline all’incalcolabilità?
Verità e mistero si palesano come prismi focali apparentemente antinomici, fungono da caleidoscopio della realtà nell’avvicendamento di immagini e percezioni.
La domanda interiore sopraggiunge in modo dialogico e logico, chiede senza domandare, si risponde nel non rispondere come il tempo costituito da frammenti imponderabili che si vivono e si trascorrono in una microeternità indicibile. “Ma veramente ti sembra/di non essere mai nato?”. È questo il dilemma.
Cosa si può dedurre dall’ambientazione trasognata della natura? “Il” dio, che non è una, trina e alcuna divinità, accoglie l’uomo come essente nativo del mondo: “Che il dio ci ama e ci coccola/anche se noi siamo all’oscuro”.
Da questa oscurità, però, emerge una consapevolezza panica che controbilancia ogni dubbio ontologico: “Sei tutt’uno con il cielo, con la terra, le piante,/sei tutt’uno con le macchine anche”.
Il peso specifico di ogni singola esistenza è la circostanza dell’attimo di vita responsabilizzato o responsabilizzante alla sua vacuità, attraverso la chiave interpretativa dell’accettazione della nostalgia.
Dire che “non ci sono speranze” è ammettere di essere fragili. La fragilità è la chiave di volta che mantiene in equilibrio la speranza di sperare come scienza infinita del finito.
Lo sforzo di questo “scrivere, continuamente scrivere” è di “spingere la mente” lì dove non arriva, fino all’infinitesimalità dell’atomo, della radice, del nucleo originativo. Solo così, forse, sarà possibile scoprire il luogo interiore – e non mai esteriore – ove sfuggire alla morte.
Alcune prose brevi compaiono come narrazioni della narrazione. Sembrano contenere echi della parabola evangelica e invocare la salvezza dalla dimenticanza del padre ma padre non è per forza un dio e l’uomo non è per forza il sacrificio incarnato. “In verità” si può dire, ancora.
Il tono colloquiale e allocutorio di queste poesie interviene a sfoltire la consuetudine tipica della retorica letteraria, estromette il manierismo dal verso pur conservando la suggestione evocativa del dettaglio.
Il dato reale e quotidiano apre un varco (o uno squarcio) nella dimensione empirica per ricercare la metafisica che non appare – non sempre – come una relazione con il soprannaturale bensì come una compenetrazione sincretica tra le dimensioni appartenenti all’uomo, non tutte coscienti: “Era come se il mondo fosse tutt’intero dall’altra parte di lui, come se fosse stato lì ad aspettarlo, pronto”.
È concepibile la sopravvivenza prima del vivere? Se si appoggiasse la tesi della domanda aperta e diretta, il poeta sarebbe in cerca della sua perduta sorveglianza sul tempo. Se si accetta, invece, la tesi della domanda retorica, il poeta sa ma, pasolinianamente, non può dire.
D’altronde salvezza e sacrificio coincidono nella partecipazione alla magnificenza universale.
Nel dialogo con il monte Soratte, l’umanità impaziente e tesa al futuro si mette a confronto con la natura testimone di caducità.
Affiora un’altra dicotomia, quella tra la tecnica e l’arte, espresse entrambe in una koinè culturale agglomerante. L’arte è la coscienza della tragicità che spinge l’uomo all’umanità.
Il poeta entra in dialogo anche con il gatto, simbolo di saggia indolenza che rievoca ascendenze crepuscolari e nichiliste. Quanto pesa la morte nell’ecosistema di un uomo pregno di pre-occupazioni e in quello di un piccolo soggetto non umano che si occupa, semplicemente, di vivere?
Si può aspirare, però, a una resistenza collettiva, civile, possibile attraverso la comunità: “Noi dobbiamo solo stare insieme,/se stiamo insieme sarà più facile morire”.
Nella concettualizzazione di azioni e reazioni antinomiche fra loro, il poeta riflette sulle potenzialità dell’individuo plurale capace della memoria come atto di consapevolezza: “Stiamo cadendo in un vortice. Cadiamo, ma al tempo stesso, stiamo. Mentre cadiamo facciamo tutte le cose”.
La sospensione del lancio nel vuoto del trapezista, l’attimo di intervallo di equilibrio “come dice Severino” è quella percezione, prima del pensiero che la pensa, da cui si visualizza l’abisso precedente al bambino, successivo al bambino (“La vita nasce dalla vita,/e la morte?) e durante tutta la vita da adulto dell’uomo appeso a niente.
Nella natura, però, forse c’è una parola nascosta, conoscibile, sovra etnica e preater-semantica che bisbiglia all’uomo chi egli possa essere.
Se ciascuna piccola cosa esiste nella sua indescrivibile complessità, forse anche ciascun elemento esiste in una necessità reciproca e irripetibile ma questo si può esprimere solo in quella forma d’arte logica che è la filosofia e in quella forma di scienza dell’etica che è la poesia.
Gisella Blanco
Quando ero piccolo, quattro-cinque anni,
mi immaginavo prima di nascere
come sospeso nel cielo (non so se qualcuno mi aveva
detto
queste cose, o me l’ero immaginato io),
mi sembrava incredibile non essere esistito prima
e mi sembrava incredibile pure di essere esistito,
non capivo dove potevo stare, così in alto nel cielo,
dove potevo poggiare i piedi.

L’essere, e tu sei con lui.
Sei tutt’uno con il cielo, con la terra, le piante,
sei tutt’uno con le macchine anche
e coi neutrini spersi nell’etere,
sei tutt’uno con gli altri uomini anche,
anche con i peggiori nemici,
sei tutt’uno con quelli che odi,
in verità li ami, e non lo sai.
Guarda il cielo come si china sopra di te
e ti accarezza. Guarda l’aria
come ti bacia le guance
e le donne più belle, guarda come ti desiderano
senza saperlo, ognuna di loro
ti vorrebbe sposare e baciare per tutto il tempo
della sua vita e stare sempre con te.
Il mistero così fitto
e noi così fragili
che non ci sono speranze
o meglio, possono esserci solo speranze,
la speranza la nostra scienza.

