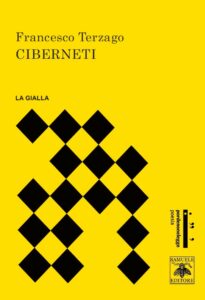
Ciberneti, Francesco Terzago (Samuele Editore-Pordenonelegge, 2022, collana Gialla).
«Cibernetica» è termine articolato, ma si può asserire che è quel campo di ricerca nato verso la metà del XX secolo, prefiggendosi l’interdisciplinarietà necessaria per tracciare uno studio comparato fra sistemi naturali e artificiali, avvalendosi, fra le altre, delle conoscenze della matematica, della biologia, dell’ingegneria e della filosofia.
Tramite un linguaggio ultra-specialistico, anche Terzago sembra percorrere quella che pare già consolidarsi come una scia, un filone letterario che, dopo anni di periferia e perplessità, sembra ora tornare in auge con maggiore seguito (soprattutto in alcune prove recenti di giovani autori, nelle quali il registro adottato è quello tecnico-chimico-scientifico). Ad essere invece più inusuale in Ciberneti (Samuele Editore-Pordenonelegge, 2022) è la svolta fantascientifica, macro e micro-tecnologica, di cui sono intrise queste pagine; e che, invero, dopo i grandi albori della prosa letteraria degli anni Quaranta, è sopravvissuta perlopiù sotto forma di rivisitazioni, adattamenti o riscritture per sceneggiature cinematografiche, senza sbarcare mai con convinzione nel panorama della poesia.
Questa commistione, tuttavia, comporta dei costi nell’economia poetica: ci si trova difatti dinanzi a una poesia-automa che diviene quasi impersonale, svincolata dal giogo letterario del pathos, e nella quale l’io lirico tramonta nell’onnipresenza dell’elemento meccanico-tecnologico (attrezzature, elettromandrini, verricelli, valvole, robot, ecc.), anche se ciò che sembra dunque tralignare dal poetico a causa del proprio oggetto e del suo linguaggio, può ritornare poi alla poesia tramite l’ampiezza delle sue stesse radici, attraverso l’etimologia della stessa téchne.
A onore di precisione, ciò che è veramente onnipresente nell’opera non è l’elemento tecnologico in sé, ma il suo rapporto dialogico, il suo coabitare dissonante e non con l’ambiente naturale circostante; fosse anche solo per un accenno, un lacerto in chiusura apparentemente insignificante. Non a caso ad aprire Ciberneti è la costruzione, in un luogo ameno, di un Buddha (simbolo per eccellenza di consapevolezza, spiritualità, ritiro ed essenzialità) di oltre cento metri, per mezzo di dinamite e invasivi macchinari.
Ad assurgersi a soggetto di queste pagine è infatti lo scontro, il ribaltamento e via via la fusione, l’ibridazione fra il tecnico-inorganico-contingente e il naturale-organico-atemporale: così «il dio guerriero ha le sembianze / di un personaggio dei videogiochi», i «capezzoli» divengono «dritti come antenne», e un «matrimonio / di plastica può durare per sempre se entra / nella carne»; in eguale maniera, scendendo coi verricelli, dal fondo di uno scavo «il cielo / è un asterisco e le pareti sono lucide / come vetro meteoritico o la gola di un vitello», infine «i robot faranno avanti / e indietro […]. Mentre gli uccelli / insediati e le volpi volanti, a poca distanza, / copriranno con i loro versi il fischio delle fresatrici».
Il dettato di Terzago non si limita a esporre l’ibridazione, ma tenta di svilupparla, di farla sua. La parola del poeta deve sacrificare dunque il lirismo in vece di una componente maggiormente discorsivo-espositiva (si notino le numerose parentesi, gli ecc.). E al fine di aderire e tradurre l’oggetto di cui tratta, le immagini proposte vengono spesso invertite grazie alla similitudine rovesciata del Realismo terminale. Il verso lungo, seppure privo di sfrangiature, si distende e precipita ben oltre la lunghezza della pagina, sfiorando a più riprese la prosa e restando però sorvegliato in una forma mai distensiva. La struttura della raccolta non prevede nessuna suddivisione in capitoli: l’opera risulta piuttosto pensata come un solo movimento, disarticolato nei vari segmenti di un’unica catena di assemblaggio, di una imponente colonna vertebrale meccanica.
Esondando non di rado nella lingua piatta (del rendiconto, dei bilanci, del manuale tecnico d’utilizzo o della pianificazione dell’iter operativo), il messaggio veicolato non può cedere alla rappresentazione cinica, deragliando così dalla spersonalizzazione che qui intende abitare. Il risultato sarà allora l’indifferenziazione, il raffreddamento: «nel caso / in cui l’imperizia, o la distrazione, degli addetti / ne comporti il ferimento, è fortemente raccomandato / di impedire che il materiale ematico / raggiunga il sistema di ricircolo dell’acqua. / Ciò potrebbe usurare i filtri». Parimenti, quello che potrebbe essere dapprincipio interpretato come sarcasmo, possiede semmai i processi di una I.A., tanto logico-ineccepibili quanto disarmanti: «i supervisori devono accedere all’impianto / in condizioni di assoluto riposo, la totale / dedizione alla missione / aziendale è garantita da telecamere / di sorveglianza e ulteriori sistemi / di monitoraggio. Poi la disponibilità / di beni di conforto: distributori di caffè, / tonici stimolanti e papaya disidratata. / Le cabine di controllo sono tinteggiate / di azzurro primula e danno su siepi alte / di ponciro che trafiggono i volatili più incauti. / I supervisori, ogni quattro mesi, / saranno sottoposti ad analisi del sangue / e del capello e a maggiori accertamenti / psicofisici. In questo modo la direzione / promuoverà la dieta mediterranea scongiurando / il consumo di sostanze stupefacenti». Qui l’uomo stesso necessita delle adeguate cure preventive per inibire la propria usura-inefficienza e, seguendo la lettura di Baudrillard, diviene oggetto fra gli oggetti, appendice di essi, fino ad ambire alla loro identica capacità di performance.
Attraverso un infittirsi di corrispondenze, echi e sovrapposizioni con la natura, lungo il corso delle pagine l’elemento tecnologico si fa sempre più iper-tecnologico e mimetico, dunque imitativo, dunque preponderante. Le corrispondances di Baudelaire vengono così proseguite fino a raggiungere la loro stessa perversione. «La Nature» non è più «un temple», un luogo sacro di simboli, rimandi e fusione, ma distopia, centro di sfruttamento o imitazione artificiale di sé.
La matrice dialogica prima accennata non può che risolversi nel fallimento, giacché «due realtà che procedono / in una direzione temporale differente / non possono comunicare».
Probabilmente «un giorno le macchine potranno guarire e / ci insegneranno a guarire», anche se non sappiamo a quale costo. Tuttavia, se la robotica e il progresso tecnologico sono inevitabili – e per molti auspicabili –, lungi dal catastrofismo, la conseguente e sotterranea alienazione dell’individuo non è inverosimile. La prima legge della robotica di Asimov andrà allora ricordata, garantita e non tradita, o rischierà di restare pura utopia, letteratura, bonaria ingenuità: nient’altro che fantascienza.
Dario Talarico
Cuoio
Il vetro corrugato ha le stesse increspature
della mia busta da bagno di pelle sintetica.
Ne esistono un milione, sono distribuite
in tutto il mondo, queste buste.
C’è una sovrapposizione perfetta. Ho aperto
la finestra e l’ho messa dall’altra parte, la busta,
dietro di lei c’era la luce anodina della pioggia e,
davanti, quella di una lampada alogena. Muovendo
ho trovato ogni corrispondenza: come una mano
sinistra ferma a pochi millimetri da uno stagno oppure
una moneta che, sollevata in aria, confonde il suo colore
con quello del disco solare, spento, tra i palazzi.
Sono state impresse, entrambe le superfici.
Hanno avuto lo stesso modello:
un pezzo di cuoio. Cuoio venuto da non so
quale bestia morta, e poi morta dove, e perché.
Morta, se per questo, almeno mezzo secolo fa:
considerando lo stato degli infissi, il mastice crepato.
Comunque, ammazzata da qualche gente,
con quali strumenti poi non so; di notte, di giorno; per fame,
per tenersi al caldo o per tenere al caldo qualcuno.
Flessibile
Un improvviso gelo, poi una sensazione, al dito,
di quiete. Il flessibile che gira con stanchezza
proietta il sangue sul pavimento verniciato di verde,
così sul basamento zincato – che sembra
uno sfrigolio led all’apice dei circuiti.
Pulire quando il lavoro sarà finito.
Non dici nulla. Prendi il rocchetto
del nastro isolante e stringi la carta assorbente
sulla ferita, incapsulandola. Riaccendi
il flessibile. Pareggi il ferro e poi guardi
in direzione delle cassette di plastica:
le bocche di lupo impilate una sull’altra.
Pensi al loro contenuto, alle viti di acciaio
inossidabile, ai gomiti zincati. Alla loro
immediata sostituibilità e resistenza
a fatica, alla loro sincerità. Dai un tiro
alla sigaretta e quella svampilla. Poi
ti massaggi le cervicali lamentandoti
con te stesso di quella ulteriore
perdita di tempo (due realtà che procedono
in una direzione temporale differente
non possono comunicare).
A quel punto li vedi. Sono sotto al banco.
Incastrati gli uni sugli altri, così
da occupare il minor spazio possibile,
gli elementi che sono stati sostituiti
nel rinnovamento dell’impianto perché quello
possa tornare a produrre. Qualcuno è coperto
di concrezioni calcaree, una statua di coralli morti,
una patina che sarebbe troppo oneroso rimuovere
per dare chiarezza ai lineamenti. Altri, ossidati,
forse non garantiscono più le prestazioni meccaniche
per le quali gli insondabili progettisti li hanno
inseriti nel disegno [il corpo dei macchinari
è inalterabile]. Il corrugato, però, spezza l’ombra,
taglia il confine, e quasi raggiunge il piede sinistro
con qualche tubicino blu e cavi sfribrati.
Ti trasferisci in loro. Le cellule si combinano
al reticolo cristallino dei minerali, della perlite,
vedi gli spigoli perdere gradualmente ogni gibbosità.
Le filettature ripristinarsi, elica innocente
di una chiocciola. ogni asperità superficiale è
un ematoma che si riassorbe.
Un giorno le macchine potranno guarire e
ci insegneranno a guarire.