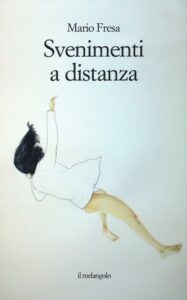Michele Paoletti intervista Mario Fresa
Come sappiamo lo svenimento è una momentanea perdita di sensi, ma il deliquio, ovvero l’origine profonda del termine, è strettamente connesso ad un mancamento causato da un’emozione soverchiante (fonte web). É in questa chiave che, a mio avviso, vanno letti i testi di Mario Fresa (facenti parte della raccolta di prossima pubblicazione Svenimenti a distanza, Il melangolo ed.). In queste poesie la parola non è un rifugio, non riesce a contenere tutta l’emozione, si contorce, scarta e genera emicranie. Non esistono riferimenti certi, un luogo esiste almeno cinque volte, i nomi [precipitano] giù dall’ascensore e rifugiarsi dentro significa fronteggiare un mostro/che ha un solo desiderio, quello che i fatti si trasformino in certezze, che il silenzio [venga] messo presto in discussione. Ogni verso fluisce e si ribalta nel verso successivo, i personaggi evocati sono attraversati da una sorta di febbre intermittente, una ricerca di senso e di equilibrio, una continua tensione verso un altro (ho fretta della tua voce) che non ascolta e non risponde e, forse, questa distanza più o meno consapevole rappresenta una salvezza nell’attesa.
Ho provato a dare un’interpretazione al titolo della raccolta, ma mi piacerebbe approfondire con lei. Cosa rappresentano questi svenimenti a distanza?
Tutti, o quasi, i personaggi che abitano lo spazio dei miei testi, sospesi tra la prosa e il verso, (e tra il saggio e l’autobiografia), si pongono in una sorta di auto-smacco e di auto-esilio: perdono loro stessi, svengono, si disfanno del loro io (accettano, insomma, la visione buddica di intendere tutta la realtà come illusione e impermanenza). Ognuno di loro, a un certo punto, cambia la propria vita, rinnega tutto e si ritira, scompare, dà forfait. (Ciò lo fa, per inciso, anche l’autore: e, dunque, la stessa “autobiografia” che prima si citava è, forse, solo una fòla, una riscrittura del vero, un’opera buffa, un travestimento). Tutti questi smacchi-svenimenti, infine, li ho immaginati come “distanti” (nello spazio e nel tempo) ma pure comuni e condivisi da ciascuna delle figure rappresentate.
Mi hanno colpito molto i versi Per essere felici, / apriamo i nervi ottici e stacchiamo l’ombra netta / alla radice: un modo di spezzare il tuo cervello / quasi perfettamente in due. Sembra quasi che per raggiungere la felicità occorra scindere gli emisferi, da un lato l’istinto, dall’altro la razionalità.
Tra le possibili soluzioni per intendere i versi, vorrei suggerire questa: per essere (e pur di essere) felici, vogliamo illuderci che sia proprio o soltanto la felicità lo scopo ultimo da raggiungere o la strada migliore da percorrere (ma chi ha detto che non sia meglio, più semplicemente, porsi al di là del desiderio?); e per conquistarla, questa benedetta e in realtà impossibile felicità, noi facciamo molte cose tanto assurde, quanto insensate (come, per esempio, cercare di staccare, di dividere un’ombra dal suo corpo; cioè dalla sua radice). In ogni caso, ci si rompe solo il cervello (perché ci si illude, intanto, di averne uno): e davvero noi crediamo, insomma, di poter fare qualcosa di logico o di stabile o di duraturo; o di possedere sul serio qualcosa che possiamo definire un “io”. E senza alcun risultato, poi! Dovremmo smetterla, una buona volta, con questa stolida illusione di esserci o di essere qualcosa o di poter volere qualcosa.
Amare, essere amati sono forme inevitabili di vulnerabilità?
Non sono inevitabili; ma ogni aspetto del mondo ci può rendere, infine, vulnerabili. Alla parola amore vorrei sempre sostituire la parola karuṇā: una compassione alta, disinteressata e assoluta, perché senza sentimento “personale” (e priva affatto di sentimentalismo). Si potrebbe, così, nell’adottare una simile nobilissima compassione, imparare ad amare sul serio: cioè senza alcuna finalità (e così la finiremmo, in questo modo, chissà! perfino di voler desiderare, o di assoggettare o di controllare quella che noi definiamo realtà…).
Nei suoi testi, la parola non rappresenta mai una certezza, spesso descrive la realtà e poi la ribalta, mostra e confonde, apre numerose vie di fuga. É così? E la poesia?
Preferisco il suono alla parola, la musica al testo, l’eco alla presenza, l’allontanarsi al precipitarsi (e il precipitare al riemergere). L’augurio che si rivolge, da parte mia, al lettore è quello di non ritrovarsi, di abbandonare la propria casa (nel senso auspicato da Juan de La Cruz). Chi legge o chi ascolta una scrittura d’arte non dovrebbe far altro che dissentire dai propri pensieri, dalla propria finta immagine (e dal poeta che legge): e solo nella direzione di questa dolce crudeltà sarà possibile superare sé stessi e divenire, infine, un autentico amico stellare del poeta che si sta interpretando.
Quali libri stava leggendo mentre scriveva queste poesie?
Libri, tra gli altri, di Coccioli, Thomas Mann, de Musset, Clerc, Weil, Jünger, Saramago, Bortolotto, Fofi, Roth, Quignard, Butor, Morante, Goethe, Canetti, d’Annunzio, Campo, Ceronetti.
Mi siedo fingendo di essere un suono
interminabile. La strada arriva a te, cotone d’aria,
per essere guardata
con autentica pazienza da chi parla,
da chi risponde: «Non l’ho sentito per nessuno, mai. Te l’assicuro».
Prova a spezzare le tue movenze in quattro,
come un avaro mostro che gioca
senza riguardo a ricercare me, nello spedale
delle parole vinte o sottili:
topi di artiglieria che vengono alle mani,
se tu gli muovi guerra; e così sia.
Alcuni gli vogliono bene quanto basta, felice purgatorio
senza vele – e lui così, turbante sulle gambe; occhio sparito
fin dal principio; si sposerà? –. Eppure adesso gli sale
tra le gote un vento leggerissimo che resta
senza pace. Poi lascia la nostra roba all’aria,
e nel silenzio messo presto in discussione (gridare
dalla finestra fino a volersi rovinare proprio il mento,
le gambe, la prossima stagione…).
Più centrale, più acuta. Se ne ricorderà.
Ecco la luce che fa più uguale, adesso,
il tuo veloce sguardo al mio.
I nomi precipitati giù dall’ascensore, o semiaperti,
dimenticati; confusi soprattutto per il caldo innaturale.
Un accidenti che vuole proprio me, anche se dice
di non sapere amare.
Se qualcuno, cioè, gli vuole bene,
non lo dirà proprio a nessuno.
Mai rendere pubblico un disastro.
Un luogo esiste almeno cinque volte.
I successivi due anni nessuno ne sa niente e lo teniamo
a bada, giusto ai confini della guerra. Per essere felici,
apriamo i nervi ottici e stacchiamo l’ombra netta
alla radice: un modo di spezzare il tuo cervello
quasi perfettamente in due.
Accade, allora, che lui – nel centro del dolore –
torni ogni giorno al mio indirizzo.
Riprovano a lasciarci sulla rotta,
senza mutare o restando con una certa età;
viene da dentro, come se lui non fosse un mostro
che ha un solo desiderio: passare dal fatto alla certezza pura.
Facciamo il tutto esaurito.
Se non ti volti nemmeno adesso – è tutta qui la mia
speranza – tu dormirai nel nulla,
come salvato dall’attesa.
Inediti tratti dalla raccolta Svenimenti a distanza