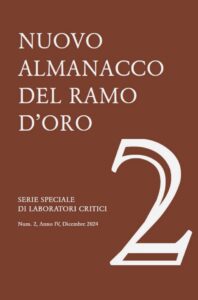È uscito il Nuovo Almanacco del Ramo d’oro num. 2 dal tema paura/paure. Proponiamo l’interessate articolo di Damiano Cantone.
Dobbiamo essere estremamente grati alla paura. Ne va della nostra sopravvivenza, letteralmente. È per paura che abbiamo imparato a costruire le nostre case, dapprima capanne e ora grattacieli di oltre cento piani, per difenderci dalle intemperie e dormire al riparo dagli assalti degli altri animali. Sempre per paura abbiamo sviluppato la manualità, per costruire utensili che incrementassero la nostra forza e la nostra precisione, che ci dessero un senso di sicurezza e di possibilità di resistere in un ambiente che di certo non ci ha risparmiato i pericoli. Per lo stesso motivo, la paura, abbiamo inventato gli dei, le religioni, la filosofia e la scienza, per dare un senso all’orrore del caos e del nulla che incombe e ci aspetta alla fine delle nostre esistenze. Saggezza della natura, emozione primaria comune a tutti gli uomini e a gran parte degli animali, ha guidato il cammino dell’Homo Sapiens fin dalla sua comparsa sulla Terra. Interrogandosi su quale fosse stato il motivo della nascita delle società umane, Thomas Hobbes scoprì che la paura è anche la forza che spinge a vivere insieme, che sta a fondamento di tutte le nostre forme sociali: essa è nient’altro che la “ragione naturale”, una forza civilizzatrice, razionale, che spinge a rinunciare al dominio individuale su tutto per accettare la fastidiosa vita regolata in comune, in cambio della sicurezza e dell’incolumità. Certo, è una paura, quella di Hobbes che definiva se stesso “fratello della paura”, di tipo ben diverso dal terrore attonito che devono aver provato i nostri progenitori davanti alle manifestazioni di potenza incontrollabile della natura bruta. È un’emozione più riflessiva, calcolata, che paventa i danni futuri che possono derivare da una competizione individualista e generalizzata.
Inoltre, soli tra tutti gli altri animali, sappiamo di dover morire – ma non è questo il punto – e siamo in grado di immaginare, anticipandolo, il momento della nostra morte, il tempo in cui non saremo più. La paura infatti guarda al futuro piuttosto che al presente, un domani abitato da preoccupazioni, timori e ansie. Con una bella immagine, Hobbes ci dice che «tutti gli uomini, e specialmente coloro che vedono troppo in là, si trovano in una condizione simile a quella di Prometeo: infatti, come Prometeo (nome che tradotto significa l’uomo prudente) era incatenato sul monte Caucaso, luogo da cui si gode un’ampia vista e in cui un’aquila che si nutriva del suo fegato ne divorava di giorno quanto ne ricresceva durante la notte, così quell’uomo che, preoccupato del futuro, guarda troppo avanti a sé, ha il cuore tutto il giorno roso dalla paura della morte, della povertà o di altre calamità e non trova quiete né tregua alla sua ansietà se non nel sonno».1 E infatti Prometeo è prudente perché, etimologicamente, pensa prima di fare le cose, le pre-vede e, letteralmente divorato dall’ansia, si mette al riparo da tutte le sventure che possono succedergli. Attenzione: in questa prospettiva, non è che i mali derivino dalla paura, ma anzi la paura è la risposta più logica ai mali del mondo, è un calcolo che mi rende lungimirante. Se infatti suppongo negli altri un’analoga paura di morire, ecco che tutti saremo d’accordo nel concludere che è meglio allearsi, federarsi, stare insieme secondo delle regole anziché combattere gli uni contro gli altri in uno stato di perenne incertezza. Certissima è la morte, la cosa che fa più paura ai viventi: certissima ma ignota, quindi la paura ci spinge a conoscere, a controllare, a prevedere, a sapere, a padroneggiare il caso e a ripararci dai suoi colpi. Non ci sarebbe paura se non ci fosse un futuro, dunque, e se pure il traguardo e il premio delle nostre esistenze è uguale per tutti, cionondimeno cerchiamo di rendere il percorso che ci separa da esso il più lungo possibile e, sperabilmente, privo di troppi dolori. E in effetti è anche del dolore che abbiamo paura, anzi soprattutto del dolore, perché la morte rimane un punto astratto nel tempo cui non pensiamo troppo – a meno che non sia troppo tardi per noi – ma il suo ambasciatore, il dolore, è uno sgradevole quanto onnipresente compagno di viaggio.
Era stato Aristotele a legare la paura ai mali futuri piuttosto che a quelli presenti,2 mali che temiamo nella loro natura di minaccia – la vecchiaia, la malattia, la miseria – e che quindi affannano il nostro presente nel tentativo di evitarli o perlomeno di guadagnare ancora un po’ di tempo.
E a nulla vale in questo il quadrifarmaco di Epicuro, poiché la ragione non riesce mai a liberarci dalle paure fondamentali, paura del giudizio di chi amiamo, della morte, di non poter raggiungere la felicità, del dolore. Il tentativo stoico di controllare e negare le emozioni attraverso la razionalità è paradossalmente il più folle degli atti, o come osservava Agostino: «non provare il minimo turbamento finché siamo in questo luogo di miseria non può avvenire senza una grande durezza d’animo e un grande istupidimento del corpo».3 Perché sì, la paura si prova col corpo, oltre che con la mente e l’anima. E non si intende solo la reazione di attacco o fuga, la sudorazione, l’accelerazione del battito cardiaco, la dilatazione delle pupille di fronte all’orrore o agli eventi terrificanti, né la paralisi da panico, ma lo stato di tensione e stress continui che si genera nel nostro organismo quando siamo in preda all’ansia (paura che possano succedere cose spiacevoli, o che non accadano cose che desideriamo intensamente), o la morsa allo stomaco e il respiro mozzo dell’angoscia. Quest’ultima è proprio la chiave di volta che aveva permesso a Heidegger nel secolo scorso di fondare la propria analitica esistenziale, poiché «l’angoscia non ha occhi per “vedere” un determinato “qui” o “là” da cui si avvicina ciò che è minaccioso. Ciò che caratterizza il davanti-a-che dell’angoscia è il fatto che il minaccioso non è in nessun luogo».4
Essa si distingue dalle altre forme della paura per il fatto di non avere un oggetto proprio, non è cioè una paura determinata, di qualcosa di specifico, ma di essere una condizione dell’esistenza, la paura del nulla, della mancanza di senso delle nostre vite. È una situazione emotiva nella quale abitiamo, costantemente, cercando, con la stessa pervicacia, di dimenticarcene. Non possiamo fare a meno dell’angoscia, non possiamo liberarcene obliandoci nei piaceri o con qualche esotica forma di meditazione. Magari l’allontaniamo per un po’, ma di punto in bianco, mentre stiamo attraversando la strada o aspettando il verde al semaforo, ecco che ci attanaglia profondamente, e siamo di nuovo davanti all’abisso.
Probabilmente è stato Kafka a offrire nel racconto La tana una delle descrizioni più potenti di come funziona davvero la paura in senso esistenziale. Il narratore–animale indefinito, uomo-talpa che abita il sottosuolo, racconta la geografia e l’architettura dello spazio nel quale ha deciso di passare la sua vita: ha costruito una complessa tana sotterranea per proteggersi dai pericoli esterni. Per evitare che entrino degli estranei, visti invariabilmente come ostili, ha costruito una apertura falsa, che non conduce da nessuna parte, e una reale, così ben nascosta da rendere difficile anche uscire dalla tana. Esso infatti esce raramente, e con grande paura di rivelare in tal modo l’esatta ubicazione dell’ingresso. La tana rappresenta sia un rifugio sicuro che una fonte di continua ansia per il protagonista, ossessionato dall’idea che l’entrata sia vulnerabile agli attacchi di predatori. Nonostante i suoi sforzi per perfezionare il sistema difensivo, non riesce mai a sentirsi completamente al sicuro, poiché il senso di minaccia è costante. C’è qualche altro animale? Sta tentando di entrare? O sta scavando a sua volta una tana? Supponiamo che il pericolo di cui dobbiamo avere paura venga dall’esterno, gli attribuiamo intenzioni e desideri, ma è dentro di noi che invece abita la paura, e più cerchiamo di evitarla ripiegandoci in noi stessi e seppellendoci vivi nella nostra tana, più in verità ci avviciniamo a lei, le offriamo il dominio sulle nostre vite… Seguendo l’animale di Kafka dobbiamo forse prestare attenzione a un altro elemento che rientra nel più ampio tema della paura. Questo elemento è proprio il racconto, il fatto che la paura ha (anche) una dimensione narrativa. Non ci stupisce più di tanto: dopo che ci siamo resi conto di quanto fondamentale sia l’elemento del tempo per nutrire la paura di noi uomini, non resta che dircelo, mettere in comune la paura di ciascuno e riconoscerla come paura di tutti. Se è vero che il linguaggio ha fatto la sua comparsa tra gli Homo Sapiens circa 80.000 anni fa come specifica tecnologia comunicativa atta a condividere informazioni utili alla sopravvivenza del gruppo, è altrettanto probabile che, alla sera, accanto al fuoco, i primi gruppi umani lo abbiano usato per raccontarsi le esperienze della giornata appena trascorsa e per pianificare le azioni comuni da svolgere il mattino seguente.
Non possiamo pensare che il contenuto di primi racconti fosse teso solo a mettere al corrente gli altri delle proprie esperienze: di certo le emozioni – e tra queste la paura – provate durante la caccia, la pesca, la raccolta, l’accudimento dei figli, hanno avuto un ruolo determinante nel far sviluppare al linguaggio le sue enormi potenzialità espressive e narrative. Raccontando la paura si insegnava agli altri a essere prudenti, li si metteva in guardia dai pericoli e dai rischi, preparando se stessi e gli altri ad affrontare le prove che avrebbe portato con sé il domani. E forse qualcosa in più: si mostrava come non temere la paura, esorcizzando le sue tossine paralizzanti si provava collettivamente ad appropriarsene, a trasformarla in coraggio, che né è un aspetto, e non di certo il contrario. Esso infatti, come aveva notato già Aristotele,5 è la virtù mediana tra la viltà e l’incoscienza, ovvero l’atteggiamento di chi non permette alla paura di diventare il suo padrone, ma nemmeno la ignora come se non avesse alcuna funzione. C’è dunque un aspetto pedagogico del narrare la paura, una palestra che prepara alla vita, un fare delle esperienze vicarie attraverso il racconto che siano propedeutiche a quelle reali. Posso imparare ad avere paura, usarla a mio vantaggio, espormi finzionalmente ad essa senza doverne condividere i rischi. Lo vediamo anche nei giochi dei bambini, che c’è un apprendimento della paura, quando tutti eccitati giocano a rincorrersi con gli altri bambini o con gli adulti, che a volte impersonano scherzosamente mostri pronti a mangiarli. Spesso i bambini sono così compresi dal gioco da aver paura sul serio, e allora piangono e tutti si fermano interdetti. La loro paura è reale oppure no? In effetti non ci sono pericoli nei dintorni, nessuna autentica minaccia se non quelle figurate dall’immaginazione dei bambini. Tuttavia, probabilmente le cose non sono così semplici.
Non basta sapere che non c’è pericolo. Charles Darwin, analizzando le espressioni che gli umani e gli animali assumono quando sono spaventati, raccontava questo breve aneddoto personale che mostra la radice più profonda della paura: «posso citare un fatto insignificante che viene in appoggio del mio asserto e che mi ha altra volta molto ricreato. Appoggiai la faccia contro il grosso cristallo della gabbia d’una vipera al Giardino zoologico, colla ferma intenzione di non rinculare ove il serpente si slanciasse verso di me; ma esso aveva appena battuto il cristallo, che la mia risoluzione sparì, ed io saltai addietro un metro o due con un’incredibile rapidità. La mia volontà e la mia ragione erano riuscite impotenti contro l’immaginazione che mi rappresentava un pericolo, cui per lo innanzi non ero giammai stato esposto».6 La reazione di fuga di Darwin sopravanza ogni sua possibilità razionale di resistergli, sebbene egli si fosse impegnato a fondo in tal senso e fosse assolutamente impossibile che il serpente rompesse il vetro della teca. Inoltre, egli non era mai stato esposto a un pericolo simile, quindi a rigore non era in uno stato di allarme rispetto a quello che avrebbe potuto succedere, basandosi sulle sue esperienze pregresse. Di fatto, il pericolo era finto, ma la paura reale. Anzi, il pericolo era finzionale, ovvero richiedeva – a un livello inconsapevole –, di attuare quella suspension of disbelief che, ci ricorda Samuel Taylor Coleridge, è il segreto del successo di ogni opera di finzione.7 La paura di Darwin era dunque vera, vera a un livello più profondo di quanto lo stesso naturalista inglese potesse mettere in conto, eppure era immaginaria, ovvero non dipendeva da alcun pericolo reale, che fosse presente, passato o futuro. Cruciale è qui comprendere bene la differenza tra finto e fittizio: nel caso di Darwin si tratta di una paura fittizia (poiché non esiste motivo di pericolo), ma non finta, ossia recitata. Per capire la differenza tra queste due forme di paura, si può pensare a quella che gli attori fingono di provare durante una performance cinematografica. È necessaria una notevole capacità di astrazione e autocontrollo per mostrare i segni della paura quando si è completamente calmi di fronte a una troupe al lavoro. La paura fittizia, invece, è una paura che proviamo realmente, ma non in modo autentico: sappiamo che non c’è pericolo, ma ci esponiamo al brivido e al piacere conseguente che essa ci offre. Il fatto di essere minacciati finzionalmente da un pericolo (anche se non reale) provoca in noi una reazione che, per un osservatore esterno, è indistinguibile dalla paura reale, ma che differisce per noi che la sperimentiamo. È la “quasi paura”, una paura di cui siamo consapevoli grazie alla nostra introspezione, verso qualcosa che “non fa davvero paura”.
Se credessi fermamente di essere in pericolo, ogni atto immaginativo sarebbe bloccato e sarei davvero spaventato. È chiaro tuttavia che ci deve essere una relazione con la paura reale, quella che si prova davanti al pericolo: se la vipera avesse potuto uscire dalla sua teca, la paura di Darwin sarebbe stata più che giustificata. Del resto, tutti i mondi finzionali, dalla letteratura al cinema, funzionano perché e nella misura in cui sono modellati a partire dalle coordinate che reggono quello reale, offrendoci delle variazioni di un modello che è garantito dal senso comune.
Tuttavia, c’è un elemento che riguarda la paura nei mondi finzionali che – in buona misura – la distingue da quella che si prova di fronte a un pericolo reale: questo quid è la sua relazione con il piacere. In effetti, se la paura è un’emozione che ha a che fare con la repulsione e il disgusto, se ci invita a stare all’erta per evitare qualcosa di spiacevole, se la prima reazione è quella di fuggire, perché siamo attratti dalle opere di finzione che la usano come motore narrativo? Lo psicanalista ungherese Michael Balint, studiando i parchi divertimenti e i luna park all’inizio del XX secolo, si chiedeva cosa spingesse le persone a esporsi ai brividi delle montagne russe, a farsi spaventare nella casa degli orrori, a esporsi insomma a “situazioni-brivido”8 nelle quali l’incolumità dei partecipanti era messa finzionalmente a rischio.
In tutte queste situazioni, nota Balint, sono sempre contemporaneamente presenti tre elementi, ovvero la paura legata al fatto che c’è comunque un margine di rischio (qualcosa può andare storto), la decisione di esporsi volontariamente al pericolo e la speranza che potremo controllare la paura e superare il pericolo. In esse si entra con due atteggiamenti differenti, a seconda che cerchiamo il piacere nelle cose sicure o in quelle incerte. Il primo è l’atteggiamento degli ocnofili, quelli che vogliono stare al sicuro, hanno paura di perdere quello che hanno, e che se si espongono al rischio soffrono, e provano piacere solo quando ritornano al sicuro nella loro tana; il secondo è quello dei filobati – amanti delle altezze – che provano piacere nella mancanza di appigli sicuri, e per i quali gli oggetti e i legami sono solo degli ostacoli. Appartengono a questa seconda categoria coloro che praticano sport estremi, ad esempio, e che vivono il brivido con la ragionevole sicurezza (o presunzione) di ritornare a casa propria sani e salvi. Probabilmente è il nostro tentativo di controllare la paura senza farci paralizzare da lei che ci spinge a inoculare dosi di spavento controllato, una specie di vaccino contro la paura vera. Non ne diventeremo immuni, ma almeno sapremo riconoscerla e gestirla quando la proveremo. Ed è in questo che le opere di finzione risultano fondamentali: nel sapere costruire la giusta alchimia di dolore e piacere nell’offrirci la loro esperienza narrativa.
A chi gli chiedeva perché i suoi film avessero tanto successo nonostante facessero leva sulla paura, Alfred Hitchcock rispondeva che gli spettatori vanno al cinema per provare i brividi dei quali la loro vita quotidiana è priva, «per non diventare inattivi e simili a molluschi».9 Ma non tutte le forme di paura servono allo scopo: bisogna che il pubblico sappia di non essere esposto a un vero pericolo, perché se si sentisse davvero minacciato, se avvertisse come minata la propria sensazione di sicurezza, perderebbe il piacere insito nel brivido. Il piacere fornito del cinema legato alla paura consiste proprio nel permettere questa esperienza vicaria e funzionale del rischio, rischio al quale mai ci si esporrebbe nella realtà. Proprio per questo Hitchcock – pur sfiorandolo in alcuni film come Psycho e The Birds – ha sempre evitato di ricadere nel genere horror, poiché lo spaventoso, il sadico, il macabro finiscono per fornire un’emozione eccessivamente forte e in qualche modo “malata” che inquieta e perturba lo spettatore, impedendo proprio quell’effetto vivificante che si propone. Questa ricetta funziona (o perlomeno ha funzionato) all’interno dei thriller, in particolare quelli che si presentano come una detective story, genere che pur inaugurato dalla letteratura – con la figura dell’investigatore Dupin partorita dal genio di Allan Poe – ha trovato nel cinema, e nella rigidità implicata dalla sua fruizione per uno spettatore, la sua declinazione di maggior successo. E per un motivo ben preciso: è il genere che meglio si presta ad attuare il meccanismo della suspense. Nella suspense il ruolo della paura è ascritto perfettamente al regime dell’immaginario: temiamo (o temiamo che non) si realizzi un determinato esito di una situazione narrativa, sulla base delle nostre proiezioni verso il futuro. Ma questo timore è complicato da una serie di considerazioni di tipo morale con le quali dobbiamo fare i conti: e se effettivamente noi – almeno a livello immaginario – desiderassimo che l’esito moralmente meno auspicabile (la morte del protagonista, la vittoria del cattivo) si realizzasse? Nella sospensione, che è sempre una sospensione del giudizio, comportata dalla suspense si mantiene viva questa dimensione ancipite, che è un misto di speranza e timore, paura e desiderio, ambiguità di fondo della nostra natura di esseri umani.
C’è un sottile piacere in questa labilità, un piacere che spiega la fascinazione di questo tipo di narrazione. È qualcosa di differente da quel “dilettoso orrore” col quale Edmund Burke descriveva lo sgomento e il piacere che coglievano lo spettatore di fronte al sublime, alle terribili e potenti catastrofi naturali. Piuttosto quest’ultimo sta alla base del motivo del successo degli horror, la cui cifra di fondo è la presenza di un mostro, un’entità che porta in sé lo stigma della diversità assoluta (demonio, creatura sovrannaturale, zombie, esperimento scientifico, ecc.), genere che a sua volta conosce una prima codificazione nella letteratura, perlomeno a partire dalla metà del XIX secolo, legato alle poetiche e alle sensibilità tardoromantiche. Il confronto con il mostruoso non possiede tutte le sfumature esistenziali della paura legata alla suspense, si tratta infatti di una paura irrazionale, che ha a che fare, come nel sentimento del sublime kantiano, con ciò che eccede il limite, che riduce a zero la nostra capacità di resistere o di fargli fronte cognitivamente.
Non ci sono opzioni morali nel terrore, si tratta di fuggire o di soccombere, di uccidere o rimanere uccisi. Il piacere che ne ricaviamo è dunque di tipo negativo, consiste nella scarica emotiva della tensione, nel ritorno accompagnato dal sollievo a una situazione ordinaria. Nella suspense invece siamo in qualche modo “tirati dentro”, catturati, diventiamo parte integrante di quello che stiamo leggendo o guardando. C’è infatti sempre una specie di patto di disimpegno nelle opere di finzione, persino in quelle cinematografiche che rispetto alle altre determinano sicuramente un grado di partecipazione emotiva superiore da parte dello spettatore: quello che sto guardando non mi riguarda, posso benissimo immedesimarmi nella vicenda, riconoscere alcuni tratti di personalità in comune con i personaggi, ma in fin dei conti viene sempre salvaguardata una distanza di sicurezza tra me e lo schermo. Tale patto viene violato – o perlomeno sospeso – nella suspense. Per parafrasare il titolo di un celebre film di Hitchcock, è infatti sempre lo spettatore a trovarsi nella posizione dell’“uomo che sapeva troppo”, ad avere più informazioni su ciò che sta accadendo di quante ne possiedono i personaggi del film. Sappiamo che il protagonista sta per ficcarsi in una trappola, abbiamo paura che non riesca a cavarsela e non possiamo fare nulla per metterlo in guardia: allo stesso tempo ci sentiamo impotenti e responsabili, costretti in una situazione spiacevole che non abbiamo scelto e che possiamo solo sperare si risolva per il meglio. La suspense ci rimette in contatto con l’incertezza, con il fatto che anche nella situazione più controllata – l’opera di finzione – risuona un ammonimento a non avere una fiducia cieca nelle nostre abitudini e a non contare troppo sulle nostre aspettative, per quanto possano essere state suffragate dalle esperienze pregresse e dai dati di fatto. Essa ha a che fare con la perdita di sé, con la scoperta di una dimensione esistenziale che è più vicina al caos e all’angoscia che alla consapevolezza e alla conoscenza.
È un momento vertiginoso nel quale tutte le nostre difese razionali, tutti gli ingressi della nostra tana vengono scoperchiati per rivelare la loro fondamentale inconsistenza. Ma non precipitiamo nel terrore, rimettiamo in moto una risignificazione del nostro orizzonte di senso, ricostruiamo il nostro mondo e torniamo al sicuro in esso. Tuttavia, come lo strano animale di Kafka, continuiamo a sentire un rumore – un sibilo, un fruscio, forse non è nulla – e di nuovo, per quello strano effetto di repulsione ed attrazione che esercita in noi la paura, ci diremo: «Scaverò un grande cunicolo regolare in direzione del rumore e non smetterò di scavare finché, indipendentemente da ogni teoria, non avrò trovato la vera causa del rumore. Allora, se starà in me, la eliminerò, altrimenti avrò acquistato almeno la certezza. Questa mi darà o la tranquillità o la disperazione, ma sia l’una, sia l’altra, saranno al di là di ogni dubbio e giustificate».10
1 Thomas Hobbes, Leviatano, o la material, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile, a cura di A. Pacchi, con la collaborazione di A. Lupoli, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 87.
2 Aristotele, Retorica II 1382 a 20 e segg.
3 Agostino, Civitate Dei XIV, 9.
4 Martin Heidegger, Essere e tempo [1927]), traduzione di P. Chiodi condotta sull’undicesima edizione, Longanesi, Milano 1976, p. 188.
5 Aristotele, Etica Nicomachea, I, 13, 1103 a; VI, 3, 1139 b.
6 Charles Darwin, L’espressione delle emozioni negli animali e nell’uomo [1872], traduzione di B. Bandinelli, Bollati Boringhieri, Torino 2021, p. 28.
7 Si veda il capitolo XIV di Samuel T. Coleridge, Biographia literaria [1817], traduzione di P. Colaiacomo, Editori Riuniti, Roma 1993.
8 Michael Balint, Situazioni-brivido e regressioni, in Michael Balint e Enid Balint, La regressione (1968), traduzione di M. Lang, Raffaello Cortina, Milano 1983, pp. 31.
9 Alfred Hitchcock, Hitchcock secondo Hitchcock. Idee e confessioni del maestro del brivido, a cura di S. Gottlieb, traduzione di R. Caccia, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2003, p. 135.
10 Franz Kafka, La tana [1924], in Tutti i racconti, a cura di E. Pocar, Mondadori, Milano 2017, p. 54.