Continua la promozione dei 3 libri finalisti del Contest di fine 2024 di Laboratori Poesia (vedi QUI). Il Contest, ricordiamo, ha visto 30 libri in gara per 93 votanti effettivi tra i lettori dell’Osservatorio Poetico di Laboratori Poesia, per un totale di 171 voti effettivi. Tutti i risultati sono visualizzabili QUI.
Il primo Speciale ha visto una traduzione e una nota a cura di Rocío Bolaños e Alessandro Canzian su Seracchi e morene di Mauro Ferrari (Passigli, 2024, terzo posto, visualizzabile QUI). Su Corpo contro di Daniela Pericone (Passigli, 2024, secondo posto) la traduzione è stata curata sempre da Rocío Bolaños e la nota di lettura da Serena Mansueto (visualizzabile QUI). Su Sull’altra riva di Stefano Colletti (Puntoacapo, 2024, vincitore) la traduzione di Rocío Bolaños e la nota di lettura a cura di Federico Migliorati (visualizzabile QUI).
Il secondo Speciale invece è stato un invito a partecipare alla puntata su Fango Radio di Vocale, ormai punto di riferimento della promozione radiofonica della poesia a cura di Elisa Longo. Per l’occasione Daniela Pericone e Mauro Ferrari hanno letto alcuni loro testi mentre dal libro di Stefano Colletti ha letto Vernalda Di Tanna (il podcast è fruibile QUI).
Il terzo Speciale, pubblicato oggi 2 maggio, consiste in interviste agli autori a cura di Elisa Nanini (a Daniela Pericone, QUI), Vernalda Di Tanna (a Mauro Ferrari) e un ricordo a cura di Marco Molinari (su Stefano Colletti, QUI). Il quarto Speciale invece consisterà in un percorso, a cura della redazione, dentro le tre opere attraverso alcune parole chiave presenti nei libri.
I prossimi appuntamenti saranno un percorso, a cura della redazione, dentro le tre opere attraverso alcune parole chiave presenti nei libri, e un invito a leggere i propri testi al Festival della Letteratura Verde (QUI) che si terrà il 15 giugno a Porcia in provincia di Pordenone, sulle sponde del lago Burida.
INTERVISTA A MAURO FERRARI
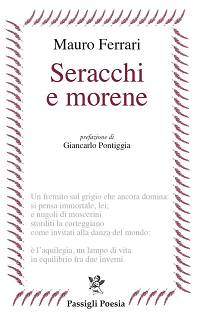
Vernalda Di Tanna: Sull’osservatorio poetico Laboratori Poesia sono recentemente apparse delle traduzioni da Seracchi e morene (Passigli, 2024), a cura di Rocío Bolaños, con annessa nota di lettura a cura di Alessandro Canzian, il quale, scrivendo del libro cita questi versi di Montale: «Eppure resta / che qualcosa è accaduto, forse un niente / che è tutto». Partiamo da qui, da questi accadimenti.
Mauro Ferrari: I due testi tradotti da Rocío Bolaños e commentati da Alessandro Canzian in un certo senso si parlano. “Ed io, che posso dire qui alla sbarra… / Certo, ero lì, e dall’alto / mi godevo la discesa”. Vorrei precisare che qui, davanti al tribunale della Storia, sta parlando la bomba di Hiroshima. Innocente strumento, se vogliamo, della brama di odio umano (anche se il dibattito su Hiroshima è molto complesso e non banalizzabile). La bomba si godeva la caduta (un po’ rilkianamente…), e comunque non ammette colpe “davanti a questa assise e al cielo”. E chi le ammette, nella Storia? Per collegare questo testo al secondo (Infine), dobbiamo ammettere che siamo un nulla, che arriva dal nulla e lì approderà. Non c’è alcuna consolazione nella mia poesia (meno che mai in Seracchi e morene), ma è chiaro che, operativamente, dobbiamo trarre la massima gioia dalla vita, dal “nulla che noi siamo”. La particolarissima struttura della seconda poesia, quasi un gioco di poesia metafisica all’apparenza, in realtà mette in tensione irrisolvibile il nulla con il “tutto che noi siamo”: è quasi una poesia d’amore, nella forma, ma nella sostanza una dichiarazione universale.
V.D.T.: Vorrei lei provasse a recuperare una parola-chiave dal suo Seracchi e morene.
M.F.: Probabilmente la parola centrale del libro è Storia. Non so se La Storia siamo noi…: io preferisco dire che Noi siamo la Storia, il che non è del tutto uguale Temo che la poesia stia dando troppo peso alle storie individuali, peggio se filtrate e depurate di tutto ciò che non è immediato e limitato diarismo. Anche in questo ambito si incontrano lavori pregevolissimi, sia chiaro, come è chiaro che questi lavori si collocano all’interno di una linea precisa e della poesia italiana e occidentale. Ritengo però che oggi, se la poesia vuole giocarsi le sue (ultime) chance, deve puntare in alto, al dialogo con arte, scienza, filosofia. E con la Storia, appunto. Il che non vuol dire fare filosofia in versi, ma rendersi conto che il poeta, lo scienziato e il filosofo fanno lo stesso lavoro, seppure con strumenti diversi: cercano di rispondere alle domande che tutti dovrebbero avere sempre ben presenti.
V.D.T.: È interessantissimo il personaggio che ci propone in Ulteriori notizie di Ulisse. Può commentare la sua poesia?
M.F.: Ulisse mi ha sempre affascinato, e sappiamo bene che la storia di Ulisse è parte della storia della letteratura di ogni tempo e Paese, perché sono infinite le riprese e le riscritture delle sue vicende, o di vicende che riprendono e ampliano creativamente il suo personaggio. Tutto è stato detto di lui, e davvero oggi è Everyman, tanto che anche considerarlo l’epitome dell’Uomo occidentale è riduttivo. Ulisse – meglio, la persona che è diventato tramite questo processo – è l’Uomo assoluto, colui che ha “a name and a place” nella definizione di Shakespeare, il quale ha inventato Amleto, l’unico personaggio in grado di rivaleggiare con Ulisse quanto a universalità: anche lui ha perso tutto, diventando anche lui Nessuno.
Ulisse ha un luogo dell’anima, Itaca, ma ha anche attraversato infiniti luoghi; è un re, ma è anche un mendicante; è astuto, ma si perde e perde tutti i compagni; è un personaggio “autentico”, ma deve fingere di essere altri… e via dicendo. È insomma un coacervo di maschere e di possibilità, un Indecidibile che proprio per questo mi affascina: qualunque ruolo può essere adattato a lui, perché si adatta a tutti i ruoli. E allora ho scelto, in vari testi disseminati nei miei libri e che forse dovrei raccogliere, di stravolgerlo ulteriormente, certo che sarebbe comunque rimasto Ulisse, solo ulteriormente potenziato, rafforzato nella sua universalità. L’ho fatto diventare ad esempio un rimbambito che fallisce la prova delle scuri e se ne fa bofonchiando; in una sorta di pensionato che tiene in ordine il giardino… e altro ancora. In Ulteriori notizie di Ulisse lo trasformo (anche, ma non solo) in un migrante che ha “attraversato il mare / per un terra in cui qualcuno / potesse dargli u nome e un luogo”, ma che alla fine ha perso tutto ed è diventato appunto “Nessuno, come tutti”: ma mi piace tenere un’ambiguità, perché la poesia comincia con due avventori al bar che lo ricordano come un fanfarone che millantava di storie improbabili, mentre adesso la “notizia” è che ha davvero attraversato il mare, anche se è giunto come un disgraziato. Insomma, sempre più indecidibile…
V.D.T.: Mi ha colpito il settimo componimento della IV sezione del libro, La Spira. Qui i versi fanno da specchio e ciò che urta, forse, è saperci «tutti innocenti come squali» (p. 94), nel momento in cui l’uomo si riconosce «nelle storie e nella Storia» (p. 82). Può raccontarci qualcosa della genesi di questo testo?
M.F.: La spira è un poemetto a cui ho lavorato per trenta anni, per giungere a questa versione che ritengo finale. Ho voluto creare, per quanto possibile, un’immagine (più che una storia) di ciò che siamo oggi, di ciò che siamo diventati. I frammenti di vita personale, di ricordi legati agli ultimi decenni nella mia città (Novi Ligure) e nell’Italia vanno visto sullo sfondo di eventi più ampi (appunto, la Storia) e di una mia personale “individuazione” in una precisa geografia, storia e cultura “locale”. Mi scuso per le virgolette, che in genere non amo, però non voglio né affondare in certo psicologismo né, tantomeno, peccare di localismo: il racconto della (triste) sorte dell’Italsider/Ilva, che ha sede a Novi, della sparizione del villaggio di cercatori d’oro ai Laghi della Lavagnina, gli accenni agli eventi partigiani (quella è la zona dell’eccidio della Benedicta) e altro servono per inquadrare meglio i temi generali; ne sono le variazioni musicali, in una struttura che da un lato vorrei indebitata a certo Romanticismo (il Preludio di Wordsworth) e dall’altro ai poemetti modernisti anglosassoni (il poundiano Mauberley, la Waste Land e i Quattro Quartetti di Eliot, Briggflatts di Bunting che non casualmente ho appena pubblicato in traduzione per la mia puntoacapo).
L’intento insomma era di scrivere qualcosa di abbastanza raro nella poesia italiana (e non solo), anche come tenuta: sebbene non sia lunghissimi, si tratta pur sempre di una dozzina di facciate.
V.D.T.: Un consiglio da offrire a coloro i quali oggi si avvicinano alla poesia.
M.F.: Oggi, come sempre, sono tantissimi che provano a scrivere in versi, almeno andando a capo e frammentando un discorso spesso sentimentale e privato piuttosto che scrivere in prosa. C’è bisogno di interiorità, e la scrittura serve a questo scopo, quindi la cosa è in sé nobilissima. Non bisogna però confondere questa esigenza (che produce il 99% delle decine di migliaia di titoli annui) con l’esigenza – meglio, il tentativo – di fare letteratura, cioè entrare in dialogo con ciò che la Storia delle letteratura (finché è esistita, direi, cioè fino ad alcuni decenni fa) ha definito come poesia. Oggi tutto questo è molto più confuso, e non è il caso di entrare in diatribe o peggio polemiche. Diciamo però che le voci da seguire sono molte, e ogni anno vengono comunque pubblicate decine di buoni libri, e fra loro qualche capolavoro (parola disusata ma concretissima). Allora, chi vuole fare poesia deve seguire il panorama poetico, leggere e conoscere. Insomma, imparare il lavoro (altra parola un po’ forte).