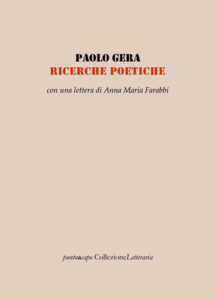
Ricerche poetiche, Paolo Gera (Puntoacapo, 2021, con una lettera di Anna Maria Farabbi).
Non è facile scrivere recensioni per libri come Ricerche poetiche di Paolo Gera, e forse neppure è giusto. E non lo è nella misura in cui recensire potrebbe costituire un tentativo di ghermire, di inquadrare, di ridurre, definendo, la stessa inafferrabilità e asistematicità dell’opera che ne serbano il valore e che rappresentano il suo stesso corredo genetico. Questa raccolta si suddivide in quattro sezioni: “Prime parole”, “Rifiuti di scrivere”, “Ricerche poetiche” e “Concetti verbali”.
“Prime parole” incarna il principio del libro e della sua ricerca. In essa è la genesi linguistica, la materia prima balbuziente e magmatica della parola, delle prime vocalizzazioni, della lallazione o – per dirla con Lacan – della lalangue che precede il linguaggio, e che si traduce nell’esperienza di una lingua fatta corpo e, al contempo, nel corpo della lingua, ovvero nella vita.
Segue poi “Rifiuti di scrivere” nella quale Gera offre l’alternarsi di indor e compost come «risultato dello smaltimento di materiali verbali» (p. 12) di varia provenienza. Qui l’autore sembra inaugurare quello zapping letterario e verbale che in più occasioni si ripresenterà nella raccolta, e nel quale convergono indiscriminatamente citazioni colte e popolari, stralci di bugiardini e colpi di poesia, arcaismi, neologismi, riflessioni e decreti legge. È questa un’operazione che ricorda quella del cadavre exquis, ma che qui richiede tuttavia un collettivo differente, interspecifico, composto da democratiche intemperie, e foglie, fango, muffe e onischi, ai quali, rispetto alla versione originale surrealista, viene assegnato significativamente il compito di rimuovere, anziché aggiungere e proseguire.
Ma il cadavere squisito è – e nasce essenzialmente – come gioco letterario, e come ogni gioco ha anzitutto una funzione di apprendimento, di sperimentazione e simulazione, di pratica, di conoscenza del circostante e di proiezione verso orizzonti inesplorati. Anzi, in quest’ottica quasi pedagogica di Big-bang linguistico e di gioco-scavo, forse la stessa scelta di iniziare la raccolta con queste prime due avanguardistiche sezioni, non fa che tramutare – come in un vero e proprio ecosistema – l’apparente pars destruens in pars construens, avviando metaforicamente proprio attraverso l’inciampo verbale della prima sezione, e il disfacimento e il compostaggio letterario della seconda, il fertilizzante necessario all’intero germogliare e dispiegarsi delle successive sezioni. Ed è infatti poi in queste ultime che l’autore solca sempre più a fondo e sempre più concentricamente il discorso poetico e meta-poetico, critico e meta-critico, fino ad approdare in maniera significativa al silenzio e alla voragine della pagina bianca. Difatti, pur ammorbidendo la celebre sentenza di Adorno, e tenendo sempre a mente l’ultimo enunciato del Tractatus logico-philosophicus, l’autore non può che guardarsi intorno e riconoscere la responsabilità intellettuale che «per certi versi è solo una questione di tempi,/ e questo non è il tempo per certi versi» (p. 60).
Quella che viene offerta in queste pagine è una prosa che senza strappi tramonta in poesia, in poème en prose e viceversa, ma è soprattutto una lettura diversa, coraggiosa, incendiaria e anarchica; è un lavoro maleducato e colto, denso di rimandi e citazioni, di interrogativi, di insofferenza, di sdegno e di intolleranza al ristagno; e tuttavia è anche un grido di libertà e di vita, un inno alla disobbedienza civile e intellettuale, alla ricerca di nuove angolazioni e dialoghi possibili, al valore della scelta, e sopra ogni cosa è una irrefrenabile pulsione generativa volta al cambiamento, all’esplorazione, al nomadismo nel linguaggio, giacché, per citare Wittgenstein «immaginare un linguaggio significa [innanzitutto] immaginare una forma di vita».
Ricerche poetiche di Paolo Gera è un libro estremo e impegnativo che di certo non metterà tutti d’accordo, e tantomeno metterà necessariamente d’accordo su tutto anche chi è d’accordo. Ma ciò non può e non deve togliere quanto sia stimolante e importante sapere questo tipo di lavoro e di intenzione qui, adesso, in poesia, in Italia.
E alla fin fine «si legga poi come si vuole» (p. 12). Non resta allora che rimandare le sue parole a ogni singolo lettore, con lo stesso auspicio che Wittgenstein – in chiusura all’auto-prefazione – rivolgeva alle sue Ricerche filosofiche: «Le rendo pubbliche con sentimenti dubbiosi. Che a questo lavoro, nella sua pochezza, e nell’oscurità del tempo presente, sia dato di gettare luce in questo o in quel cervello, non è impossibile, ma che ciò avvenga non è certamente probabile. Non vorrei, con questo mio scritto, risparmiare ad altri la fatica di pensare. Ma, se fosse possibile, stimolare qualcuno a pensare da sé».
Dario Talarico
7.
Per certi versi ti sento più forte di me,
più preciso anche, e più efficace.
Per certi versi, certi endecasillabi ad esempio:
quando io scrivo “se ci ripenso tremo tutto e sudo”,
tu hai già scritto “che nel pensier rinova la paura”;
se ci riprovo con “son stato male, male da morire”,
tu mi umili con “tant’amara che poco più è morte”.
A me sembra di usare una lingua comune, ma tu mi superi
trovando proprio le parole giuste, quelle.
Forse è una questione di addestramento
e se tu volessi potresti insegnarmi bene.
Com’è questo gioco che a te riesce e a me no?
Eppure se riuscissi per certi versi a essere così centrato,
se riuscissi a scriverne solo uno forte come i tuoi,
ecco, ieri a tarda notte, dopo mille tentativi, cancellazioni,
fogli accartocciati gettati via con un senso di frustrazione e inutilità,
questo ho scritto: “Amor condusse noi ad una morte.”
Per certi versi mi reputo soddisfatto della riuscita
ed ecco finalmente che me ne riesce uno.
Ero al settimo cielo, ovvio dopo tanta dedizione e fatica,
poi ho scoperto che tu mi avevi preceduto e l’avevi già scritto.
Eppure non ne sapevo nulla, lo giuro.
“Amore condusse noi ad una morte”, il mio;
“Amore condusse noi ad una morte”, il tuo.
Uguali. Tuttavia, per certi versi, il tuo è sempre più forte del mio.
Per certi versi, come nel caso di questo verso, non è giusto,
essere uguali senza nessuna imitazione, ma per certi versi,
anche se io li scrivessi tutti quanti su mia ispirazione,
tu ancora e sempre avresti il riconoscimento della vittoria,
per certi versi meritata, ma anodina, impenetrabile e numinosa.
Potrei citare me o citare te, per certi versi sarebbe la stessa cosa,
perché io oltre a questo, altri ne ho scritti del tutto simili ai tuoi,
identici, sovrapponibili, sì, potrei citare me e citare te, ma mai citarti
in giudizio, perché l’avresti sempre e comunque vinta.
Allora, come funziona il gioco, da chi è composta la giuria,
qual è il regolamento?
Diamo tempo al tempo, si potrebbe dire,
ma il tempo sarebbe sempre e comunque dalla tua parte.
La tua patina è luminosa, la mia luce è opaca.
Per certi versi è solo una questione di tempi,
e questo non è il tempo per certi versi.
19.
[…]
Io sono il ragazzo dentro la capanna trafitto dalla luce degli spiriti antenati che sono invece giochi di flash, trucchi fotografici. Mi è toccata la polvere dei millenni e il fosforo che ha scatenato le immagini. Gli sciamani sono decine, ma per loro non occorre avere troppa reverenza. Il cieco che vede le fiamme, quello che parla coi morti, quello che ama le nuvole, quello sul battello ubriaco, quello che ferma la morte col vino, il soldato che si stende nell’acqua del fiume… È osservando loro che ho imparato il gioco. Non sono al di fuori e sopra con la loro disciplina e il loro fervore. Mi sono cresciuti nella carne e nelle ossa, la loro ombra si è allungata con la mia. Se tendevo la mano a raccogliere un frutto sul ramo più alto, centinaia di braccia si alzavano insieme. Io poggiavo la mia fronte sulla loro e come se ci baciassimo scorrevano dalle bocche accostate le belle parole. Così ho imparato il linguaggio e le regole. Non prima, ma osservando loro che giocavano ho imparato il gioco. Io sono il ragazzo dentro la capanna e intorno sono a dozzine. Il figlio dei numeri che danno zero, il passero quetzal, il custode delle lacrime, la madre delle libellule, la levatrice delle vocali. Si sono impolverati e sono cresciuti mangiando polvere e fosforo, scrollandosi di dosso i granelli e le immagini. In una maniera diversa dalla mia, ognuno sulla sua pista, raccolgono e cacciano, sono prede e sono colti. La nostra forza è nella nostra relazione, nell’annullamento dell’eroismo. La gloria è andata, finalmente! Non un santo, ma tanti minori. Qual è la proprietà delle parole? La linea ancora ci divide. Siamo seduti in una fila interminabile, accostati gli uni agli altri e non possiamo guardarci negli occhi. Affetti dal crampo cervicale dell’autore! Nella capanna la linea diventa cerchio. Ognuno appoggia la fronte su quella dell’altro e dalle bocche accostate come in un bacio escono le parole necessarie. Dentro si espande il canto gravitazionale, il coro dei richiami, la danza presente. Da questa parte del mondo, nella sua evoluzione, nella città di colonne e fibre, questi sono i nostri tronchi intorno, la nebulizzazione, la scimmia ragno appesa sulla schiena. Questo il circolo a cui tutti si appartiene. Poesia, nome collettivo. Non sono il primo per fortuna e lo ripeto.
[…]
b)
nella poesia scritta sulla pagina
successiva a questa
c’è il rimpianto per la poesia
scritta su questa pagina
c’è il bussare alla porta chiusa della stanza
dove il silenzio indica la presenza
c’è l’alzare le braccia verso quella che alta e indifferente
parla con altri e ignora che esistiamo
c’è il volgersi in pianto verso lei
separata per sempre
c’è la nostalgia indicibile per la lettera a
che è assente dalla poesia che segue
composta da tutte le lettere ma non dalla a
il tempo in cui ci si stringeva
e ogni lettera vi entrava ed era a
e colmava ogni desiderio
nella pagina successiva a questa
c’è la poesia che non riesce a dormire sotto il foglio bianco
crede qui ci sia un buio e due in un corpo
un sonno
