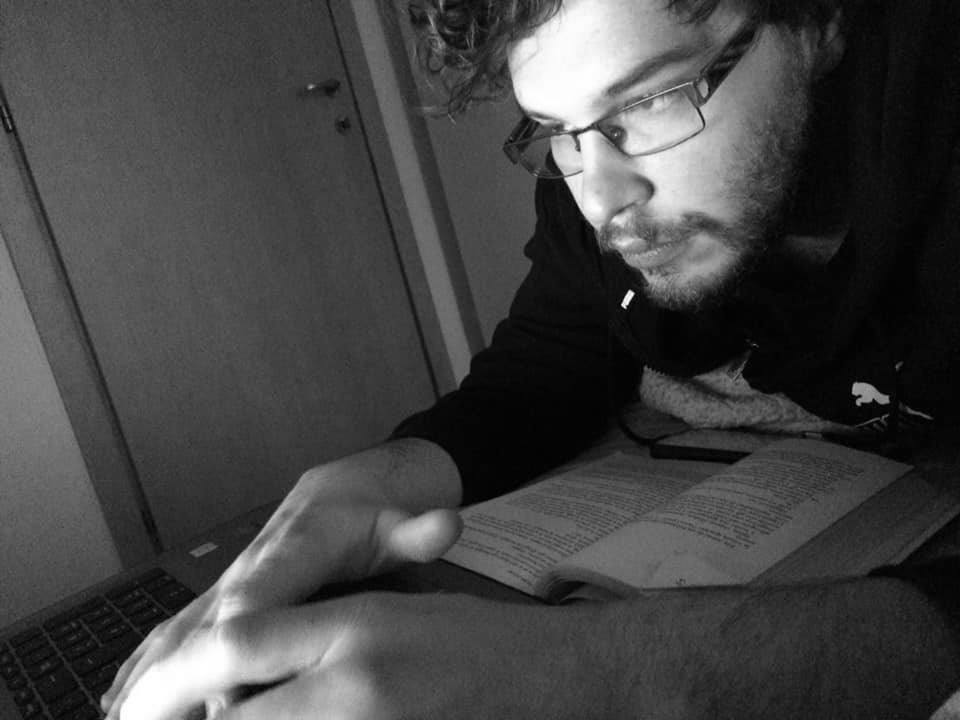
II
Sarà da bollir nella pentola il Cocito
– filtrar le congerie –, per gli oboli gettati
sul fondo in facsimile; dice il corifèo:
Che fai? Che fai?
L’implicito risulta eluso dall’incompleta
integrità miniata per ricamo in ibride drôlerie
nel vario privarsi di significato concepite
ai margini dei codici gotici, istoriati orbene;
così noi ci poniamo.
XXIX
Cui prodest scelus, is feci;
profanar il martirio ch’è passo pass-so
cadenza; questo strozzinaggio di retorica
bellica ne addensa un’esigente
prospettiva
di cosa sia o non sia l’esistenza.
Sia l’insurrezione: il calco che non c’è;
la sommossa, semi-mozza, pure, non persiste
che nell’oblio e ravvisarla comporta
il tropismo proprio del girasole.
XL
La scorreria cartilaginea non revoca
lo già scabro incuneo, bensì lo edulcora,
ingravida il sintomo.
Si nega la fucina
di un ologramma sotto mentite spoglie:
la congiura della controparte
residua stipata: pare provenire da fasiche
fenditure di dimensione, cimentano sinaptiche
relazioni o osmosi di resezione.
Mark Bedin, Reportage clinici (Nulla Die, 2021)
Non di facile approdo, almeno quanto interessante per le modalità espositive di cui si avvale, appare questa raccolta di Bedin: testo in cui sia la produzione lessematica, che l’apparizione estetica della rappresentazione, tradiscono una ben più profonda tragedia della mera cernita di uno o l’altro vocabolo.
Per questo motivo si dimostra fondamentale in sede critica sia tentare l’esposizione delle ragioni per cui queste difficoltà si rinvengono, motivandone succintamente le ragioni e le presunzioni, sia soffermare l’attenzione sopra il lessema stesso nel suo essere tale – non più come mera riproduzione affidabile (perché meccanica) della realtà, ma come matrice musicale dello spossessamento sistematico nell’esistenza che si affaccia al ribrezzo incontenibile della stessa.
La poiesis del nostro, nel suo valore complessivo, appare protesa allo sforzo di suturare lo sfregio che ha spaccato le carni della creazione artistica; tentativo che l’autore esplica coniugando le necessità di un presente, rilevato ormai come caduco di ogni valore estetico da un lato, all’esteticità delle tradizioni passate, subendone al contempo il fascino e la seduzione.
Partendo da questo assunto, il poetare in Reportage clinici trova nell’elezione di una lingua aulica, volutamente forbita e musealizzante, uno stato creaturale che si rispecchia nella capacità del proprio creatore – derivante da una logica artefice-artefatto di natura oscena, occultamente sottesa a quel che si compie all’oscuro della vista dei più.
Tuttavia, sull’esperimento linguistico dell’elaborato grava una tensione alla fissità, che nel complesso scivola nel meticciare dei vari registri stilistici che una lingua subisce per necessità di cose; il che non può non esporsi alla sofferenza di un parto mortale di una creatura che soffre e (continua a soffrire) l’assenza di un referente infisso sia nella lettera, che in ciò che questa dispiega.
Infatti, portando la parola sino al limite dell’esasperazione emulativa – che segue, di pari passo, la visionarietà della poetica del vicentino, assieme alla sua disperazione attorno alla realtà mera, nella sua nudezza – la parola riesce a coinvolgere non più nella descrizione come consegnata, ma nella narrazione che continua a prodursi nel mentre viene prodotta.
Potremmo riflettere a lungo, in effetti, che la meraviglia (nel suo essere percezione tremenda) insita nella materia non possa produrre altro sfogo in Bedin se non nella poesia che avviluppa, e si sviluppa in sé stessa.
Il che, però, ha senso solo e soltanto se il ragionamento si adagi anche sul vulnus che l’autore espone, più o meno coscientemente, consistente e nell’afasia della parola “moderna”, e nella responsabilità di una indagine stilistico-filologica nell’opulenza lessicale, ai limiti del rococò, in equilibrio sul baratro sotteso tra celebrazione e rifiuto, fra stile e sostanza.
A ragion veduta potremmo anzi asserire che se la formazione del dettato trova un certo approdo, ed un porto sicuro, e nell’orpello e nell’ampollosità delle forme; d’altro canto, la stessa versificazione risulta (pur troppo) oggettivamente caducata dell’afflato ritmico che necessita.
A suffragio di questo, ineluttabile è indire la mancanza di un codice metrico di fondamento al testo, e di un sistema di accentuazione riconducibile ad uno schema quantomeno fisso; e questo avviene nella piena consapevolezza di non escludere che il paradigma costitutivo del verso sia piuttosto demandato alla musicalità ed alla canorità di questo, delegando ad una posa teatrale quella struttura di cui si rinviene la necessità.
Non di meno però la poesia di Bedin si consegna tellurica, ed in ultima istanza impulsiva nella stessa misura in cui questa sia indispensabile all’autore, e si appella ad una certa formalità espressiva in sintonia ad una ritualità esasperata che risponde alla mancanza del senso persuasivo dell’episteme di cui il testo si fa annotazione.
Nei riguardi di questo, non è possibile non dar spazio alle parole del prefatore quando scrive: «Non è casuale, crediamo, che il verbo rilevare adombri passaggi semanticamente pregni di significanza etica ed estetica: rilevare – nemmeno più cantare – è l’atto dovuto del poeta, oggi, direbbe Bedin, che sia uno “screzio del frastaglio” ciò che il taccuino annota con pudore maniacale, o che viceversa si livelli a un ammorbato accoglimento della contingenza.»
L’opera di Bedin, in un atto di diffidenza e passione estrema, enuclea un dettato che sembra sostituirsi all’oggetto dello stesso; e difatti, entrando nel merito, non ci è parimenti plausibile riflettere in un modo diverso da quanto scritto in introduzione al testo.
O meglio, armonizzandosi e ponendosi in calce a quanto scritto nel prodromo letterale all’opera, si potrebbe concludere dicendo che Bedin, nel suo scrivere, sembra anzi tutto non solo collocarsi nello squarcio tra quanto esistente e quanto cantato (e cantabile) di questo; ma sembra porgere un interrogativo attorno alla tendenza descrittiva del reale, sostituendo la narrazione al narrato, ed incoccando così la freccia della diffidenza epistemologica della realtà in quanto tale – per scagliarla direttamente nel seno di Maya, perforandone il corpo, assieme al suo velo.
Carlo Ragliani
