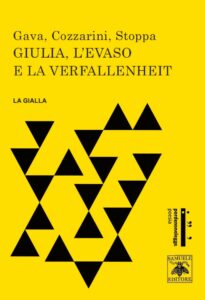
Se suona vero leggere da un insigne critico letterario come Giulio Ferroni che la poesia, intesa quale rapporto dialogico e assoluto col mondo e farsi di una concezione dialettica sulla e nella società, è terminata con Zanzotto e Giudici (il riferimento è al volume uscito qualche anno fa sugli ‘ultimi poeti’ a loro dedicato) è altrettanto da sottolineare come nelle nuove generazioni si mantenga spesso nei confronti dei versi una tensione non sempre superficiale né banale. Per alcuni giovani scrittori in versi essa rappresenta non un semplice origliare, bensì un penetrare nella materia viva, suggendone il nettare più puro, derivante dalla classicità o dalla contemporaneità per riuscire in seguito a dare una forma e una fisionomia al proprio dire. Accade ciò per questa pregevole raccolta che nasce indirettamente e idealmente sui banchi di un liceo friulano diverso tempo fa, e che ha trovato linfa feconda (“un piccolo miracolo”, lo definisce acutamente Roberto Cescon) per germogliare nel tempo. Tre le partizioni in cui si suddivide il volume corrispondenti ad altrettanti autori (Letizia Gava, Andrea Cozzarini, Alessandro Stoppa, nati tra lo spirare degli anni Novanta e i primi vagiti del nuovo millennio), tre differenti luoghi in cui la parola abita con felice esito mantenendo un tenore elevato anche senza frequentare un linguaggio eccessivamente forbito.
Nella prima la ricerca di una figura scomparsa finisce per diventare un cammino dentro di sé, in ciò ripercorrendo certi viaggi metaforici (anche con epigrammi penetranti) precipui del mondo caproniano, segnatamente quello dell’esperienza più matura vieppiù asciugata di espressività, con una certa influenza di Mario Benedetti che ha funto da incipit ideale di tutti e tre i poeti. Con un ricorso ampio all’allitterazione, sul filo di un’allegoria meditata, Letizia Gava parla al maschile e si muove su un terreno ispido, scivoloso, dove l’assenza è elemento dominante attorno a cui tutto ruota e tutto si tiene, in un vorticoso rincorrere l’evaso, il sé, il nulla. Un giallo in versi dal finale aperto, intenso, vibrante, sospeso, in grado di tramortire con un linguaggio scarno e denso al contempo.
Sono invece lampi, visioni improvvise atemporali quelli raccolti da Cozzarini, aperti dalla figura di una donna, Giulia, destinata a un processo esiziale e rovinoso. Sprazzi di natura, lacerti da un passato che redivivo si ripresenta con acutezza alla vista compongono il resto della produzione in cui il verso si distende facendosi più prosastico, dettagliato, lucido. Entra così in gioco il processo di recupero alla memoria di luoghi, accadimenti, figure, talvolta nitide talaltra più opache, che la storia personale ha posto sul cammino. Stupore e turbamento si mischiano, in un viaggio a ritroso nella tradizione di un tempo, nella scabrosità e nel disincanto delle immagini dell’adolescenza, con un susseguirsi costante e improvviso di figure, uno zapping poetico, ritmato, come un metronomo a scandire il passaggio da una stanza all’altra, da un mondo all’altro con un verso che si allunga lambendo i territori della prosa. Tratti di umanità, segmenti, schegge di pensiero si affastellano lasciando odori e umori nel magma di un’età perduta e nell’excipit la paura affoga in un’indistinta normalità. Palpiti di vita mozzata, singulti di una quotidianità che riemerge talvolta soffocata proprio nel ricordo connotano la terza e ultima partizione della raccolta che riporta alla luce, come abbacinanti visioni, i drammi della guerra in brevi componimenti e la morte quale ossessiva, inestricabile presenza. Anàfore, epìfore, allitterazioni, rime: ampio è il corso alle figure retoriche per rafforzare il senso del dire tra “paresi di ricordi” che si sedimentano gli uni sugli altri, ma si procede a tentoni, tra dubbi e un incespicare della memoria, verso un orizzonte incerto tanto che anche la propria presenza diventa una “insostenibile mole”, un ingombrante elemento da gestire.
Cenni danteschi e leopardiani sono introiettati nel flusso della poesia e la finitezza umana trova la sua più drammatica verità nel componimento conclusivo, “Verfallenheit”, termine caro a un certo Esistenzialismo di matrice heideggeriana. Per riepilogare, riteniamo che occorra dare credito a questo collettivo e gioviale affacciarsi alla scrittura, già dotato di una sua percepibile e apprezzabile fisionomia.
Federico Migliorati
da Alla ricerca dell’evaso (o quasi morto) di Letizia Gava
Il principio della ricerca non ricordo più,
solo che già troppe volte in un anno
l’avevo visto cambiare strada, passo o senso
a incrociarlo a piedi, o andar via, come entravo,
e senza salutare gli amici che erano iniseme,
sempre fingendo di essere solo e serio,
anche senza pagare una volta, che poi l’oste
mi hanno detto gliene fece il doppio di lire,
e ancora oggi racconta come quel giorno
ha perso il buonumore e poi sempre di lì,
ho sentito da altri, lasciava due lire in più.
Ma negli ultimi tempi non si vedeva più,
non solo io, che, ormai è certo, evitava,
ma anche gli altri, che lo aspettavano ormai
da molto per le carte o il vino, dicevano
che forse era morto e bisognava andare a vedere,
che, può darsi, il corpo marciva già da giorni
in uno scantinato o morto dove di quale morte.
Poi sempre un’altra voce era a dire che no,
non poteva mica essere, e poi nessuno lì
si sapeva dove abitava o lavorava per avere
sempre quelle due lire in più, e tanto sarebbe
tornato a dirsele con l’oste, giorno più o meno.
da Giulia e altre poesie di Andrea Cozzarini
Poi Giulia torna a casa
la macchina non le piace, è come se spiasse
può guardare ma non si sente
tranquilla, e tutto cambia di posto:
anch’io nei suoi occhi sembro
Jesse James o una petunia
Don’t go breaking my heart
canta Giulia e la radio
risponde: non potrei
se volessi. La notte
si apre come un’albicocca
come la sua gonna, quando balla e riempie di fiori
il pavimento che reclina, i bicchieri
madidi di gioia
le mie mani
che non coprono più
da Verfallenheit di Alessandro Stoppa
Il nostro futuro è dove rimani
Il passaggio quasi obbligato, davanti a quella che era stata
la breve dimora di Leopardi. Si apre, via Santo Stefano
nel livore notturno, nei passi appesantiti dal rimpianto,
io che faccio ritorno, e le parole ancora non dette.
Riguardo i mattoni e le volte, le serrande e i pochi
che tornano insieme, e di nuovo le molte stelle
di una notte senza fiato. Eravamo silenzio nella stanza,
volti immaginati a lungo, nelle sere
del sonno mancato, era un attento scegliere
gesto dopo gesto, alzarsi, ritentare, sedersi. Ogni notte
un suono inclinato, un ignorare di sguardi.
Stava a dire che è impensabile, ad ampliare il disamore.
Vado a letto più tardi, le notti che lavora
mia madre pesante sui ginocchi
esasperata vita che vuol esser vissuta
per le sigarette di rito, al mattino, un’ora o poco meno
prima che io mi alzi. Non ci incrociamo dunque,
ma è come se l’attesa del sonno protratta
fosse il saluto che non riusciamo a scambiarci.
Leggo, perlopiù cose in versi, le stesse identiche cose
di qualche anno fa. Questo perché non ricambio
lo scaffale che ha l’aria di esser completo
e allora la notte, aspettando, ripeto
quelli che sono i versi migliori, che bastano
a parlare al suo cuore. «Una breve finestra nel cielo tranquillo
calma il…»; un rumore tradisce il suo passo
poco fuori la stanza. È tornata e non sa se dormire.
