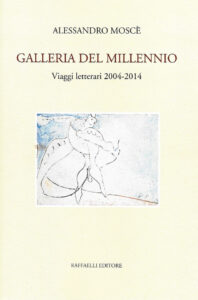
Galleria del millennio (Raffaelli Editore 2016) di Alessandro Moscè è una raccolta di articoli, recensioni, interviste che l’autore ha pubblicato (e non, nello specifico la terza parte colleziona inediti) su quotidiani e siti vari (tra gli altri: “Il Corriere Adriatico, “Il Tempo”, “L’Azione”, Atelier”, “Poesia”, “Prospettiva”). Una fotografia della contemporaneità che sfiora un censimento privato non dal punto di vista dei poeti ma dalla prospettiva del lettore-critico che ne cerca il trade union (o eventualmente la spaccatura).
Perchè un progetto del genere inevitabilmente traccia una mappa (e non da poco) così come traccia un’opinione, una poetica della critica. Non a caso Alessandro a introduzione del volume scrive: La letteratura che seguo e sulla quale indago da anni è la letteratura dell’esperienza, racchiusa in un caleidoscopio di soggetti, scenari, ambienti, di atmosfere, squarci e affreschi, in uno stile che metabolizza l’umano escludendo una prassi gergale, misurata a tavolino, di stampo sperimentale. Fa eco a queste parole Claudio Damiani che in un’intervista afferma: La poesia è qualcosa che non ha niente a che vedere con il concetto di ideologia, cioè di realtà sociale. La poesia dipende dalla realtà, certamente, cioè da ciò che esiste, che si manifesta nell’evidenza […] Nella poesia incontriamo l’essere vivo che stupisce per la sua vivacità.
E sicuramente anche Galleria del millennio stupisce per la sua vivacità e fertilità che riflette, tutto sommato, uno stato laboratoriale diffuso che stiamo vivendo in questi anni. Dove la necessità di eleggere il o un letterato ha lasciato spazio a una coralità di voci lavoranti che sanno consegnare sprazzi di verità letteraria a volte stupendamente intensa. Riferendosi a Valentino Zeichen (proprio in questi giorni al centro dell’attenzione per le sue condizioni di salute): L’amore è un gesto senza doveri, un’interlocuzione occasionale, una configurazione che mette in scena un teatro interiore, uno scioglimento di nodi nei dubbi e nelle perplessità. Il poeta capta ciò che sembra essere sempre un punto da colpire. Riferendosi a Ives Bennefoy: Il ritmo è dentro un luogo, in un’evento ritagliato nell’apparizione della solita veglia. Riferendosi a Davide Rondoni: Il reale non si può mai afferrare del tutto, è visibile e insondabile nelle sue punte più estreme. Se la vita appare nel buio, la visitazione comporta anche una sottrazione. Riferendosi a Giancarlo Pontiggia: Il paesaggio e il passaggio eterno della vita riservano sorprese, anche nello stesso angolo che cambia temporalmente, in una specie di nontempo che viene prima delle stagioni, della nascita e della morte. Il luogo del poeta è quindi un luogo di transito spersonalizzato. Il destino umano vaga in un qualsiasi punto del mondo, in una ragione forte di esistenza, nell’espressione di un mito contro l’espropriazione della lingua.
Considerazioni utili a comprendere la natura più fonda e profonda della parola che è sempre esperienza, sempre vita vissuta con brandelli di cose capite e tramandate. Oltre ad essere una buona (se non ottima) fotografia della composizione contemporanea. A questo proposito particolarmente interessanti sono le parole di Elisabetta Monti che, nel sito Pelagos, scrive: Il male di esistere è un comun denominatore di molti scrittori presenti in Galleria del millennio: Moscè lo individua nelle opere di Alberto Moravia, specie le ultime (imperniate sulla fantasessualità); nei fantasmi di Enzo Siciliano; nell’utopia di Paolo Volponi; nelle case che crollano di Gianni Celati. E ancora nella foga e nella disperazione di Dario Bellezza; nella preghiera di Vincenzo Cerami; nella morte senza un fine di David Grossman; nella nausea dei sensi di Paolo Dal Colle. I luoghi sono un altro aspetto singolare di questa indagine: reali e naturalistici in Luigi Bartolini, Tonino Guerra, Alberto Bevilacqua, Claudio Magris e Umberto Piersanti. Luoghi urbani in Edoardo Albinati, Marco Lodoli, Emanuele Trevi e Sandro Veronesi. Luoghi immaginifici in Roberto Pazzi, Ermanno Cavazzoni e Ugo Cornia. Luoghi di un quadro compositivo visionario nel poeta Remo Pagnanelli, appassionato di lari e figure semidivine. Moscè si occupa di Marc Augé, dello spazio infinito e del mondo globale che fissano il tempo morto nella relazione di nonluogo della società. Spiega: “L’antropologo, come lo scrittore, contribuisce allo sforzo di lucidità di cui oggi l’uomo ha bisogno più che mai, se davvero vuole dichiararsi totale e non più globale”.
Riporto infine un articolo inedito di Giorgio Germosi intitolato Alessandro Moscè e la letteratura possibile che ho trovato interessante e che forse meglio di me introduce alcuni estratti del libro: Alessandro Moscè, nato ad Ancona nel 1969, ha pubblicato una parte del suo lavoro critico in Galleria del millennio. Viaggi letterari 2004-2014 (Raffaelli 2016), dove emerge non solo l’inquadratura analitica dei libri dei migliori narratori, poeti e critici (per lo più italiani), ma anche la predilezione per un certo tipo di letteratura. Questa raccolta di recensioni appare come un’ambientazione nelle città e nei luoghi vissuti o frequentati dagli autori. La Roma di Luigi Bartolini (quella, poverissima, di Ladri di biciclette), definito “anarchico celeste”, o la stessa Cupramontana collinare, dove il prosatore e incisore marchigiano ha “messo in scena” le opere campestri realizzate con puntasecca e il torchio. La Roma convulsa di Paolo Volponi dopo la fuga da Urbino, capitale del Rinascimento; la Parma e la Casarola di Attilio Bertolucci nell’eco del ricordo dolcissimo di Paolo Lagazzi; l’Emilia di Pier Vittorio Tondelli con la “fauna artistica” degli anni Ottanta ecc. Moscè fa capire che la letteratura di oggi permette ancora di addentrarci nella crisi del mondo globalizzato e insieme di conoscere gli autori e il loro universo mediante la parola del reale e il senso del vero, nonché nel bisogno di fare forma e colore alle cose. Si fa strada un linguaggio senz’altro non abitudinario, non consunto, che si oppone in modo netto alla notizia confezionata e ridotta in pillole (l’inflazionato short message). Letteratura e vita, dunque, secondo l’insegnamento di un riferimento insostituibile come Carlo Bo, per cui la letteratura, ad un certo punto, è stata tutta la sua vita. La sopravvivenza, fisica e morale di ciò che costituisce il fattore umano, traccia la magna quaestio del presente e del futuro odierni, comprendendo un’osservazione nello specchio della memoria affidata al sentimento del tempo. “Il problema drammatico della civiltà che si affaccia con il nuovo secolo sta nel ritrovare le ragioni ultime che consentano una vita motivata, interrogativa, che tengano conto delle cose visibili, ma anche e soprattutto di quelle invisibili, che esistono in una ciclica ripetizione”, scrive Moscè. Solo gli archetipi della letteratura incarnano un’immagine completa, una concezione grandiosa dell’esistenza come l’ha programmata Dante, che faceva i conti con gesti e situazioni allegoriche. In ogni storia esiste una tensione conoscitiva e certamente l’uomo non può smettere di attraversarla proprio come in un cammino dantesco, in una durata senza un tempo cronometrico, in uno spettro ampio di soluzioni, nello specifico creative e interpretative. “Sono i valori totali che si ergono al di sopra del contingente a segnare le migliori intenzioni della letteratura. Non è mai una potenza fantastica e innaturale a prevalere, ma una condizione che si butta a capofitto sulle ragioni assolute che conchiudono una linea di forza”, annota ancora Alessandro Moscè.
Alessandro Canzian
Alcuni estratti:
Emanuele Trevi e la cicatrice di un incontro
Qualcosa di scritto (Ponte alle Grazie 2012) di Emanuele Trevi è un libro anomalo, un corpo a corpo tra parole e persone di ieri e di oggi. Siamo a Roma nei primi anni Novanta. Il secolo breve sta finendo e la profezia pasoliniana della civiltà dei consumi come strumento fascista di potere e di consenso, giunge al suo culmine. Uno scrittore trentenne, ingenuo, sbadato, ma appassionato e acuto, trova lavoro in un archivio, il Fondo Pier Paolo Pasolini. In uno stabile del quartiere Prati regna la bisbetica e intrattabile Laura Betti, folle eroina ed erede spirituale dello scrittore. La donna sembra custodire non solo l’opera e l’anelito di Pasolini, ma l’ombra stessa, se non addirittura la presenza inquietante dell’uomo. Qualcosa di scritto racconta il contagio, la persuasione, il fascino di Pasolini, diventato una figura mitologica, e il congedo da un’esistenza spensierata, vagabonda per chi lo studia. Scrive Trevi: “Sono rarissimi gli incontri che davvero, come si dice, lasciano un segno. Parlo di un segno indelebile – più una cicatrice o anche un’amputazione che un sistema di ricordi. La maggior parte delle persone che incontriamo, è triste dirlo, non determina in noi nessuna reazione profonda, meno che mai un cambiamento anche minimo. Saremmo perfettamente gli stessi senza averle mai conosciute. Ma questa deprimente regola non fa che rendere l’eccezione più pericolosa. Ci sono pur sempre degli individui che svolgono nella vita dei loro simili un ruolo che non saprei definire meglio che catastrofico”. Un libro, dunque, su Pasolini, ma anche la storia di uno scrittore che diventerà la vittima preferita di Laura Betti mentre è intento a selezionare materiale per un saggio. Una donna insopportabile perpetua un periodo di soprusi, insulti, denigrazioni. Ma il giovane, sopportando, può farsi un’idea su chi fosse veramente Pasolini, sul lascito testamentario di Petrolio, sui suoi misteri, sulla doppiezza della sua scrittura, sui significati nascosti che racchiude. Qualcosa di scritto segue un percorso saggistico e narrativo, un’epica personale nonché dei soggetti coinvolti nel libro, ben oltre “la possibilità dei singoli”. Trevi accosta, capitolo per capitolo, una serie di immagini su cui ritorna, lasciando al lettore il compito di rintracciare le corrispondenze. Racconta l’amore, un ignoto sentimento, i luoghi dell’io, il malessere e l’ossessione, l’intreccio di conoscenza e il dolore che coinvolsero Pasolini e chi si riconosceva in lui, chi lo amava totalmente rimanendo immerso nella foschia delle sue parole e dei suoi gesti. Qualcosa di scritto è rito, è psicoanalisi, è interpretazione. Un libro complesso, denso, detentore di una varietà di tematiche mai dispersive e irrelate. Del Resto Petrolio stesso consiste in una serie di lacerti, in un vasto campionario umano, in un’esplorazione della sessualità e in un’indagine sui complotti di potere, di rimando in rimando, capitolo per capitolo. In un certo senso Emanuele Trevi ne perpetua l’enigma. Un uomo è in una certa maniera e alla fine della lettura dimostra di aver subito un influsso che l’ha contagiato. Questo testo basta a se stesso, come fosse una stella polare che illumina la strada più impervia. Ogni punto temporale si traduce in una prova da rischiare, in una tensione mai astraente. Qualcosa di scritto, appunto, qualcosa che tocca nel profondo. “I problemi non si risolvono, si vivono”, ammoniva Pasolini, che negli insegnamenti impartiva il convincimento a non temere la sacralità e i sentimenti, discostandosi dagli adoratori di feticci.
(2012)
La poesia orfica di Milo De Angelis
Milo De Angelis è oggi un poeta di culto, specie tra le nuove generazioni, per la capacità di focalizzare come un vero e proprio annuncio lo spirito del tempo di un’età giovanile prolungata. L’esperienza di questo tempo emotivo e formativo si diffonde in un magistero dove il reale, la lingua poetica e la spinta dell’inconscio captano un’inventiva originale e un modello falsamente ritenuto post-ermetico. In realtà siamo di fronte ad una voce dirompente, singolare, continuamente nuova. De Angelis ha esordito con Somiglianze nel 1976 (Guanda), suscitando un dibattito favorevole. Non c’è dubbio che questa raccolta ebbe una duplice importanza e un’eco come pochi altri testi poetici di quel periodo: da un lato De Angelis riscopriva un’estrazione simbolista, dall’altro si insinuava nella forza dei luoghi, nell’oggettività delle cose. Una certa astrazione non si sfilacciava in labirintici meandri, ma rimaneva confinata nella fisicità. Il dato è abbastanza sorprendente, perché se i postulati dell’avanguardia erano stati respinti, il verso non risultava troppo aderente alla tradizione italiana, pur riscoprendo raccordi interiori e ispirazioni universali, tra il non conosciuto e l’inconscio, in segnali epifanici aperti ad orizzonti immaginifici, oltre il sensibile tatto [“È venuta in mente (ma per caso, per l’odore / di alcool e le bende) / questo darsi da fare premuroso / nonostante. / E ancora, davanti a tutti, si sceglieva / tra le azioni e il loro senso”]. Al poeta interessano gli “esistenti” nella necessità di comunicare e di razionalizzare. E l’incontro avviene nell’oggettività dell’accadimento, nella verità individuale della persona, nel suo verbo, nella sua emotività (“Presa la vita, rallentato il tempo / con i gesti, tutto concordava: / cercavamo una fraternità / nell’ombra, dove l’esperienza non separa”). I visi sono delineati, chiamati a farsi vedere. Il magma dell’inconscio si fonde con la chiarezza dell’immagine. Dall’orfismo all’intuizione di un adesso, i vasi comunicanti si misurano nella prospettiva di una dimostrazione completa, parola per parola. Si pensi, a tal proposito, a versi che provengono da un pre-pensiero, ma che trovano una rispondenza nel fatto specifico: “Anche la faccia, al risveglio / ogni volta, panico e ansia / di diventare diversa”. Si infittiscono le trame tra le strade, gli studenti, i semafori: ma in mezzo alle cose svetta il tempo che passa e nessuno recita una parte irrinunciabile, determinante. La coscienza infelice entra in ballo nell’azione, in una prova, in un dialogo, nell’indugio dell’uomo che vuole esserci, che grida il suo male, che vince la sua ritrosia. I piani della conoscenza (Cucchi) sono spostati e anche l’esempio dei poeti maledetti non è così lontano, in una risposta alla vita metallica, piena di rigurgiti, misteriosamente scoppiettante di destini di gente che dice, che si lamenta, che si dibatte, che non demorde. Biografia sommaria (Mondadori 1999) è l’altra capitale raccolta dove vengono ripresi molti dei toni e delle sfumature della raccolta d’esordio e dove appare una risalita della quiete primordiale, però unita a uno stato più riflessivo e meno complesso. Una certa accettazione della realtà si lega all’oggetto definito, oltre che a una densità di pensiero. Si scioglie il nodo di questioni esistenziali che erano rimaste volutamente nebulose, inglobate in rigagnoli dispersi. Il “pendio della memoria” ridà una saldezza alle stesse fotografie augurali, alle corse infantili, ad azioni che si accavallano, addolcendo però lo stato d’animo che le genera e il sapore di alcuni versi tra i più riusciti, ci sembra, di tutta la poetica di De Angelis. Le considerazioni e le apprensioni sul tempo vibrano squillanti (“Vita che è solo vita / e non ci lascia prima di comprendere / e batte sui segnatempo, sull’inverno / intuito dalla scorsa mente. I camion / restano lì, spirituali. Ora una città / ci aziona il respiro”). Questi camion “spirituali” sono la dimostrazione di un silenzio che chiama le cose, di occhi che cercano frontalmente di fermare il silenzio. La musicalità del verso viene da una parabola esistenziale, si eleva dalle macerie, da un sangue raggrumato. La magia di Milo De Angelis coglie il “semprevivo” della notte, dell’uomo che non molla, che entra nella cronaca (“Nel capogiro delle tangenziali / donne ancora felici portavano le lenticchie / a capodanno: era l’alba, / l’alba di ogni sostanza e ti disse / solamente non puoi, non puoi morire / l’insanguinata che entrò nella tua stanza”). Si instaura un braccio di ferro con la morte arginata nel vuoto esistenziale. La vertigine di Biografia sommaria enfatizza la presa diretta della quotidianità, nient’altro che la poesia della vita (“come un compito della sostanza / come un tutto senza notte / chiedevo di scendere / come due città, potenti sotto la pioggia, / scambiano una vita con un’altra vita”).
(2004)
Francesco Scarabicchi e la poesia domestica
Non è così segreta la poesia di Francesco Scarabicchi, il quale, parafrasando Pier Paolo Pasolini, potrebbe individuare la sua opera completa con un verso: “Cerco nel mio cuore, solo ciò che ha”. Viene fissata la verità di alcuni momenti irripetibili, nuclei fondanti, esistenziali, come la perdita e l’invasione del passato nel presente. L’ora felice (Donzelli 2010) ne è un’ulteriore testimonianza, laddove emerge la condizione residenziale di esilio interiore, oltre che fisico e perfino geografico. Il dialogo che Scarabicchi instaura è un colloquio muto senza soluzione di continuità. Si afferma con forza la poetica dello sparire, dello spegnersi, di ciò che finisce e non tornerà più. Tutto va avanti senza di noi e spesso emerge nella tragedia di chi ci lascia, specialmente se si attraversano le rive della malinconia, se si accende la luce umana del ricordo. Un viaggio di formazione in definitiva, un destino e un disegno di paesi, stagioni, persone, oggetti. Viene combinata l’ambivalenza della rastremazione formale, come ha suggerito Pier Vincenzo Mengaldo nella nota introduttiva a Il cancello (PeQuod 2001), ad un presente ridotto, scartato, composto come una sorta di epistolario in versi che conferma la cifra linguistica di Scarabicchi, il quale persegue l’utopia di una parola che dice il necessario negli interstizi del tempo (“Tutto il tempo del tempo non è niente, / età che si dissolvono, declini, / luci che vanno dov’è sempre sera, / anime abbandonate dalle cose, / sedili da Levante, tende, vele, / libri tradotti in polvere, missive”). Scarabicchi fornisce sempre una visuale sul perché si è optato per una precisa testimonianza. Non colloca schematicamente, ma conosce e ricerca i fini. Poesia e vita, poesia ed esperienza, poesia e reale: questo ci sembra un dato più che mai recuperato. L’ora felice è insita nel tempo, dunque, rappresentato in un soliloquio che si genera dal luogo, in quel luogo e non altrove, come avviene nell’opera di Ferruccio Benzoni, poeta molto affine alle stesse tematiche. Il verso difende l’uomo in una nevrosi del privato, in un microcosmo suggestivo di una realtà locale che ha rappresentato una parte determinante, se non decisiva, della poesia italiana del secondo Novecento. Viene da pensare a quella terza linea, dopo il grande stile e l’avanguardia, e all’esperienza della terza generazione, che è l’asse portante di una lunga vicenda al centro del dibattito secolare. Si pensi alla poesia onesta di Saba, con un accento classico e autobiografico, che si radica sugli affetti personali e che per molti poeti di oggi rimane un caposaldo. Scrive Francesco Scarabicchi: “Sono quest’ora ferma dentro gli anni / a consolare chi non si consola, / a togliere la gioia dov’è il sogno. / Scrivo parole che non serviranno, / musiche che nessuno può ascoltare, / piccole barche che mi lasceranno, / baci per bocche che non so baciare, / passi che t’avvicinano e non sanno”. La nudità di questa esperienza è nella sobrietà di un rapporto con le cose come lo era per il maestro Franco Scataglini, ormai un classico, con lo spirito che dialoga con le persone scomparse. L’evocazione si staglia nell’orizzonte marino, anconetano, nell’immagine inquadrata en plein air o, molto più spesso, dentro una casa, tra pareti domestiche. E’ lo spazio chiuso la difesa umana, la parabola dell’esistere. L’ambiente più amato si situa nella vibrazione di un afflato personale o in un’eclissi dove tutto sembra precario e instabile e dove ci si accorge che il miracolo sta nella partecipazione, nel rendere conosciuta un’istanza, una volontà (“Passa anche di qua la nostra vita, / all’insaputa buia del lungomare, / nell’onda d’ogni brivido, nel sangue / di un gesto tuo che sceglie di fermarsi / dove il mio sguardo arreso ti pronuncia”).
(2010)
Pier Luigi Cappello e l’imperatore del terzo millennio
L’imperatore di Pier Luigi Cappello potrebbe essere un sindaco, un governatore di regione, lo stesso presidente del consiglio. Oppure un uomo che esercita un dominio in qualunque posto del mondo, compresa questa Italia ferita del nuovo millennio, politicamente allo sbando. La poesia del giovane friulano non ha, però alcuna dimensione civile, né tanto sociologica. Si tratta, viceversa, di versi che accomunano le cose che non si notano e gli stessi archetipi della letteratura: vita, morte, dolore, redenzione, memoria. Mandate a dire all’imperatore (Crocetti 2010) è un bel libro innanzitutto perché, Cappello, come nota Eraldo Affinati nella post-fazione, è un poeta nuovo che conosce e sa descrivere quella solitudine scalfita dalla debolissima luce del tremolante canzoniere amoroso, parafrasando un verso. Il poeta si rivolge ad un padre d’amore che non c’è più, e ne sente lo stimolo impulsivo al dialogo, più che la nostalgia di rivederlo, di abbracciarlo. Questa poesia instaura un confronto che raccoglie l’aria di tutte le albe del mondo, per rifarci ad un altro verso, perché si vuole testimoniare una rinascita giornaliera fatta di piccole cose, in cui il ricordo è sponda momentanea, passaggio da un giorno all’altro. “Ieri sono passato a trovarti, papà, / la luce in questi giorni non è tagliata dall’ombra / negli alberi senza vento c’è l’odore secco dell’aria…”. Cappello racconta, annota, scandaglia l’esistenza fino alle ragioni più intime e totali. Lo fa con una capacità artigianale di costruzione del verso e con una folgorazione ragionata, come quando scrive: “Domani anche qui saremo in mezzo alle foglioline / si può dire la marea si può fermare / ma nessuno è capace di arrestarla / e noi si vive dentro questi metri crudi / e il vivere è portarne la scomparsa, / un giorno alla volta portarne il nome”. Cappello diffonde una poesia dura, non in quanto priva della tenerezza di un sentimento, ma perché non si lascia mai andare a lamentele retoriche. Il suo sguardo è doloroso, lucido, illuminato da una costellazione, da un moto che porta con sé il ciclo della vita anche dopo la vita: “Dal desiderarti al pensarti mia / sei rimasta tu, mentre entri e ti siedi”. Oppure: “Scrivere come sai dimenticare, / scrivere e dimenticare. // Tenere un mondo intero sul palmo / e dopo soffiare”. I colori consueti, come il grigio delle pietre e il verde immenso della pergola, sconfinano in una profonda libertà, che è quella di chi indica la linea d’orizzonte dalla propria postazione, un sistema di valori inamovibile. Lo stesso sistema del tempo non è mai rinnegato, ma accolto con dedizione. E con esso le vicende personali, anche le più dolorose. La densità affettiva di Cappello non è ripiegata su se stessa, ma appare appunto un’offerta sovrasensibile, come ogni rito iniziatico, come ogni consapevolezza del proprio esserci. La libertà, per Pierluigi Cappello, rimane la visione di una frontiera impalpabile nei luoghi del suo Friuli non così pacificati nel silenzio mortale dei monti e dei boschi, nel rumore del vento come un ritmo musicale, da sottofondo. Le parole hanno corpo, spuntano nell’orizzonte conoscitivo al quale si alludeva, fino a rivelarlo del tutto. La grazia della poesia è un dettato che fuoriesce dai canoni della società e si affida ad una timida speranza di riconciliazione per una voce lieve, ma profonda, incisiva. Il titolo stesso, Mandate a dire all’imperatore, non è altro che una provocazione, un’esortazione ad una condotta diversa, che sappia guardare al passato e non solo ad un eterno, fatuo presente, alla generazione dei padri e dei nonni, ad una determinazione del tempo degli affetti sedimentata nei sapori e negli odori, nelle cose per come le percepiamo personalmente e non per come accadono meccanicamente.
(2010)
Visibile e visionario di Giovanna Rosadini
Giovanna Rosadini è una poetessa che scivola incessantemente dal visibile al visionario della quotidianità, specie nella raccolta di versi dal titolo Il numero completo dei giorni (Aragno 2014). “Un vuoto dentro ad altro vuoto”, al quale allude uno dei versi iniziali, fa presentire l’intento di riesumare la memoria come una “membrana sbiadita”. Le espressioni sono ricordi a sprazzi, redimenti, scrive Davide Brullo nell’introduzione, dove non mancano i colori soffici, le descrizioni dettagliate affinché non si disperda la memoria, quasi fosse stratificata in una roccia millenaria. Non si scova una poesia dell’io, ma una collocazione di tanti io e noi riannodati dal filo di più esistenze presenti, passate e future: “Saremo noi se ci sapremo riconoscere, / la terra promessa”. Oppure: “ Sentiamo la discesa / nella gola, a onde totalmente affidati / a un istinto di riconoscimento: ed ecco / questa nebbia, è casa…”. La stagione di un qualunque tempo cronologico, dunque, è affiancata da un cammino della coscienza interiore, come se i due mondi fossero perfettamente paralleli, scanditi e decisi da uno stesso destino, da un approdo, da un nuovo inizio e così via. Ogni affermazione palesa una rivelazione nella frequenza netta della parola: “Dare un corpo alle parole, toglierle / dalla notte impalpabile e affamata / d’aria, che abbiano peso, che sudino / come organismi maturi…”. Rosadini scrive delle “benedizione del primogenito”, di una promessa del cuore, di linfa e sangue, del suo essere madre. Riemergono cicatrici del passato, “rilievo della superficie” o “memoria dell’ustione”. Il passo di questi versi si allunga in un divagare verso la parte più segreta dell’esistenza. In Anno sabbatico, uno dei migliori testi, la meta sfugge, eppure è a portata di mano quella dualità tempo/coscienza: “Come fossi qui, agguanto nebbia / ripiego i margini del campo incolto / cielo attraversato da una sola nota // ma piove sottile nella città rischiarata…”. Le immagini rimangono sospese dentro la vita, mai in un’ipotetica morte o in un sogno enigmatico. La vicenda esistenziale di Giovanna Rosadini è un catalogo, un calendario, un block notes dove distillare la lingua e dove ritrovare il fondo delle cose. Tra percorsi di donna, identità personale ed emblemi che sono di tutti, questa poesia dialoga con un’endogena percezione, in una sorta di zona franca che induce i corpi a non riconoscersi nell’interfaccia visibile/visionario. “Indossi un viso senza tempo indefinitivamente / modellato dalla luce opaca, risvegliato / a una vuota e inconsapevole fissità. Racchiudi / intere geografie, e storie di suoni dislocati / lungo pianure di cielo. Risarciscimi”. E’ questo “risarciscimi” che la dice lunga sullo slancio verso l’altro, sulla purezza espressa in un tono confessionale, composto, dignitoso, di chi custodisce un’aurea di grazia. Umano e amore si incontrano, saldano armonia e dolcezza. Negli epigrammi dell’ultima sezione Giovanna Rosadini condensa certezze e dubbi, sempre interpellando un’indefinita presenza, laica e religiosa insieme, illimitata: “Chi sei tu per spiccare questa vita? Forse i miei giorni sono la semina della vita celeste, o le ossa che getti ai tuoi angeli dal volto di cane. Prego che non esista la vita eterna, che tutto, tutto, anche l’amore e l’amarti abbiano un termine, la fine”. Un’esperienza necessaria, passata sotto una luce fosforescente, ineludibile, dove la nettezza del dialogo apre un parlatoio radunando voci multiple, un diario intimo, ripercorrendo giorni e giorni di meditazione.
(2014)
Derek Walcott e l’eco del mare
Derek Walcott, poeta e scrittore santaluciano, nel 1992 insignito del Nobel per la Letteratura, è conosciuto per aver eletto la sua terra natale come habitat naturale di un’opera pregna di visionarietà e di rimandi escatologici, sorgente di vita nella consapevolezza, sofferta, di popoli, culture, storie. Per dirla con Iosif Brodskij “i suoi versi pulsanti e inesorabili sono arrivati nella lingua inglese come onde di marea, coagulandosi in un arcipelago di poesie senza il quale la mappa della letteratura moderna assomiglierebbe, di fatto, a una carta da parati”. Walcott (che ama molto la tradizione latina, classica, che adora Lucrezio e Dante) opta per una parola invocante, per una solenne simbologia che privilegia lo stupore della bellezza e il destino umano in un percorso da meandro dantesco, che si affaccia nell’aldilà attraverso la sabbia nera che costeggia il mare tra un’immensa varietà di piante e una curiosa fauna tropicale. Omeros (Adelphi 2003) racconta l’avventura di due pescatori, Ettore e Achille, innamorati della stessa donna, Elena, sensuale cameriera di un hotel di Santa Lucia, questa piccola isola sovrastata da due coni vulcanici, al centro del Mar dei Caraibi. In ogni verso si configura il profilo dei luoghi come delle specie animali e vegetali, lo sguardo di una memoria storica, un’offerta lirica nell’impersonalità dell’epica. Per un caraibico il tema chiave del sentimento risiede nella schiavitù degli avi. Walcott ha un volto africano, vicino e lontano, umanissimo e inquieto. Parafrasando dei versi, le cose che guarda non esplodono, sbiadiscono, svaniscono, come il sole dalla pelle, come la spuma dalla riva, come il lampo fulmineo d’amore che non finisce in un tuono. Il tono della poesia è di un esiliato, ma anche di chi ha ereditato la dura occupazione francese, spagnola, inglese. La condizione in cui Walcott dice di trovarsi è quella dell’innocenza, che non è naturalmente ignoranza. E dalla lettura dei fatti, dei processi storici e della meravigliosa natura, fiorisce la poesia. I suoi libri condensano forme, lezioni, esempi. Walcott abita il passato intrecciando una vocazione al senso del luogo, appunto storico e contemplativo insieme, che si salda nell’orizzontalità del mare caraibico, in una descrizione minuta, in un paesaggio familiare dove oggi arrivano due navi da crociera al giorno. Omeros è un poema dedicato specie al navigante nel mare che ha coraggio, forza, che tiene in pugno una sorte terrena e cosmica. L’eco viene dal sogno di un infinito, da una tregua, ma anche dal peso del dolore, dalla speranza di un equilibrio nei territori di casa perché rimanga il simbolo, finalmente, di una terra-madre che illumina le colline fortificate. Da Omeros: “Era questa la luce in cui Achille era più felice. Quando, / prima che le mani afferrassero le falche, stava per farsi / penetrare dall’immensità del mare, sentendo il giorno all’inizio”. E sarà la natura a sorreggere l’uomo: in riva al mare, tra i ligustri e gli aironi, tra l’azzurro intenso della piana d’acqua, nella rigenerazione di uno spazio, nel crocevia di un’esperienza sedimentata nel tempo, nella sintonia con l’universo più che con gli uomini, nel frammento di luce, nel clima secco originato da un sole avvolgente, da una vegetazione ospitale, a volte foresta, a volte giardino. Derek Walcott ha una sensibilità tattile che in Omeros si fa pastosa, concreta, fotografica. Un piccolo, grande mondo si schiude come i grandi occhi del poeta che guardano dappertutto, che ruotano, che slittano fino ad un’epoca mitologica ripensata per i nostri giorni in quasi ottomila versi, con metriche e rime, in inglese, detonanti e concitate.
(2008)
Indice del volume:
Fuori pagina (critica, narrativa, poesia) – La riscoperta dell’anarchico celeste Luigi Bartolini; Pier Paolo Pasolini: l’eretico senza tempo; Alberto Moravia e la nostalgia del malato; Il male d’esistere per Enzo Siciliano; L’utopia di Paolo Volponi nel terzo millennio; Ezio Raimondi e un atto d’amore; Franco Cordelli: il romanzo e la mortificazione; Franco Brevini: la letteratura è ancora possibile; Alfonso Beradinelli e il rifiuto del fondamentalismo; Paolo Lagazzi e la dimostra di Bertolucci; Raffaele Manica e la riflessione aggiunta; Massimo Onofri: il critico è Socrate; Massimo Raffaeli: la critica militante e postdatata; Giuseppe Giglio: il binomio scrittore-lettore; L’infanzia del mondo di Tonino Guerra; L’aldilà dantesco di Federico Fellini; Pier Vittorio Tondelli e la fauna artistica; L’ultimo sentimento di Alberto Bevilacqua; Le case che crollano di Gianni Celati; Il Vaticano di Roberto Pazzi; Claudio Piersanti e l’occhio vigile sulla coppia; Il memoriale di Edoardo Albinati; Fulvio Ervas e il viaggio che vale una vita; Sandro Veronesi e una solitudine sobillata; Susanna Tamaro e la reazione al dolore; Davide Barilli e l’oralità tra il Po e Cuba; Mauro Covavich e una prosa sincopata; I picchettini di Angelo Ferracuti; Paolo Del Colle e la nausea dei sensi; Franco Arminio e il viaggio nel meridione; Emanuele Trevi e la cicatrice di un incontro; Il fondale epico di Guido Conti; Ugo Cornia e le ipotesi assurde della narrativa; Giuseppe Genna e l’uomo del delirio; Andrea Di Consoli e la valle ombra; Niccolò Ammaniti e il ragazzo che cresce; Donatella Di Pietrantonio e la saga familiare; Italo Mancini testimone dell’eterno; Wojtyla: il santo che fu poeta; Il cristianesimo di Mario Luzi; Umberto Piersanti: tempi e luoghi del Montefeltro; Maurizio Cucchi: un secondo e un secolo; La poesia orfica di Milo De Angelis; Remo Pagnanelli e una seconda vita; Paolo Ruffilli e le verità comuni; Francesco Scarabicchi e la poesia domestica; Il tempo straniero di Giancarlo Pontiggia; La percettibilità di Valerio Magrelli; Davide Rondoni e un verso di fuochi; Pierluigi Cappello e l’imperatore del terzo millennio; Visibile e visionario di Giovanna Rosadini.
Cocktail d’autore (interviste) – Felice Piemontese e la modernità degradata; Alberto Bertoni e i tramandi poetici; Bianca Garavelli e Dante nel Duemila; Raffaele La Capria e l’infelicità italiana; La versatilità di Raffaele Crovi; Dacia Maraini e un lungo viaggio; Pupi Avati e la grande invenzione; Arnaldo Colasanti e l’amore che non muore; Carlo D’Amicis e l’inganno televisivo; Adonis e l’immanenza dell’uomo; Alda Merini e l’assoluzione della poesia; Claudio Damiani tra silenzio e natura.
Cronaca e critica (appunti quotidiani) – La riconoscibilità salvifica di Pier Paolo Pasolini; Cesare Garboli critico simmetrico; Pietro Citati: la morte e l’indifferenza; Marc Augé: spazio e mondo globale; Filippo La Porta e le città italiane; Alberto Moravia e la fantasessualità; Giorgio Saviane voleva parlare con Dio; Pier Vittorio Tondelli e l’epica dell’eros; Vincenzo Cerami e la preghiera davanti alla pietra; Alberto Bevilacqua: l’arlìa di una terra di nebbia; Philippe Forest: la morte che ci accomuna; La morte senza un fine di David Grossman; Tahar Ben Jelloun: mescolarsi tra la gente; Claudio Magris: il viaggio e le identità; Ermanno Cavazzoni e la scissione umana; La doppiezza e il sosia di Roberto Pazzi; Le passeggiate e le isole di Marco Lodoli; Silvia Ballestra e la rivolta della rotonda; Mario Desiati e il sogno della fuga; Giacomo Leopardi: il giovane favoloso nell’infinito; Alfonso Gatto e la macchina del tempo; Mario Luzi e il soffio dell’estate; Amelia Rosselli e un cortocircuito fluttuante; Foga e disperazione di Dario Bellezza; Ives Bonnefoy e le parole della veglia; Il tumulto immobile di Seamus Heaney; Ancona e lo scoglio di Franco Scataglini; Remo Pagnanelli e il metasogno di Macerata; I morti e i vivi di Giovanni Raboni; Derek Walcott e l’eco della mare; Umberto Piersanti e la mitografia personale; Valentino Zeichen: l’elegante neomarziale.
